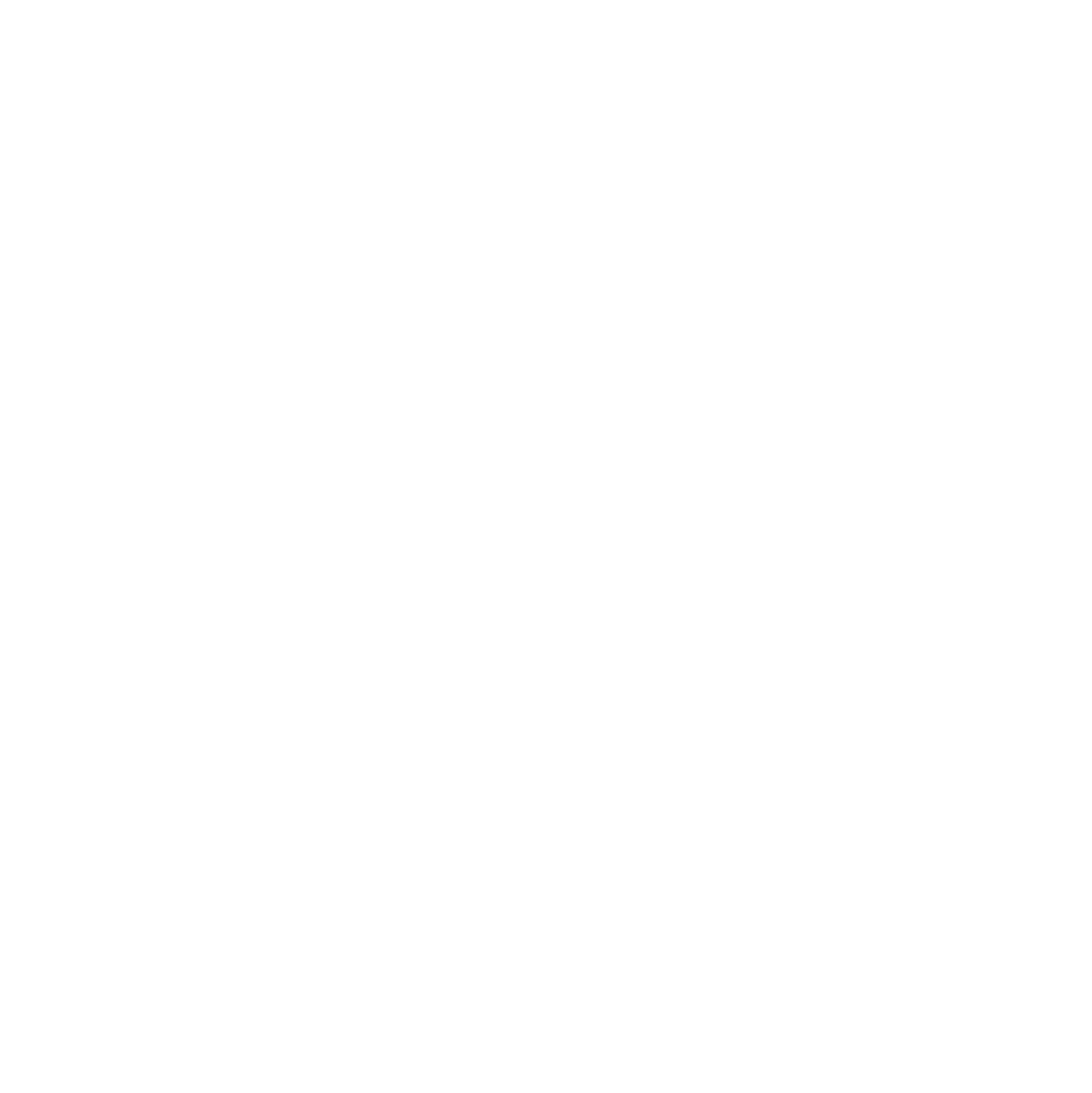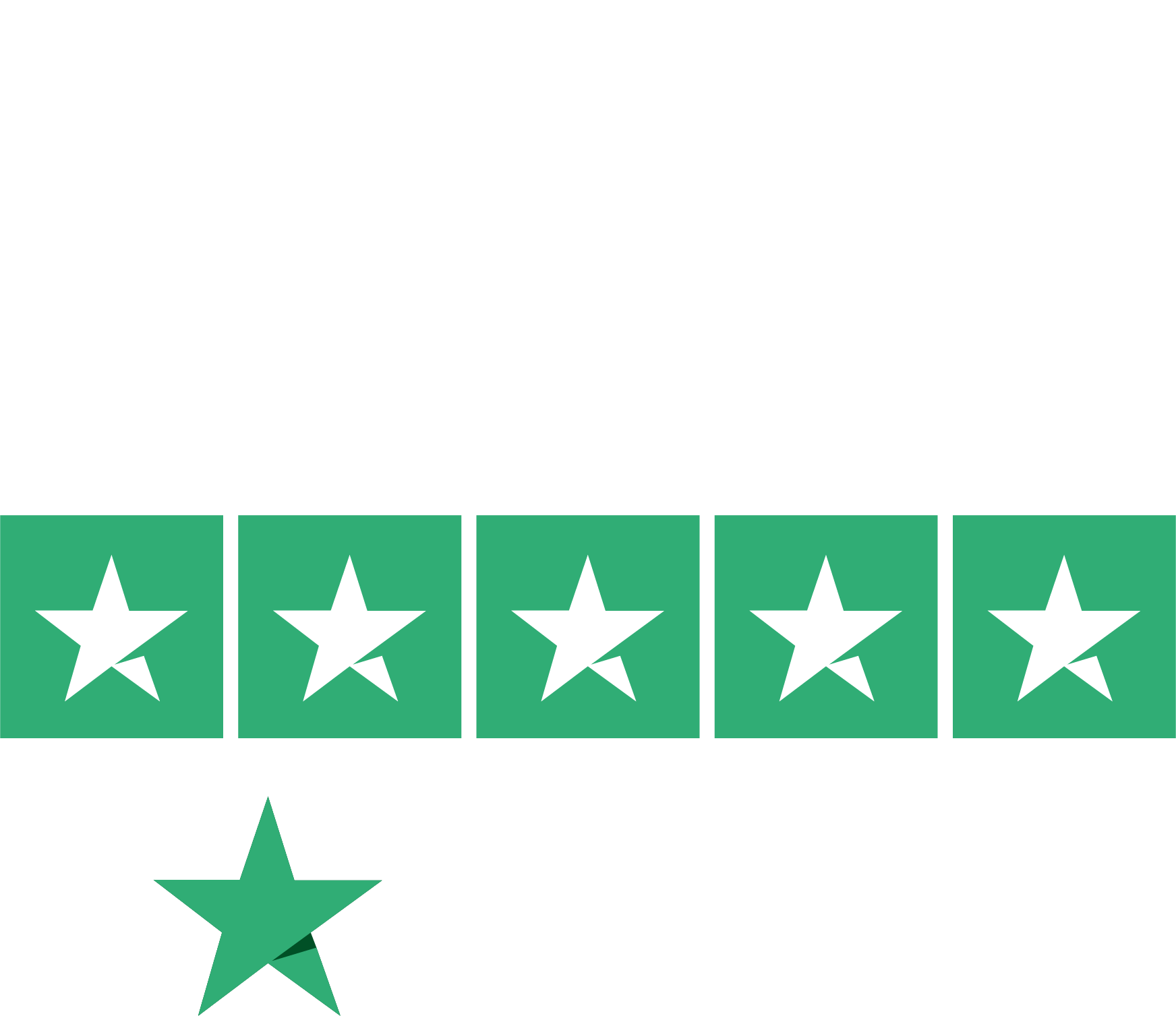Titolo universitario
La più grande facoltà di scienze motorie del mondo"
Presentazione
Questo programma genererà un senso di sicurezza nello svolgimento della pratica quotidiana dello specialista in Scienze Motorie, che lo aiuterà a crescere personalmente e professionalmente"

L'uso dei campi elettromagnetici come strumento terapeutico è stato utilizzato fin dall'antichità, ma è dalla fine del secolo scorso che ha conosciuto un grande progresso. Questo progresso è andato di pari passo con la conoscenza sempre più approfondita della fisiologia umana, che ha facilitato la progettazione e lo sviluppo di diversi tipi di trattamenti basati sull'applicazione dei campi elettromagnetici.
Il campo di applicazione dell'elettroterapia è molto vasto, per cui è necessario avere una conoscenza approfondita sia del funzionamento fisiologico del soggetto che dell'agente più appropriato in ogni caso. Queste conoscenze spaziano dai meccanismi di contrazione muscolare ai meccanismi di trasmissione somatosensoriale, il che rende essenziale per il professionista di Scienze Motorie conoscere sia i meccanismi fisiopatologici del soggetto sia le basi fisico-chimiche dell'elettroterapia.
Negli ultimi anni è cresciuto il numero di studi di ricerca relativi all'elettroterapia, soprattutto quelli incentrati su tecniche invasive. Queste includono tecniche analgesiche percutanee, in cui gli aghi vengono utilizzati come elettrodi, nonché la stimolazione transcranica, sia di natura elettrica che attraverso l'uso di campi magnetici. Sulla base di queste ultime applicazioni, il campo d'azione dell'elettroterapia si sta ampliando e può essere applicato a diverse tipologie di popolazione, dai soggetti con dolore cronico ai pazienti neurologici.
L'obiettivo delMaster privato inElettroterapia nell'Attività Fisica e nello Sportt è quello di fornire una presentazione aggiornata delle applicazioni dell'elettroterapia nelle patologie neuromuscoloscheletriche, basandosi sempre sull'evidenza scientifica nella scelta del tipo di corrente più appropriato per ogni caso. A tal fine, le basi neurofisiologiche sono sempre presentate all'inizio di ogni modulo, in modo che l'apprendimento sia completo. Ogni modulo è supportato da applicazioni pratiche di ogni tipo di corrente, in modo che l'integrazione della conoscenza della patologia e del suo trattamento sia completa.
Immergiti nello studio di questo Master privato di alto livello e migliora le tue competenze come professionista delle scienze dello sport"
Questo Master privato inElettroterapia nell'Attività Fisica e nello Sportt possiede il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Sviluppo di oltre 75 casi di studio presentati da esperti di elettroterapia
- Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per l’esercizio della professione
- Novità relative al ruolo del professionista di scienze motorie nell'applicazione dell'elettroterapia
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- Sistema di apprendimento interattivo basato su algoritmi per prendere decisioni su situazioni date
- Accento sulle metodologie di ricerca sull'elettroterapia applicata alle Scienze Motorie
- Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o portatile provvisto di connessione internet
QuestoMaster privato è il miglior investimento che tu possa fare nella scelta di un programma di aggiornamento per due motivi: oltre a rinnovare le tue conoscenze in Elettroterapia, otterrai una qualifica rilasciata da TECH Università Tecnologica”
Il suo personale docente comprende professionisti del settore della scienza dello sport, che apportano l'esperienza del loro lavoro a questa formazione, oltre a specialisti riconosciuti provenienti da società di riferimento e università prestigiose.
Contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso. A tal fine, il professionista sarà assistito da un innovativo sistema video interattivo creato da esperti riconosciuti ed esperti di elettroterapia nell'attività fisica e nello sport.
IlMaster privato permette di esercitarsi con simulazioni che forniscono un apprendimento programmato per prepararsi di fronte a situazioni reali"

QuestoMaster privato 100% online ti permetterà di combinare i tuoi studi con il tuo lavoro professionale, aumentando le tue conoscenze in questo campo"
Programma
La struttura dei contenuti è stata progettata da un gruppo di professionisti provenienti dai migliori centri e università della Spagna, consapevoli della rilevanza della formazione attuale per poter intervenire in situazioni che richiedono l'uso dell'elettroterapia, e impegnati in un insegnamento di qualità attraverso le nuove tecnologie educative.

Disponiamo del programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Desideriamo offrirti la migliore formazione possibile"
Modulo 1. Elettroterapia ad alta frequenza
1.1. Fondamenti fisici dell'alta frequenza
1.1.1. Introduzione
1.1.2. Principi di base
1.2. Effetti fisiologici dell'alta frequenza
1.2.1. Effetti termici
1.2.2. Effetti termici
1.3. Effetti terapeutici dell'alta frequenza
1.3.1. Effetti termici
1.3.2. Effetti termici
1.4. Fondamenti delle onde corte
1.4.1. Onde corte: Modalità di applicazione capacitiva
1.4.2. Onde corte: Modalità di applicazione induttiva
1.4.3 Onde corte: Modalità di emissione pulsata
1.5. Applicazioni pratiche delle onde corte
1.5.1. Applicazioni pratiche delle onde corte continue
1.5.2. Applicazioni pratiche delle onde corte pulsate
1.5.3. Applicazioni pratiche delle onde corte: Fase patologica e protocolli
1.6. Controindicazioni alle onde corte
1.6.1. Controindicazioni assolute
1.6.2. Controindicazioni relative
1.6.3. Precauzioni e misure di sicurezza
1.7. Applicazioni pratiche delle microonde
1.7.1. Nozioni di base sulle microonde
1.7.2. Considerazioni pratiche sulle microonde
1.7.3. Applicazioni pratiche delle microonde in continuo
1.7.4. Applicazioni pratiche delle microonde pulsate
1.7.5. Protocolli di trattamento a microonde
1.8. Controindicazioni alle microonde
1.8.1. Controindicazioni assolute
1.8.2. Controindicazioni relative
1.9. Fondamenti di tecarterapia
1.9.1. Effetti fisiologici della tecarterapia
1.9.2. Dosaggio del trattamento di tecarterapia
1.10. Applicazioni pratiche della tecarterapia
1.10.1. Artrosi
1.10.2. Mialgia
1.10.3. Rottura fibrillare del muscolo
1.10.4. Dolore post-puntura dei trigger point miofasciali
1.10.5. Tendinopatia
1.10.6. Rottura del tendine (periodo post-chirurgico)
1.10.7. Guarigione della ferita
1.10.8. Cicatrici cheloidi
1.10.9. Drenaggio dell'edema
1.10.10. Recupero post-esercizio
1.11. Controindicazioni alla tecarterapia
1.11.1. Controindicazioni assolute
1.11.2. Controindicazioni relative
Modulo 2. Ultrasuonoterapia in fisioterapia
2.1. Principi fisici della terapia a ultrasuoni
2.1.1. Definizione di ultrasuonoterapia
2.1.2. Principali principi fisici dell'ultrasuonoterapia
2.2. Effetti fisiologici dell'ultrasuonoterapia
2.2.1. Meccanismi d'azione degli ultrasuoni terapeutici
2.2.2. Effetti terapeutici dell'ultrasuonoterapia
2.3. Principali parametri della terapia a ultrasuoni
2.3.1. Introduzione
2.3.2. Parametri principali
2.4. Applicazioni pratiche
2.4.1. Metodologia di trattamento con ultrasuoni
2.4.2. Applicazioni pratiche e indicazioni della terapia a ultrasuoni
2.4.3. Studi di ricerca sulla terapia a ultrasuoni
2.5. Ultrasuonoforesi
2.5.1. Definizione di ultrasuonoforesi
2.5.2. Meccanismi dell'ultrasuonoforesi
2.5.3. Fattori che influenzano l'efficacia dell'ultrasuonoforesi
2.5.4. Considerazioni sull'ultrasuonoforesi da tenere in considerazione
2.5.5. Studi di ricerca sull'ultrasuonoforesi
2.6. Controindicazioni alla terapia con ultrasuoni
2.6.1. Controindicazioni assolute
2.6.2. Controindicazioni relative
2.6.3. Precauzioni
2.6.4. Raccomandazioni
2.6.5. Controindicazioni all'ultrasuonoforesi
2.7. Terapia ad ultrasuoni ad alta frequenza. OPAF
2.7.1. Definizione di terapia OPAF
2.7.2. Parametri della terapia OPAF e della terapia HIFU
2.8. Applicazioni pratiche della terapia a ultrasuoni ad alta frequenza
2.8.1. Indicazioni per la terapia OPAF e HIFU
2.8.2. Studi di ricerca sulla terapia OPAF e HIFU
2.9. Controindicazioni alla terapia con ultrasuoni ad alta frequenza
2.9.1. Introduzione
2.9.2. Principali controindicazioni
Modulo 3. Altri campi elettromagnetici
3.1. Il laser Principi fisici
3.1.1. Il laser Definizione
3.1.2. Parametri del laser
3.1.3. Laser. Classificazione
3.1.4. Laser. Principi fisici
3.2. Laser. Effetti fisiologici
3.2.1. Interrelazione tra Laser e Tessuti Viventi
3.2.2. Effetti biologici dei laser a Bassa e Media Potenza
3.2.3. Effetti Diretti dell'Applicazione Laser
3.2.3.1. Effetto Fototermico
3.2.3.2. Effetto Fotochimico
3.2.3.3. Stimolo Fotoelettrico
3.2.4. Effetti Indiretti dell'Applicazione Laser
3.2.4.1. Stimolazione della Microcircolazione
3.2.4.2. Stimolazione del Trofismo e della Riparazione
3.3. Laser. Effetti Terapeutici
3.3.1. Analgesia
3.3.2. Infiammazione ed edema
3.3.3. Riparazione
3.3.4. Dosimetria
3.3.4.1. Dose di Trattamento Raccomandata nell'Applicazione Laser a Basso Livello secondo WALT
3.4. Laser. Applicazioni cliniche
3.4.1. Il laser nell'Osteoartrite
3.4.2. Laser nella Lombo-Sciatalgia Cronica
3.4.3. Laser nell'Epicondilite
3.4.4. Laser nella Tendinopatia della Cuffia dei Rotatori
3.4.5. Laser nel Dolore Cervicale
3.4.6. Laser nei disturbi muscoloscheletrici
3.4.7. Altre applicazioni Pratiche del Laser
3.4.8. Conclusioni
3.5. Laser. Controindicazioni
3.5.1. Precauzioni
3.5.2. Controindicazioni
3.5.2.1. Conclusioni
3.6. Radiazione infrarossa. Principi fisici
3.6.1. Introduzione
3.6.1.1. Definizione
3.6.1.2. Classificazione
3.6.2. Generazione di radiazioni infrarosse
3.6.2.1. Emettitori Luminosi
3.6.2.2. Emettitori non Luminosi
3.6.3. Proprietà fisiche
3.7. Effetti fisiologici degli Infrarossi
3.7.1. Effetti Fisiologici Prodotti sulla Pelle
3.7.2. Infrarossi e Cromofori nei Mitocondri
3.7.3. Assorbimento delle Radiazioni nelle Molecole d'Acqua
3.7.4. Infrarossi nella Membrana Cellulare
3.7.5. Conclusioni
3.8. Effetti terapeutici dei raggi infrarossi
3.8.1. Introduzione
3.8.2. Effetti Locali dei Raggi Infrarossi
3.8.2.1. Eritematoso
3.8.2.2. Antinfiammatorio
3.8.2.3. Cicatrizzazione
3.8.2.4. Sudorazione
3.8.2.5. Rilassamento
3.8.2.6. Analgesia
3.8.3. Effetti Sistemici degli Infrarossi
3.8.3.1. Benefici per il Sistema Cardiovascolare
3.8.3.2. Rilassamento Muscolare Sistemico
3.8.4. Dosimetria e Applicazione dei Raggi Infrarossi
3.8.4.1. Lampade a Infrarossi
3.8.4.2. Lampade non Luminose
3.8.4.3. Lampade Luminose
3.8.4.4. MIRE
3.8.5. Conclusioni
3.9. Applicazioni pratiche
3.9.1. Introduzione
3.9.2. Applicazioni cliniche
3.9.2.1. Artrosi e Radiazione Infrarossa
3.9.2.2. Lombalgia e Radiazione Infrarossa
3.9.2.3. Fibromialgia e Infrarossi
3.9.2.4. Saune a Infrarossi nelle Cardiopatie
3.9.3. Conclusioni
3.10. Controindicazioni dei Raggi Infrarossi
3.10.1. Precauzioni/Effetti Avversi
3.10.1.1. Introduzione
3.10.1.2. Conseguenze di un errato Dosaggio di Infrarossi
3.10.1.3. Precauzioni
3.10.1.4. Controindicazioni Formali
3.10.2. Conclusioni
Modulo 4. Principi generali dell'elettroterapia
4.1. Basi fisiche della corrente elettrica
4.1.1. Brevi cenni storici
4.1.2. Definizione e basi fisiche dell'elettroterapia
4.1.2.1. Concetti di potenziale
4.2. Principali parametri della corrente elettrica
4.2.1. Parallelismo farmacologia/elettroterapia
4.2.2. Principali parametri delle onde: forma d'onda, frequenza, intensità e ampiezza del polso
4.2.3. Altri concetti: tensione, corrente e resistenza
4.3. Classificazione delle correnti in funzione della frequenza
4.3.1. Classificazione in funzione della frequenza: alta, media e bassa.
4.3.2. Proprietà di ciascun tipo di frequenza
4.3.3. Scelta della corrente più adatta in ogni caso
4.4. Classificazione delle correnti in base alla forma d'onda
4.4.1. Classificazione generale: correnti continue e alternate o variabili.
4.4.2. Classificazione delle correnti variabili: correnti interrotte e ininterrotte.
4.4.3. Concetto di spettro
4.5. Trasmissione della corrente: elettrodi
4.5.1. Informazioni generali sugli elettrodi
4.5.2. Importanza dell'impedenza tissutale
4.5.3. Precauzioni generali da tenere in considerazione
4.6. Tipi di elettrodi
4.6.1. Breve richiamo allo sviluppo storico degli elettrodi
4.6.2. Considerazioni sulla manutenzione e sull'uso degli elettrodi
4.6.3. Principali tipi di elettrodi
4.6.4. Applicazione elettroforetica
4.7. Applicazione bipolare
4.7.1. Informazioni generali sull'applicazione bipolare
4.7.2. Dimensioni dell'elettrodo e area da trattare
4.7.3. Applicazione di più di due elettrodi
4.8. Applicazione tetrapolare
4.8.1. Possibilità di combinazioni
4.8.2. Applicazione nell'elettrostimolazione
4.8.3. Applicazione tetrapolare nelle correnti interferenziali
4.8.4. Conclusioni generali
4.9. Importanza dell'alternanza di polarità
4.9.1. Breve introduzione al galvanismo
4.9.2. Rischi derivanti dall'accumulo di cariche
4.9.3. Comportamento polare della radiazione elettromagnetica
Modulo 5. Elettrostimolazione per il rafforzamento muscolare
5.1. Principi della contrazione muscolare
5.1.1. Introduzione alla contrazione muscolare
5.1.2. Tipi di muscoli
5.1.3. Caratteristiche dei muscoli
5.1.4. Funzioni dei muscoli
5.1.5. Elettrostimolazione Neuromuscolare
5.2. Struttura dei sarcomeri
5.2.1. Introduzione
5.2.2. Funzioni del sarcomero
5.2.3. Struttura del sarcomero
5.2.4. Teoria del filamento scorrevole
5.3. Struttura della piastra motore
5.3.1. Concetto di Unità motore
5.3.2. Concetto di giunzione neuromuscolare e placca motoria
5.3.3. Struttura della Giunzione Neuromuscolare
5.3.4. Trasmissione neuromuscolare e contrazione muscolare
5.4. Tipi di contrazione muscolare
5.4.1. Concetto di contrazione muscolare
5.4.2. Tipi di contrazione
5.4.3. Contrazione muscolare isotonica
5.4.4. Contrazione muscolare isometrica
5.4.5. Relazione tra forza e resistenza nelle contrazioni
5.4.6. Contrazioni auxotoniche e isocinetiche
5.5. Tipi di fibre muscolari
5.5.1. Tipi di fibre muscolari
5.5.2. Fibre Lente o Fibre di tipo I
5.5.3. Fibre Veloci o Fibre di Tipo II
5.6. Principali lesioni neuromuscolari
5.6.1. Concetto di Malattia Neuromuscolare
5.6.2. Eziologia delle malattie neuromuscolari
5.6.3. Lesioni e NMD della giunzione neuromuscolare
5.6.4. Principali lesioni o malattie neuromuscolari
5.7. Principi di Elettromiografia
5.7.1. Concetto di elettromiografia
5.7.2. Sviluppo dell'elettromiografia
5.7.3. Protocollo di studio elettromiografico
5.7.4. Metodi di elettromiografia
5.8. Principali correnti eccitomotorie. Correnti neofaradiche
5.8.1. Definizione di corrente eccitomotoria e principali tipi di correnti eccitomotorie.
5.8.2. Fattori che influenzano la risposta neuromuscolare.
5.8.3. Correnti eccitomotorie più comunemente utilizzate. Correnti neofaradiche
5.9. Correnti eccitomotorie interferenziali. Correnti di Kotz
5.9.1. Correnti di Kotz o correnti russe
5.9.2. I parametri più importanti delle correnti di Kotz.
5.9.3. Protocollo di rinforzo descritto con la corrente russa
5.9.4. Differenze tra elettrostimolazione a bassa e media frequenza
5.10. Applicazioni dell'elettrostimolazione in uro-ginecologia
5.10.1. Elettrostimolazione e uroginecologia
5.10.2. Tipi di elettrostimolazione in uroginecologia
5.10.3. Posizionamento degli elettrodi
5.10.4. Meccanismo d'azione
5.11. Applicazioni pratiche
5.11.1. Raccomandazioni per l'applicazione delle correnti eccitomotorie
5.11.2. Tecniche per l'applicazione delle correnti eccitomotorie
5.11.3. Esempi di protocolli di lavoro descritti nella letteratura scientifica
5.12. Controindicazioni
5.12.1. Controindicazioni all'uso dell'elettrostimolazione per il rafforzamento muscolare
5.12.2. Raccomandazioni per una pratica sicura dell'elettrostimolazione
Modulo 6. Elettrostimolazione nei pazienti neurologici
6.1. Valutazione delle lesioni nervose. Principi di innervazione muscolare
6.1.1. Valutazione della lesione nervosa
6.1.2. Principi di innervazione muscolare
6.2. Curve intensità/tempo (I/T) e ampiezza/tempo (A/T)
6.2.1. Curve intensità/tempo
6.2.2. Curve ampiezza/tempo
6.3. Principali correnti nella riabilitazione neurologica
6.3.1. Introduzione alla riabilitazione neurologica
6.3.2. Principali correnti
6.4. Elettroterapia per la riabilitazione motoria nel paziente neurologico
6.4.1. Il paziente neurologico
6.4.2. L'elettroterapia per la riabilitazione motoria nel paziente neurologico
6.5. Elettroterapia per la riabilitazione somatosensoriale nel paziente neurologico
6.5.1. Introduzione alla riabilitazione somatosensoriale
6.5.2. Elettroterapia per la riabilitazione somatosensoriale nel paziente neurologico
6.6. Applicazioni pratiche
6.6.1. Casi di studio
6.7. Controindicazioni
6.7.1. Effetti avversi
Modulo 7. Elettroterapia e analgesia
7.1. Definizione di dolore. Concetto di nocicezione
7.1.1. Definizione di dolore
7.1.1.1. Caratteristiche del dolore
7.1.1.2. Altri concetti e definizioni relativi al dolore
7.1.1.3. Tipi di dolore
7.1.2. Concetto di nocicezione
7.1.2.1. Parte periferica del sistema nocicettivo
7.1.2.2. Parte centrale del sistema nocicettivo
7.2. Principali recettori nocicettivi
7.2.1. Classificazione dei nocicettori
7.2.1.1. In base alla velocità di conduzione
7.2.1.2. In base alla localizzazione
7.2.1.3. In base alla modalità di stimolazione
7.2.2. Funzione dei nocicettori
7.3. Principali vie nocicettive
7.3.1. Struttura di base del sistema nervoso
7.3.2. Vie spinali ascendenti
7.3.2.1. Tratto Spinotalamico (TST)
7.3.2.2. Tratto Spinoreticolare (TSR)
7.3.2.3. Tratto Spinomesencefalico (TSM)
7.3.3. Vie ascendenti del trigemino
7.3.3.1. Tratto trigeminotalamico o Lemnisco del Trigemino
7.3.4. Sensibilità e vie nervose
7.3.4.1. Sensibilità esterocettiva
7.3.4.2. Sensibilità propriocettiva
7.3.4.3. Sensibilità interocettiva
7.3.4.4. Altri fascicoli relativi alle vie sensoriali
7.4. Meccanismi trasmissivi della regolazione nocicettiva
7.4.1. Trasmissione a livello del midollo spinale (APME)
7.4.2. Caratteristiche dei neuroni APME
7.4.3. Laminazione di Redex
7.4.4. Biochimica della trasmissione a livello di APME
7.4.4.1. Canali e recettori presinaptici e postsinaptici
7.4.4.2. Trasmissione a livello delle vie spinali ascendenti
7.4.4.3. Tratto Spinotalamico (TST)
7.4.4.4. Trasmissione a livello del talamo
7.4.4.5. Nucleo posteriore ventrale (VNP)
7.4.4.6. Nucleo mediale dorsale (MDN)
7.4.4.7. Nuclei intralaminari
7.4.4.8. Regione posteriore
7.4.4.9. Trasmissione a livello della corteccia cerebrale
7.4.4.10. Area somatosensoriale primaria (S1)
7.4.4.11. Area somatosensoriale secondaria o di associazione (S2)
7.4.5. Gate control
7.4.5.1. Modulazione Livello segmentale
7.4.5.2. Modulazione sovra-segmentale
7.4.5.3. Considerazioni
7.4.5.4. Revisione della teoria Control Gate
7.4.6. Vie discendenti
7.4.6.1. Centri modulatori del tronco encefalico
7.4.6.2. Controllo nocicettivo inibitorio diffuso (DINC)
7.5. Effetti modulatori dell'elettroterapia
7.5.1. Livelli di modulazione del dolore
7.5.2. Plasticità neuronale
7.5.3. Teoria delle vie sensoriali del dolore
7.5.4. Modelli di elettroterapia
7.6. Alta frequenza e analgesia
7.6.1. Calore e temperatura
7.6.2. Effetti
7.6.3. Tecniche di applicazione
7.6.4. Dosaggio
7.7. Bassa frequenza e analgesia
7.7.1. Stimolazione selettiva
7.7.2. TENS e Control Gate
7.7.3. Depressione post-eccitatoria del sistema nervoso ortosimpatico
7.7.4. Teoria del rilascio di endorfine
7.7.5. Dosaggio della TENS
7.8. Altri parametri relativi all'analgesia
7.8.1. Effetti dell'elettroterapia
7.8.2. Dosaggio in elettroterapia
Modulo 8. Stimolazione elettrica transcutanea (TENS)
8.1. Fondamenti della corrente di tipo TENS
8.1.1. Introduzione
8.1.1.1. Quadro teorico: Neurofisiologia del dolore
8.1.1.1.1. Introduzione e classificazione delle fibre nocicettive
8.1.1.1.2. Caratteristiche delle fibre nocicettive
8.1.1.1.3. Fasi del processo nocicettivo
8.1.2. Sistema antinocicettivo: Teoria del Cancello
8.1.2.1. Introduzione alla corrente di tipo TENS
8.1.2.2. Caratteristiche di base della corrente di tipo TENS (forma dell'impulso, durata, frequenza e intensità)
8.2. Classificazione della corrente di tipo TENS
8.2.1. Introduzione
8.2.1.1. Classificazione dei tipi di corrente elettrica
8.2.1.2. In base alla frequenza (numero di impulsi emessi al secondo)
8.2.2. Classificazione della corrente di tipo TENS
8.2.2.1. TENS convenzionale
8.2.2.2. TENS-agopuntura
8.2.2.3. TENS a bassa frequenza (low-rate burst)
8.2.2.4. TENS breve e intensa
8.2.3. Meccanismi d'azione della corrente di tipo TENS
8.3. Stimolazione elettrica transcutanea (TENS)
8.4. Effetti analgesici della TENS ad alta frequenza
8.4.1. Introduzione
8.4.1.1. Principali ragioni dell'ampia applicazione clinica della TENS convenzionale
8.4.2. Ipoalgesia da TENS convenzionale/ad alta frequenza
8.4.2.1. Meccanismo d'azione
8.4.3. Neurofisiologia della TENS convenzionale
8.4.3.1. Control Gate
8.4.3.2. La metafora
8.4.4. Fallimento degli Effetti Analgesici
8.4.4.1. Errori principali
8.4.4.2. Principale problema di ipoalgesia con la TENS convenzionale
8.5. Effetti analgesici della TENS a bassa frequenza
8.5.1. Introduzione
8.5.2. Meccanismi d'azione dell'agopuntura ipoalgesica mediata dalla TENS: sistema oppioide endogeno
8.5.3. Meccanismo d'azione
8.5.4. Alta intensità e Bassa frequenza
8.5.4.1. Parametri
8.5.4.2. Differenze fondamentali con la corrente di tipo TENS convenzionale
8.6. Effetti analgesici della TENS di tipo burst
8.6.1. Introduzione
8.6.2. Descrizione
8.6.2.1. Dettagli della corrente TENS di tipo burst
8.6.2.2. Parametri fisici
8.6.2.3. Sjölund e Eriksson
8.6.3. Sintesi dei meccanismi fisiologici dell'analgesia centrale e periferica
8.7. Importanza dell'ampiezza del polso
8.7.1. Introduzione
8.7.1.1. Caratteristiche fisiche delle onde
8.7.1.1.1. Definizione di onda
8.7.1.1.2. Altre caratteristiche e proprietà generali di un'onda
8.7.2. Forma dell'impulso
8.8. Elettrodi. Tipi e applicazioni
8.8.1. Introduzione
8.8.1.1. Il dispositivo a corrente TENS
8.8.2. Elettrodi
8.8.2.1. Caratteristiche generali
8.8.2.2. Cura della pelle
8.8.2.3. Altri tipi di elettrodi
8.9. Applicazioni pratiche
8.9.1. Applicazioni TENS
8.9.2. Durata dell'impulso
8.9.3. Forma dell'impulso
8.9.4 Intensità
8.9.5 Frequenza
8.9.6 Tipo e posizionamento degli elettrodi
8.10. Controindicazioni
8.10.1. Controindicazioni all'uso della terapia TENS
8.10.2. Raccomandazioni per una pratica sicura della TENS
Modulo 9. Correnti interferenziali
9.1. Fondamenti delle correnti interferenziali
9.1.1. Concetto di corrente interferenziale
9.1.2. Principali proprietà delle correnti interferenziali
9.1.3. Caratteristiche ed effetti delle correnti interferenziali
9.2. Parametri principali delle correnti interferenziali
9.2.1. Introduzione ai diversi parametri
9.2.2. Tipi di frequenza ed effetti prodotti
9.2.3. Importanza del tempo di applicazione
9.2.4. Tipi di applicazioni e parametri
9.3. Effetti dell'alta frequenza
9.3.1. Concetto di alta frequenza nelle correnti interferenziali
9.3.2. Principali effetti dell'alta frequenza
9.3.3. Applicazione dell'alta frequenza
9.4. Concetto di sistemazione. Importanza e adattamento dello spettro di frequenza
9.4.1. Concetto di bassa frequenza nelle correnti interferenziali
9.4.2. Effetti principali della bassa frequenza
9.4.3. Applicazione della bassa frequenza
9.5. Elettrodi. Tipi e applicazioni
9.5.1. Principali tipi di elettrodi per correnti interferenziali
9.5.2. Importanza dei tipi di elettrodi nelle correnti interferenziali
9.5.3. Applicazione dei diversi tipi di elettrodi
9.6. Applicazioni pratiche
9.6.1. Raccomandazioni per l'applicazione di correnti interferenziali
9.6.2. Tecniche di applicazione delle correnti interferenziali
9.7. Controindicazioni
9.7.1. Controindicazioni all'uso delle correnti interferenziali
9.7.2. Raccomandazioni per una pratica sicura con le correnti interferenziali
Modulo 10. Trattamento invasivo in elettroterapia
10.1. Trattamento invasivo in fisioterapia a scopo analgesico
10.1.1. Informazioni generali
10.1.2. Tipi di trattamento invasivo
10.1.3. Infiltrazione contro puntura
10.2. Principi della puntura secca
10.2.1. Sindrome del dolore miofasciale
10.2.2. Punti trigger miofasciali
10.2.3. Neurofisiologia delle sindromi dolorose miofasciali e dei punti trigger
10.3. Trattamenti post-puntura
10.3.1. Effetti avversi dell'agopuntura secca
10.3.2. Trattamenti post-agopuntura
10.3.3. Combinazione di agopuntura secca e TENS
10.4. Elettroterapia come coadiuvante dell'agopuntura secca
10.4.1. Approccio non invasivo
10.4.2. Approccio invasivo
10.4.3. Tipi di elettropuntura
10.5. Stimolazione elettrica percutanea: PENS
10.5.1. Fondamenti neurofisiologici dell'applicazione del PENS
10.5.2. Evidenza scientifica dell'applicazione del PENS
10.5.3. Considerazioni generali per l'implementazione di PENS
10.6. Vantaggi della PENS rispetto alla TENS
10.6.1. Stato attuale dell'implementazione della PENS
10.6.2. Applicazione della PENS nella lombalgia
10.6.3. Applicazione della PENS in altre regioni e patologie
10.7. Uso degli elettrodi
10.7.1. Generalità sull'applicazione degli elettrod
10.7.2. Variazioni nell'applicazione degli elettrodi
10.7.3. Applicazione multipolare
10.8. Applicazioni pratiche
10.8.1. Giustificazione dell'implementazione di PENS
10.8.2. Applicazioni nella lombalgia
10.8.3. Applicazioni nel quadrante superiore e nell'arto inferiore
10.9. Controindicazioni
10.9.1. Controindicazioni derivanti dalla TENS
10.9.2. Controindicazioni legate alla puntura secca
10.9.3. Considerazioni generali
10.10. Trattamenti invasivi a scopo rigenerativo
10.10.1. Introduzione
10.10.1.1. Concetto di Elettrolisi
10.10.2. Elettrolisi percutanea intratessutale
10.10.2.1. Concetto
10.10.2.2. Effetti
10.10.2.3. Revisione del State of the Art
10.10.2.4. Combinazione con esercizi eccentrici
10.11. Principi fisici del galvanismo
10.11.1. Introduzione
10.11.1.1. Caratteristiche fisiche della corrente continua
10.11.2. Corrente Galvanica
10.11.2.1. Caratteristiche fisiche della corrente galvanica
10.11.2.2. Fenomeni chimici della corrente galvanica
10.11.2.3. Struttura
10.11.3. Ionoforesi
10.11.3.1. Esperimento di Leduc
10.11.3.2. Proprietà fisiche della ionoforesi
10.12. Effetti fisiologici della corrente galvanica
10.12.1. Effetti fisiologici della Corrente Galvanica
10.12.2. Effetti Elettrochimici
10.12.2.1. Comportamento chimico
10.12.3. Effetti Elettrotermici
10.12.4. Effetti Elettrofisici
10.13. Effetti terapeutici della corrente galvanica
10.13.1. Applicazione clinica della Corrente Galvanica
10.13.1.1. Azione Vasomotoria
10.13.1.1.1. Azione sul Sistema Nervoso
10.13.2. Effetti Terapeutici della Ionoforesi
10.13.2.1. Penetrazione ed eliminazione di cationi e anioni
10.13.2.2. Farmaci e indicazioni
10.13.3. Effetti terapeutici dell'elettrolisi percutanea intratessutale
10.14. Tipi di applicazione percutanea della corrente galvanica
10.14.1. Introduzione alle Tecniche di Applicazione
10.14.1.1. Classificazione in base al posizionamento degli elettrodi
10.14.1.1.1. Galvanizzazione diretta
10.14.2. Galvanizzazione indiretta
10.14.3. Classificazione in base alla tecnica applicata
10.14.3.1. Elettrolisi percutanea intratessutale
10.14.3.2. Ionoforesi
10.14.3.3. Bagno galvanico
10.15. Protocolli di applicazione
10.15.1. Protocolli di applicazione della corrente galvanica
10.15.2. Protocolli di applicazione dell'elettrolisi percutanea intratessutale
10.15.2.1. Procedura
10.15.3 Protocolli di Applicazione dell'Ionoforesi
10.15.3.1. Procedura
10.16. Controindicazioni
10.16.1. Controindicazioni alla Corrente Galvanica
10.16.2. Controindicazioni, complicazioni e precauzioni della corrente galvanica
Modulo 11. Magnetoterapia in Fisioterapia
11.1. Principi fisici della magnetoterapia
11.1.1. Introduzione
11.1.2. Storia della Magnetoterapia
11.1.3. Definizione
11.1.4. Principi della Magnetoterapia
11.1.4.1. Campi Magnetici sulla Terra
11.1.4.2. Principi fisici
11.1.5. Interazioni Biofisiche con i Campi Magnetici
11.2. Effetti fisiologici della magnetoterapia
11.2.1. Effetti della Magnetoterapia sui Sistemi Biologici
11.2.1.1. Effetti Biochimici
11.2.1.2. Effetto Cellulare
11.2.1.2.1. Effetti su Linfociti e Macrofagi
11.2.1.2.2. Effetti sulla Membrana Cellulare
11.2.1.2.3. Effetti sul Citoscheletro
11.2.1.2.4. Effetti sul Citoplasma
11.2.1.3. Conclusioni sull'effetto sulla Cellula
11.2.1.4. Effetto sul Tessuto Osseo
11.3. Effetti terapeutici della magnetoterapia
11.3.1. Introduzione
11.3.2. Infiammazione
11.3.3. Vasodilatazione
11.3.4. Analgesia
11.3.5. Aumento del Metabolismo del Calcio e del Collagene
11.3.6. Riparazione
11.3.7. Rilassamento Muscolare
11.4. Parametri principali dei campi magnetici
11.4.1. Introduzione
11.4.2. Parametri dei Campi Magnetici
11.4.2.1. Intensità
11.4.2.2. Frequenza
11.4.3. Dosimetria dei Campi Magnetici
11.4.3.1. Frequenza di Applicazione
11.4.3.2. Tempo di Applicazione
11.5. Tipi di elettrodi e loro applicazione
11.5.1. Introduzione
11.5.2. Campi Elettromagnetici
11.5.2.1. Applicazione globale o "Total Body
11.5.2.2. Applicazione Regionale
11.5.3. Campi Magnetici Locali Indotti Con Magneti
11.5.3.1. Conclusioni
11.6. Magnetoterapia. Applicazioni cliniche
11.6.1. Introduzione
11.6.2. Artrosi
11.6.2.1. Campi Elettromagnetici e Apoptosi dei Condrociti
11.6.2.2. Osteoartrite del Ginocchio in Fase Iniziale
11.6.2.3. Artrosi in Fase Avanzata
11.6.2.4. Conclusioni su Artrosi e Campi Elettromagnetici Pulsati
11.6.3. Consolidamento Osseo
11.6.3.1. Revisione della Letteratura sul Consolidamento Osseo
11.6.3.2. Guarigione ossea nelle Fratture dell'Osso Lungo
11.6.3.3. Guarigione ossea nelle Fratture dell'Osso Corto
11.6.4. Patologia della Spalla
11.6.4.1. Impedimento della Spalla
11.6.4.2. Tendinopatia della Cuffia dei Rotatori
11.6.4.2.1. Artrite Reumatoide
11.6.4.2.2. Conclusioni
11.7. Magnetoterapia. Controindicazioni
11.7.1. Introduzione
11.7.2. Possibili Effetti Avversi Studiati
11.7.3. Precauzioni
11.7.4. Controindicazioni Formali
11.7.5. Conclusioni
Modulo 12. Stimolazione Cerebrale Non Invasiva
12.1. Stimolazione cerebrale non invasiva: Introduzione
12.1.1. Introduzione alla stimolazione cerebrale non invasiva
12.1.2. Stimolazione magnetica transcranica
12.1.2.1. Introduzione alla stimolazione magnetica transcranica
12.1.2.2. Meccanismi d'azione
12.1.2.3. Protocolli di stimolazione
12.1.2.3.1. Stimolazione magnetica transcranica con impulsi singoli e accoppiati
12.1.2.3.2. Localizzazione del sito di stimolazione “hot spot”
12.1.2.3.3. Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (TMS)
12.1.2.3.4. Stimolazione a schema ripetitivo semplice
12.1.2.3.5. Stimolazione theta-burst (TBS)
12.1.2.3.6. Stimolazione a quadripulso (QPS)
12.1.2.3.7. Stimolazione associativa a coppie (PAS)
12.1.2.4. Sicurezza
12.1.2.5. Applicazioni terapeutiche
12.1.3. Conclusioni
12.1.4. Bibliografia
12.2. Corrente diretta transcranica
12.2.1. Corrente diretta transcranica
12.2.1.1. Introduzione alla corrente diretta transcranica
12.2.1.2. Meccanismi d'azione
12.2.1.3. Sicurezza
12.2.1.4. Procedure
12.2.1.5. Applicazioni
12.2.1.6. Altre forme di stimolazione elettrica transcranica
12.2.2. Neuromodulazione transcranica in combinazione con altri interventi terapeutici
12.2.3. Conclusioni
12.2.4. Bibliografia

Un'esperienza educativa unica, cruciale e decisiva per crescere professionalmente"
Master Privato in Elettroterapia nell'Attività Fisica e nello Sport
Il lavoro di riabilitazione è un pilastro fondamentale nel ramo medico, poiché ogni giorno nascono nuovi trattamenti, tecniche e strumenti innovativi che richiedono conoscenze aggiornate da parte di professionisti dedicati a questo settore. Con l'obiettivo di ampliare l'area di conoscenza e potenziare le proprie competenze in TECH, abbiamo progettato un Master Privato in Elettroterapia nell'Attività Fisica e nello Sport. Un programma accademico di alto livello incentrato sull'approfondimento dei trattamenti fisioterapici per affrontare diverse patologie. Durante 1.500 ore ti specializzerai nella stimolazione delle fibre nervose, nella modulazione di alcune aree cerebrali, nell'elettroterapia ad alta frequenza, nell'ultrasuonoterapia e in altri campi elettromagnetici applicati all'esercizio fisico. Segui questo corso post-laurea presso la più grande Facoltà di Scienze Motorie e aggiungi nuove competenze al tuo profilo professionale.
Diventa un esperto di elettroterapia applicata all'esercizio
In TECH Università Tecnologica abbiamo il programma scientifico più innovativo e aggiornato del settore; Ti forniamo le basi necessarie per approfondire l'utilizzo di questo trattamento dei campi elettromagnetici. Ti specializzerai imparando la fisiopatologia umana e la fisiochimica, i meccanismi di contrazione muscolare, la trasmissione somatosensoriale, le tecniche analgesiche percutanee e la stimolazione transcranica. In questo modo potrai trattare pazienti con problemi cronici o neurologici e applicare trattamenti totalmente appropriati per ciascuno di essi. Inoltre, potrai approfondire argomenti come l'elettrostimolazione per il potenziamento muscolare, la stimolazione elettrica transcutanea (TENS) e la corrente analgesica ad alta frequenza.
Iscriviti a un corso post-laurea online
Il piano di studi di questo programma è progettato con prove scientifiche e basi neurofisiologiche; Con questo corso tenuto in un formato online al 100%, sarai un esperto in elettroterapia per trattare la fisiologia e stimolare le aree del corpo colpite dal dolore ai nervi, tra cui infiammazioni, muscoli atrofizzati o lesioni muscoloscheletriche. Allo stesso modo, affronterai le patologie neuromuscoloscheletriche sviluppando più di 75 casi pratici simulati come situazioni reali che possono sorgere; questo servirà per completare il tuo piano di studi e reagire agli imprevisti. In TECH abbiamo metodologie di insegnamento eccezionali.Quando completerai questo Master, avrai a portata di mano un sistema di apprendimento interattivo accompagnato da lezioni teoriche e forum partecipativi.