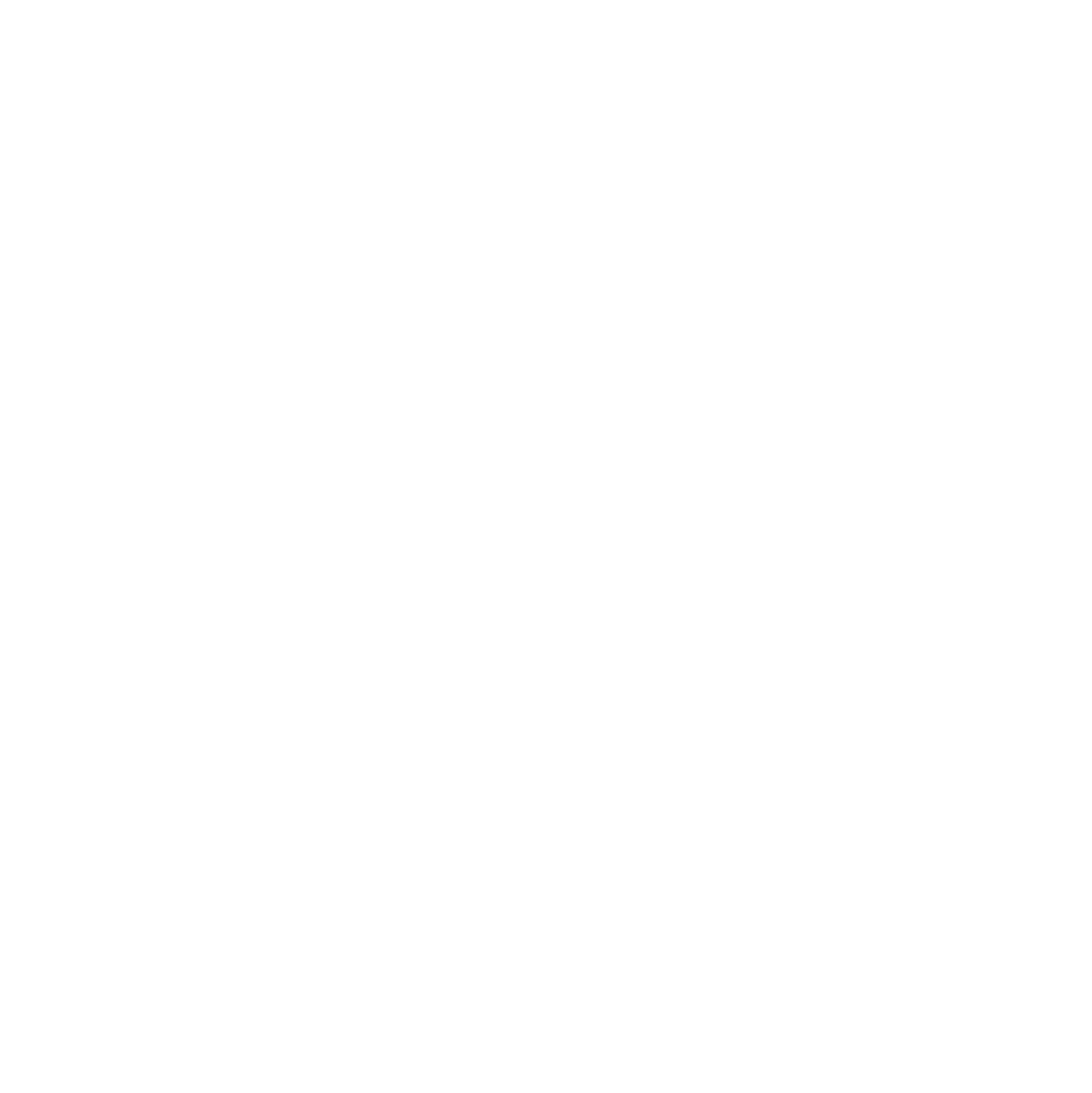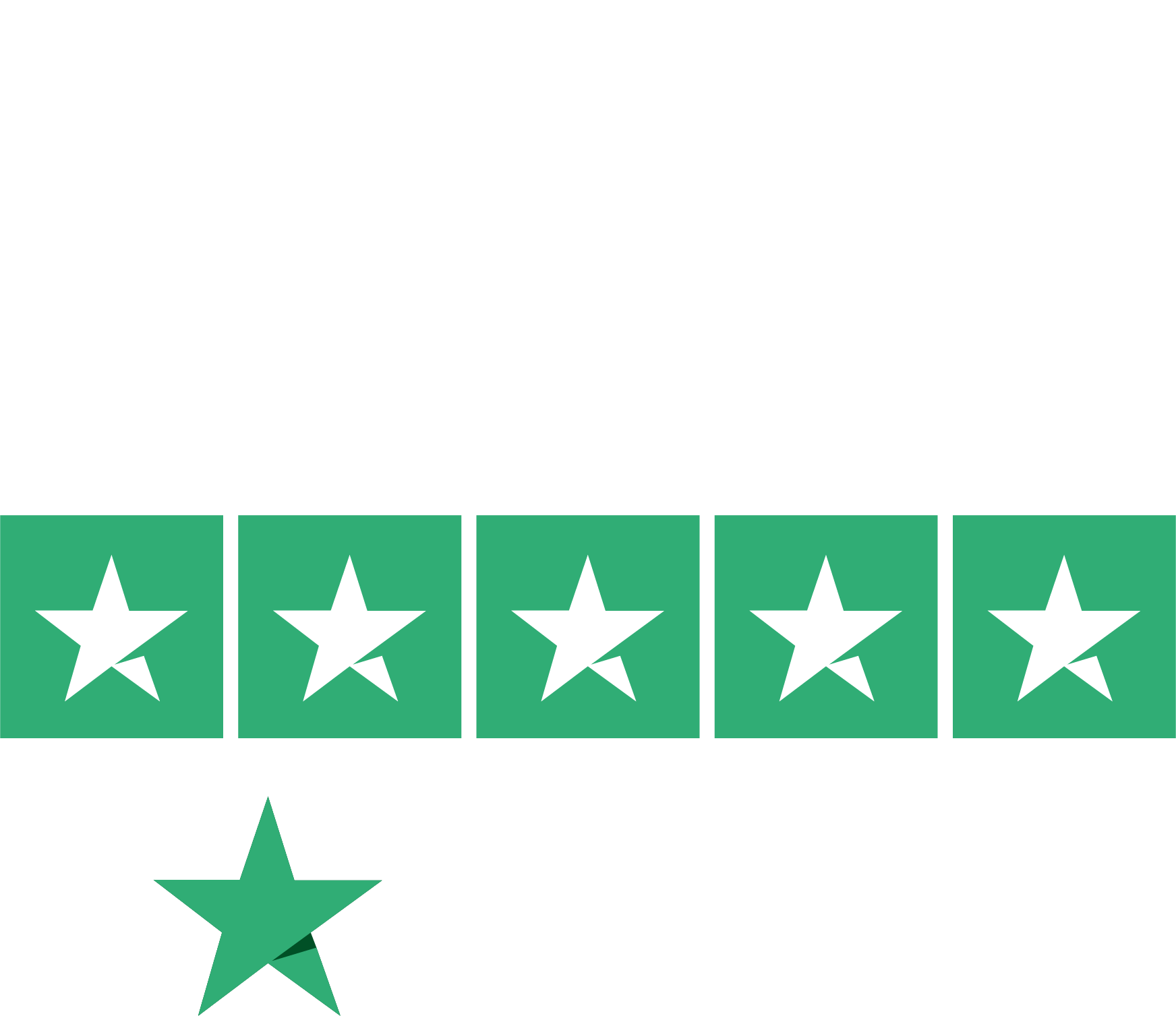Titolo universitario
La più grande facoltà di psicologia del mondo"
Presentazione
Le strategie e gli approcci alla Psicologia dell'Educazione e della Salute raccolte in un Master privato di altissima qualità educativa, con la qualità incomparabile della migliore specializzazione online del mercato"

La Psicologia dell'Educazione è la disciplina che si occupa dei processi di insegnamento e apprendimento; applica i metodi e le teorie della psicologia e ha anche metodi propri. Il suo obiettivo principale è la comprensione e il miglioramento dell'educazione.
Questo Master privato fornisce un'ampia conoscenza di modelli e tecniche avanzate in Psicologia dell'Educazione e della Salute. Potrai fare riferimento su un personale docente che si distingue per la sua ampia esperienza professionale, specializzati nei diversi ambiti della psicologia.
Durante il programma percorrerai tutti gli approcci attuali del lavoro dello psicologo sull'educazione e sulla salute. Studierai i disturbi dello sviluppo del linguaggio, la consulenza e l'intervento della famiglia, così come i nuovi sviluppi della psicofarmacologia, questi sono alcuni dei molteplici argomenti che verranno insegnati durante i 12 mesi di programma intensivo.
Non solo ti accompagneremo attraverso le conoscenze teoriche che offriamo, ma ti mostreremo un altro modo di studiare e imparare, organico, semplice ed efficiente. Lavorerai per mantenerti motivato e per creare in te stesso la passione per l'apprendimento, aiutandoti a pensare e a sviluppare il pensiero critico.
Un passo di alto livello che diventerà un processo di miglioramento, non solo professionale, ma anche personale.
Un programma creato per i professionisti che aspirano all'eccellenza e che permetterà di acquisire nuove competenze e strategie in modo fluente ed efficace"
Questo Master privato in Psicologia dell'Educazione e della Salute contiene il programma più completo e aggiornato presente del mercato. Le caratteristiche principali del corso sono:
- Lo sviluppo di 100 casi di studio presentati da esperti in Psicologia dell'Educazione e della Salute
- I contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici in base ai quali sono stati concepiti forniscono informazioni scientifiche e sanitarie riguardo alle discipline mediche essenziali per lo psicologo
- Nuovi sviluppi e innovazioni nei vari campi della psicologia
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- Un sistema di apprendimento interattivo basato su algoritmi per prendere decisioni riguardanti le situazioni proposte
- La sua speciale enfasi sulle metodologie di ricerca
- Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
Acquisire una conoscenza approfondita della Psicologia dell'Educazione e della Salute e delle sue molteplici implicazioni, in un Master privato completo creato per crescere a livello professionale"
Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La progettazione di questo programma è basata sull’Apprendimento Basato su Problemi mediante il quale il Studente deve cercare di risolvere le diverse situazioni che si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.
Aumenta la tua fiducia nel processo decisionale aggiornando le tue conoscenze grazie a questo Master privato"

Questo Master privato segna la differenza tra un professionista con molte conoscenze e un professionista che sa come applicarle nella pratica quotidiana della sua professione"
Programma
I contenuti di questa specializzazione completa sono stati sviluppati dai professionisti più competenti in questo settore, con criteri di alta qualità in ogni fase del programma. A tal fine, sono stati selezionati gli argomenti più rilevanti e completi, mediante gli ultimi e più interessanti aggiornamenti del momento.

Questo Master privato in Psicologia dell'Educazione e della Salute contiene il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato"
Modulo 1. Psicologia dell'Educazione
1.1. Storia, concetto e tendenze attuali in Psicologia dell'Educazione
1.1.1. Storia: gli inizi, la nascita e il consolidamento della Psicologia dell'Educazione
1.1.2. Questioni concettuali e diversità epistemologica
1.1.3. Metodologia della ricerca educativa
1.2. Natura, caratteristiche e approcci all'apprendimento
1.2.1. Introduzione
1.2.2. Metafore per l'apprendimento
1.2.3. Conclusioni
1.3. Teorie comportamentiste e implicazioni per l'educazione
1.3.1. Condizionamento classico nel contesto educativo
1.3.2. Condizionamento strumenti nel contesto educativo
1.3.3. Condizionamento operante nel contesto educativo
1.3.4. Apprendimento sociale di Bandura
1.3.5. Tecniche di modifica del comportamento basate sui condizionamenti
1.4. Teorie dell'elaborazione delle informazioni
1.4.1. Inizi, centri di influenza e periodo di consolidamento
1.4.2. Teoria adattiva del controllo del pensiero
1.4.3. Teoria degli schemi
1.4.4. Teoria dell'elaborazione delle informazioni
1.5. Teorie cognitive dell'apprendimento
1.5.1. Teorie classiche
1.5.2. Teorie attuali
1.5.3. Implicazioni nel contesto educativo attuale
1.6. Intelligenza
1.6.1. Concettualizzazione
1.6.2. Teorie dell'approccio psicometrico
1.6.3. Strumenti di valutazione
1.6.4. Teorie cognitive/attuali
1.6.5. Teorie attuali
1.6.6. Modello di Feuerstein
1.6.7. Teoria triarchica di Sternberg
1.6.8. Teoria delle intelligenze multipli Gadner
1.6.9. Intelligenza emotiva di Salovey, Mayer e Caruso
1.6.10. Strumenti di valutazione
1.6.11. Programmi di intervento
1.7. Stili di apprendimento e di pensiero
1.7.1. Concettualizzazione
1.7.2. Tipologie, caratteristiche e criteri differenziali
1.7.3. Strumenti di valutazione
1.8. Motivazione e apprendimento scolastico
1.8.1. Concettualizzazione e modelli esplicativi della motivazione
1.8.2. Tipi di motivazione
1.8.3. Obiettivi accademici
1.8.4. Motivazione al risultato
1.8.5. Strumenti di valutazione
1.8.6. Modelli di intervento
1.9. Creatività Approssimazione concettuale
1.9.1. Modelli classici
1.9.2. Modelli attuali
1.9.3. Strumenti di valutazione
1.9.4. Applicazioni nel contesto educativo
1.10. Relazioni interpersonali e abilità sociali
1.10.1. Processi di gruppo in classe
1.10.2. Dinamiche di classe
1.10.3. Conclusioni
Modulo 2. Psicologia dello sviluppo
2.1. Fondamenti e introduzione alla psicologia dello sviluppo I
2.1.1. Obiettivo
2.1.2. Introduzione
2.1.3. Maturazione, concetto e importanza evolutiva
2.1.4. Uno sviluppo graduale
2.1.5. Lo sviluppo nel ciclo di vita
2.1.6. Lo sviluppo multidimensionale
2.1.7. Sviluppo comune, ma a ritmi diversi
2.1.8. Alcuni fattori da considerare
2.1.9. Conclusioni
2.1.10. Riepilogo
2.1.11. Riferimenti
2.2. Fondamenti e introduzione alla psicologia dello sviluppo II
2.2.1. Obiettivo
2.2.2. Introduzione
2.2.3. Le origini dello sviluppo e la figura del bambino
2.2.4. I primi approcci allo studio dello sviluppo
2.2.5. I primi lavori scientifici sullo sviluppo
2.2.6. La metodologia dello studio
2.2.7. Studio di caso
2.2.8. Alcuni disegni sperimentali
2.2.9. Alcune teorie da considerare
2.2.10. Conclusioni
2.2.11. Riepilogo
2.2.12. Riferimenti
2.3. Sviluppo prenatale
2.3.1. Introduzione
2.3.2. Lo sviluppo prenatale
2.3.3. La fase germinale
2.3.4. Lo stadio embrionale
2.3.5. Lo stadio fetale
2.3.6. Conclusioni
2.3.7. Riepilogo
2.3.8. Riferimenti
2.4. Sviluppo neuropsicologico nell'infanzia
2.4.1. Introduzione
2.4.2. Sviluppo del concetto di sé e dell'autocoscienza
2.4.3. Conclusioni
2.4.4. Riepilogo
2.4.5. Bibliografia
2.5. La teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget
2.5.1. Introduzione
2.5.2. Jean Piaget
2.5.3. L’importanza biologica
2.5.4. Il concetto di intelligenza
2.5.5. Lo sviluppo intellettuale nel bambino secondo Piaget
2.5.6. Fasi dello sviluppo
2.5.7. Conclusioni
2.5.8. Riepilogo
2.5.9. Bibliografia
2.6. Prospettiva socio-culturale, teoria dell'elaborazione delle informazioni e teoria di Bruner
2.6.1. Introduzione
2.6.2. Vygotsky
2.6.3. La zona di sviluppo prossimale (ZDP) e l'Apprendimento Assistito
2.6.4. Il concetto di pensiero di Vygotsky
2.6.5. Lo sviluppo del linguaggio di Vygotsky
2.6.6. Relazione tra pensiero e linguaggio
2.6.7. Jerome Bruner
2.6.8. Conclusioni
2.6.9. Riepilogo
2.6.10. Bibliografia
2.7. Sviluppo psicomotorio: sviluppo psicomotorio fine e grossolano
2.7.1. Introduzione.
2.7.2. Lo sviluppo psicomotorio
2.7.3. Psicomotricità: lo schema del corpo
2.7.4. Capacità psicomotorie lorde
2.7.5. Psicomotorie fini
2.7.6. Sviluppo motorio nel tempo
2.7.7. Lo sviluppo della motricità fine
2.7.8. Conclusioni
2.7.9. Riepilogo
2.7.10. Riferimenti
2.8. Introduzione ed elementi chiave nello sviluppo del linguaggio
2.8.1. Introduzione
2.8.2. Gli inizi del linguaggio
2.8.3. Primi passi nella lingua
2.8.4. Le prime parole
2.8.5. Le prime frasi
2.8.6. Conclusioni
2.8.7. Riepilogo
2.8.8. Riferimenti
2.9. Stadio pre-linguistico e linguistico
2.9.1. Introduzione
2.9.2. Conclusioni
2.9.3. Riepilogo
2.9.4. Bibliografia
2.10. Disturbi legati allo sviluppo del linguaggio
2.10.1. Introduzione
2.10.2. Conclusioni
2.10.3. Bibliografia
Modulo 3. Neuroscienze
3.1. Il sistema nervoso e i neuroni
3.1.1. La formazione del sistema nervoso
3.1.2. Tipi di neuroni
3.2. Basi neurobiologiche del cervello
3.2.1. Emisferi e lobuli cerebrali
3.2.2. Localismo vs Funzionalità cerebrale
3.3. Genetica e sviluppo neurale
3.3.1. Neuroni indifferenziati
3.3.2. Morte neuronale programmata
3.4. Mielinizzazione
3.4.1. Comunicazione elettrica inter-neuronale
3.4.2. Il ruolo della mielina nei neuroni
3.5. Neurochimica del cervello
3.5.1. La comunicazione chimica interneuronale
3.5.2. I neuroormoni e le loro funzioni
3.6. Plasticità e sviluppo del cervello
3.6.1. Età vs plasticità neuronale
3.6.2. Lo sviluppo neuronale
3.7. Differenze emisferiche
3.7.1. Cervello destro
3.7.2. Cervello sinistro
3.8. Connettività interemisferica
3.8.1. La sostanza bianca
3.8.2. Differenze di genere
3.9. Localismo vs Funzionalismo
3.9.1. Funzioni emisferiche
3.9.2. Nuovo localismo
3.10. Tecniche per lo studio del cervello invasive vs non invasive
3.10.1. Tecniche invasive
3.10.2. Tecniche non invasive
Modulo 4. Psicologia dell'Apprendimento
4.1. Apprendimento e condizionamento classico
4.1.1. Introduzione
4.1.2. Riflesso, assuefazione e sensibilizzazione
4.1.3. Il condizionamento classico
4.2. Condizionamento operativo
4.2.1. Fondamenti del condizionamento operante
4.2.2. Programmi di rinforzo e punizione
4.2.3. Estinzione
4.3. Apprendimento causale
4.3.1. Introduzione
4.3.2. Modelli di apprendimento causale
4.3.3. Impotenza appresa
4.4. Apprendimento spaziale
4.4.1. Introduzione
4.4.2. Tolman, pioniere dell'apprendimento spaziale
4.4.3. Conclusioni
4.5. Apprendimento osservativo
4.5.1. Introduzione
4.5.2. Apprendimento osservazionale
4.5.3. Teoria dell'apprendimento sociale di Bandura
4.5.4. Alternative all'imitazione
4.5.5. Substrati cerebrali: neuroni specchio
4.6. Concetti e categorie di apprendimento, abilità e strategie
4.6.1. Introduzione
4.6.2. Apprendimento di relazioni astratte (categorie e concetti)
4.6.3. Capacità di apprendimento
4.6.4. Strategie di apprendimento
4.7. Ragionamento deduttivo
4.7.1. Introduzione
4.7.2. Ragionamento deduttivo: proposizionale
4.7.3. Principali inferenze
4.7.4. Teorie di ragionamento
4.8. Ragionamento probabilistico
4.8.1. Introduzione al ragionamento induttivo: induzione categoriale
4.8.2. Introduzione al ragionamento probabilistico
4.8.3. Euristico
4.8.4. Teoria dei modelli mentali
4.9. Apprendimento, Motivazione ed Emozioni
4.9.1. Introduzione
4.9.2. Teoria decisionale normativa
4.9.3. Processo decisionale
4.10. Ragionamento nel contesto
4.10.1. Ragionamento quotidiano
4.10.2. Capacità di argomentazione
4.10.3. Creatività
Modulo 5. Valutazione Psicologica
5.1. Fondamenti teorici della valutazione psicologica
5.1.1. Definizione e obiettivi
5.1.2. Contenuti della valutazione neuropsicologica
5.1.3. Conclusioni
5.2. Anamnesi o storia medica
5.2.1. Introduzione e ruolo della cartella clinica
5.2.2. Compilazione della cartella clinica
5.2.3. Contenuto della cartella clinica
5.3. Intervista clinica e osservazione comportamentale
5.3.1. Intervista clinica
5.3.2. Osservazione del comportamento dell'intervistato
5.3.3. Conclusioni
5.4. Elementi essenziali di selezione, amministrazione e revisione
5.4.1. Registrazione e presa di note
5.4.2. Procedure standard di test
5.4.3. Correzione dei test
5.4.4. Interpretazione delle prove
5.5. Popolazioni speciali nella valutazione neuropsicologica
5.5.1. Applicazione dei test ai pazienti con afasia
5.5.2. Applicazione dei test ai pazienti con disabilità motorie
5.5.3. Valutazioni neuropsicologiche infantili
5.5.4. Geroneuropsicologia
5.5.5. Disturbi psichiatrici
5.5.6. Valutazioni neuropsicologiche forensi
5.6. Scrittura di rapporti psicologici
5.6.1. Introduzione
5.6.2. Redazione di un rapporto neuropsicologico
5.6.3. Organizzazione di un rapporto neuropsicologico
5.7. Strumenti per la valutazione dell'intelligenza e dell'attenzione
5.7.1. Scala di Wechsler
5.7.2. Scale di Reynolds
5.7.3. Scale di Kaufman
5.7.4. Scale di Stanford-Binet
5.7.5. Scale di Raven
5.7.6. Color Trail test
5.7.7. Trail-making test
5.7.8. continuous performance test
5.7.9. Digit spam
5.7.10. Test di percezione della differenza del volto
5.7.11. Test di attenzione e concentrazione
5.8. Strumenti per valutare le funzioni esecutive, l'apprendimento e la memoria
5.8.1. Behavioural assessment of the Dysexecutive Syndrome BADS
5.8.2. Torre di Hanoi/Siviglia, Ring Test
5.8.3. Test di colori e parole Stroop
5.8.4. Valutazione neuropsicologica delle funzioni esecutive nei bambini ENFEN
5.8.5. Test di ordinamento delle carte del Wisconsin
5.8.6. Test del labirinto di Porteus
5.8.7. Test di apprendimento verbale della California (CVLT)
5.8.8. Scale di memoria Wechsler-iv
5.8.9. Test di apprendimento verbale Spagna-Complutense TAVEC e TAVECI
5.8.10. Test di memoria e apprendimento TOMAL
5.9. Strumenti per la valutazione delle funzioni motorie, visive, visuospaziali, visuo-spaziali e visuo-tattili
5.9.1. Test dell'orologio
5.9.2. Test delle figure aggrovigliate di Rey
5.9.3. Test di Bender
5.9.4. Test di sviluppo della percezione visiva di Frostig
5.9.5. Test di ritenzione visiva di Benton TRVB
5.9.6. Test di riconoscimento di figure sovrapposte
5.9.7. Test di riconoscimento destra-sinistra
5.9.8. Test di designi con cubi e puzzle
5.9.9. Test di riconoscimento degli oggetti e test di riconoscimento delle dita
5.9.10. Test per la valutazione delle abilità motorie
5.10. Test neuropsicologici
5.10.1. Test di Luria-Christensen
5.10.2. Questionario di maturità neuropsicologica Cumanin e Cumanes
5.10.3. Esame cognitivo mini-mentale MMSE
Modulo 6. Disturbi nello sviluppo del linguaggio
6.1. Introduzione
6.2. Pensiero e linguaggio: la loro relazione
6.2.1. Teorie che spiegano il suo sviluppo
6.2.2. Pensiero e linguaggio La loro interdipendenza
6.2.3. La posizione del linguaggio nell'apprendimento
6.3. Relazione tra linguaggio e difficoltà di apprendimento
6.3.1. Comunicazione, linguaggio, parola e linguaggio
6.3.2. Informazioni generali dello sviluppo del linguaggio
6.3.3. Prevenzione dei problemi del linguaggio
6.4. Lo sviluppo ritardato del linguaggio e le sue implicazioni per le difficoltà di apprendimento
6.4.1. Concettualizzazione del ritardo nello sviluppo del linguaggio e sua caratterizzazione
6.4.2. Cause del ritardo nello sviluppo del linguaggio
6.4.3. Importanza dell'identificazione precoce e della cura nelle scuole
6.4.4. Ritardo nello sviluppo del linguaggio come fattore di rischio per le difficoltà di apprendimento
6.5. Disturbi del linguaggio più comuni negli studenti
6.5.1. Concetti e delimitazioni
6.5.2. Disturbi del linguaggio orale Le sue manifestazioni nelle componenti fonetiche, fonologiche, morfo-lessicali, sintattiche, semantiche e pragmatiche
6.5.3. Disturbi del linguaggio: dislalia, disartria, rinolalia, disfonia e balbuzie
6.6. Valutazione del linguaggio
6.6.1. Strumenti di valutazione
6.6.2. Componenti da valutare
6.6.3. Referto di valutazione
6.7. Attenzione ai disturbi del linguaggio nelle istituzioni educative
6.7.1. Disturbi del linguaggio
6.7.2. Disturbi del linguaggio
6.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la sua applicazione pratica
6.9. Letture consigliate
6.10. Bibliografia
Modulo 7. Psicopatologia e intervento nel bambino e nell'adolescente
7.1. Psicopatologia infantile e adolescenziale: questioni fondamentali
7.1.1. Comorbidità con altri disturbi
7.1.2. La psicopatologia e i vari contesti
7.1.3. Vulnerabilità e rischio associato
7.2. Classificazione dei disturbi psicopatologici del bambino e dell'adolescente
7.2.1. Criteri di comportamento anormale
7.2.2. Disturbi e loro classificazione
7.2.3. Proprietà delle classificazioni di psicopatologia infantile
7.3. Valutazione dei disturbi nei bambini: caratteristiche generali
7.3.1. Valutazione diagnostica nell'infanzia: caratteristiche
7.3.2. Il processo di valutazione: fasi e strumenti
7.4. L’intervento nelle fasi infantili: aspetti differenziali
7.4.1. Caratteristiche specifiche
7.4.2. Il processo di intervento
7.4.3. Limitazioni di intervento
7.5. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività
7.5.1. Descrizione, caratteristiche
7.5.2. Diagnosi clinica e valutazione del disturbo
7.5.3. Trattamenti
7.6. Disturbi dello spettro autistico
7.6.1. Descrizione e caratteristiche
7.6.2. Valutazione e interventi terapeutici
7.7. Depressione infantile e adolescenziale
7.7.1. Caratteristiche
7.7.2. Valutazione del disturbo
7.7.3. Trattamento
7.8. Disturbi d'ansia e fobie infantili
7.8.1. Caratteristiche
7.8.2. Valutazione psicologica
7.8.3. Trattamento
7.9. Disturbi del comportamento dirompente
7.9.1. Descrizione e caratteristiche cliniche
7.9.2. Valutazione del disturbo
7.9.3. Trattamenti
7.10. Diverse entità cliniche di interesse nelle fasi infantili-giovanili
7.10.1. Abuso e maltrattamento
7.10.2. Malattie fisiche
7.10.3. Dolore cronico
Modulo 8. Cura precoce
8.1. Introduzione
8.1.1. Prevenzione dei bisogni
8.2. Interventi nei disturbi del linguaggio
8.2.1. Disturbi del linguaggio
8.3. Intervento di sviluppo
8.3.1. Origine prenatale e non prenatale
8.4. Intervento nei disturbi emotivi
8.4.1. Difficoltà di sviluppo emotivo
8.5. Maltrattamento e abuso
8.5.1. Contesto familiare
8.6. Disturbi di legame
8.6.1. La figura dell'attaccamento
8.7. Intervento nei disturbi sensoriali
8.7.1. Disturbi sensoriali
8.8. Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività
8.8.1. Comorbidità con altri disturbi
8.9. Sindromi minoritarie e malattie rare
8.9.1. Esclusioni e difficoltà sociali
8.10. Elaborazione di programmi di intervento
8.10.1. Strumenti di valutazione e intervento
Modulo 9. Sviluppo affettivo e sociale
9.1. Introduzione allo studio dello sviluppo affettivo e sociale
9.1.1. Introduzione
9.1.2. Teorie esplicative
9.1.3. Classificazione degli studi sullo sviluppo sociale
9.2. Inizio delle relazioni affettive
9.2.1. Condizioni necessarie per la formazione di un attaccamento
9.2.2. Guida per i genitori per migliorare l'interazione con un bambino disabile
9.2.3. La formazione del primo attaccamento
9.2.4. Componenti della relazione di attaccamento
9.2.5. Evoluzione dell'attaccamento durante l'infanzia
9.3. Sviluppo e evoluzione dell’attaccamento nell’infanzia
9.3.1. Teorie dello sviluppo affettivo
9.3.2. Lo sviluppo affettivo
9.3.3. Tipi di attaccamento
9.3.4. Lo sviluppo emotivo
9.4. Sviluppo dell'attaccamento dall'adolescenza all'età adulta
9.4.1. Attaccamento nell'adolescenza
9.4.2. Attaccamento nei giovani adulti
9.4.3. Attaccamento in adulti di mezza età e anziani
9.4.4. Differenze nell'attaccamento nella vita adulta
9.5. Sviluppo dell'identità personale
9.5.1. Lo sviluppo del concetto di sé
9.5.2. Autostima: la componente di valutazione del sé
9.5.3. Lo sviluppo dell’autocontrollo
9.5.4. Chi diventerò? Creare un'identità
9.5.5. L'altro lato della cognizione sociale: conoscere gli altri
9.6. Relazioni peer-to-peer
9.6.1. L'uguaglianza: una nuova esperienza sociale?
9.6.2. Relazioni tra fratelli da 2 a 6 anni di età
9.6.3. Interazioni sociali nel gioco, aggressività e prosocialità
9.6.4. Relazioni tra pari: amicizia
9.6.5. Gruppi di bambini e gerarchie di dominanza
9.6.6. I determinanti dell'esperienza sociale
9.7. Sviluppo sociale nell'adolescenza
9.7.1. Modello di cambiamento individuale: la teoria di Erikson
9.7.2. Autoconcetto e autostima
9.7.3. Relazioni familiari
9.7.4. Relazioni tra pari
9.8. Lo sviluppo morale
9.8.1. Cos'è lo sviluppo morale?
9.8.2. Pensiero morale
9.8.3. Comportamento morale
9.8.4. Sentimenti morali
9.8.5. Educazione morale
9.8.6. Valori, religione e sette
9.9. Promozione precoce dello sviluppo emotivo
9.9.1. Fattori che determinano il rendimento dei genitori
9.9.2. Modelli di intervento
9.9.3. Standard educativi per i genitori
9.10. Intervento di sviluppo sociale
9.10.1. Educazione familiare e competenza sociale
9.10.2. Valutazione della competenza sociale nei bambini piccoli
9.10.3. Sviluppo della competenza sociale in età prescolare
9.10.4. Procedure per sviluppare la competenza sociale nelle scuole della prima infanzia
9.10.5. Prevenzione del comportamento antisociale
Modulo 10. Tecniche di modifica del comportamento
10.1. Introduzione: Cos'è la modifica del comportamento?
10.1.1. Delimitazione della modifica del comportamento
10.1.2. Breve sviluppo storico della modifica del comportamento
10.1.3. Presupposti di base della modifica del comportamento
10.1.4. Correnti fondamentali nella modifica del comportamento
10.2. Valutazione comportamentale
10.2.1. Introduzione
10.2.2. Definire il comportamento
10.2.3. Registro del comportamento
10.2.4. Analisi del comportamento
10.3. Principi di apprendimento applicati alla modifica del comportamento
10.3.1. Introduzione
10.3.2. Definizione di rinforzo e punizione
10.3.3. Tipi di rinforzi
10.3.4. Il principio di Premack
10.3.5. Scelta dei rinforzi
10.3.6. Applicazioni Booster
10.3.7. Programmi di rafforzamento
10.4. Controllo delle contingenze (I): procedure per mantenere comportamenti
10.4.1. Semplici tecniche di contingenza (rinforzo, shaping, chaining e fading)
10.4.2. Sistemi di contingenza organizzati (contratti comportamentali, token economy)
10.4.3. Modellazione e addestramento delle abilità sociali
10.5. Controllo delle contingenze (II): procedure per ridurre i comportamenti
10.5.1. Estinzione
10.5.2. Rinforzo differenziale
10.5.3. Controllo stimolante
10.5.4. Costo di risposta
10.5.5. Time out
10.5.6. Saciazione
10.5.7. Sovracorrezione
10.5.8. Punizione positiva
10.5.9. Tecniche nascoste
10.5.10. Tecniche avversive.
10.6. Rilassamento muscolare e respirazione addominale
10.6.1. Introduzione: inquadrare le tecniche
10.6.2. Rilassamento muscolare progressivo
10.6.3. Respirazione addominale
10.7. Desensibilizzazione sistematica e le sue varianti
10.7.1. Desensibilizzazione sistematica
10.7.2. Desensibilizzazione dal vivo
10.7.3. Desensibilizzazione come tecnica di controllo
10.8. Tecniche di esposizione
10.8.1. Procedure di esposizione
10.8.2. Varianti e variabili coinvolte nell'esposizione
10.8.3. Conclusioni
10.9. Inoculazione dello stress e altre tecniche di coping
10.9.1. Introduzione
10.9.2. Procedura di inoculazione dello stress
10.9.3. Conclusioni
10.10. L'approccio della Terapia di Accettazione e Impegno
10.10.1. Introduzione
10.10.2. Presupposti filosofici e teorici
10.10.3. Elementi di terapia
10.10.4. Fasi della terapia
10.10.5. Applicazioni cliniche e valutazione

Il nostro programma di studio è stato progettato considerando l'efficacia dell'insegnamento: imparare più velocemente, in modo più efficiente e su una base permanente"
Master Privato in Psicologia dell'Educazione e della Salute
Se c'è una cosa che apprezziamo nella psicologia TECH, è il suo inestimabile valore interdisciplinare in quanto serve come approccio complementare ad aree come l'istruzione (sviluppando le teorie e le metodologie della pedagogia) o la salute (esplorando la patogenesi di diversi disturbi e malattie che hanno sfumature psicosomatiche). Alla luce di questa pluralità funzionale, la nostra istituzione ritiene molto utile affrontare tali aree, valorizzando così il ruolo degli psicologi nella società. Sulla base di ciò, ti offriamo il Master in Psicologia dell'Educazione e della Salute: un programma che cerca di aggiornare le conoscenze su argomenti come le teorie dell'apprendimento cognitivo e lo sviluppo neuropsicologico, oltre ad aggiungere nuove competenze nei disturbi del linguaggio, nella psicopatologia infantile e adolescenziale , tra altri aspetti degni di nota. La cosa migliore di questa formazione è che, essendo completamente virtuale, puoi laurearti senza uscire di casa, con flessibilità a tempo pieno, contenuti multimediali avanzati e un team di docenti con una vasta esperienza. Un'opportunità unica per migliorare il tuo curriculum che non troverai da nessun'altra parte.
Consegui una qualifica studiando Psicologia dell'Educazione e della Salute
Nessun ambiente merita il lavoro di uno psicologo tanto quanto un centro educativo. Dalle difficoltà di apprendimento, attraverso problemi di convivenza, a situazioni indesiderabili come il bullismo; Ogni linea guida, trattamento, progetto o dinamica che un professionista della salute mentale può associare al contesto scolastico rappresenta un contributo estremamente rafforzante ai legami scolastici e a un sano ambiente scolastico. Dedicato ad approfondire questa direzione, il nostro master esplora moduli come le neuroscienze, la psicologia dell'apprendimento, lo sviluppo affettivo e sociale, nonché le tecniche di modifica del comportamento tra cui la desensibilizzazione sistematica e la terapia dell'impegno di accettazione. Allo stesso modo, vengono rafforzate le abilità nell'affrontare disturbi mentali come l'autismo, la depressione o l'ansia. Vuoi sapere perché siamo la migliore università digitale del mondo? Iscriviti ora e prova tutti i vantaggi che abbiamo per te.