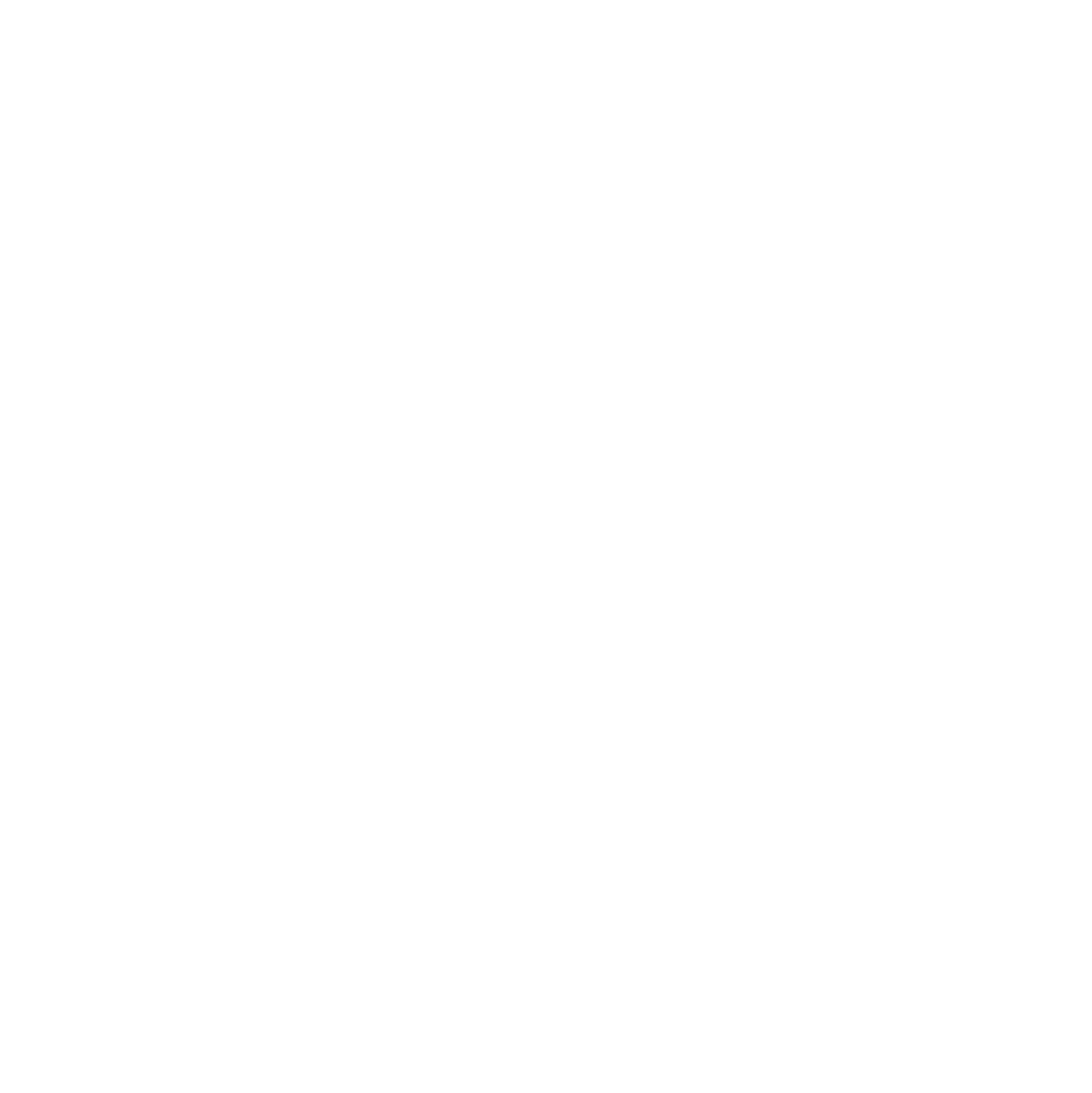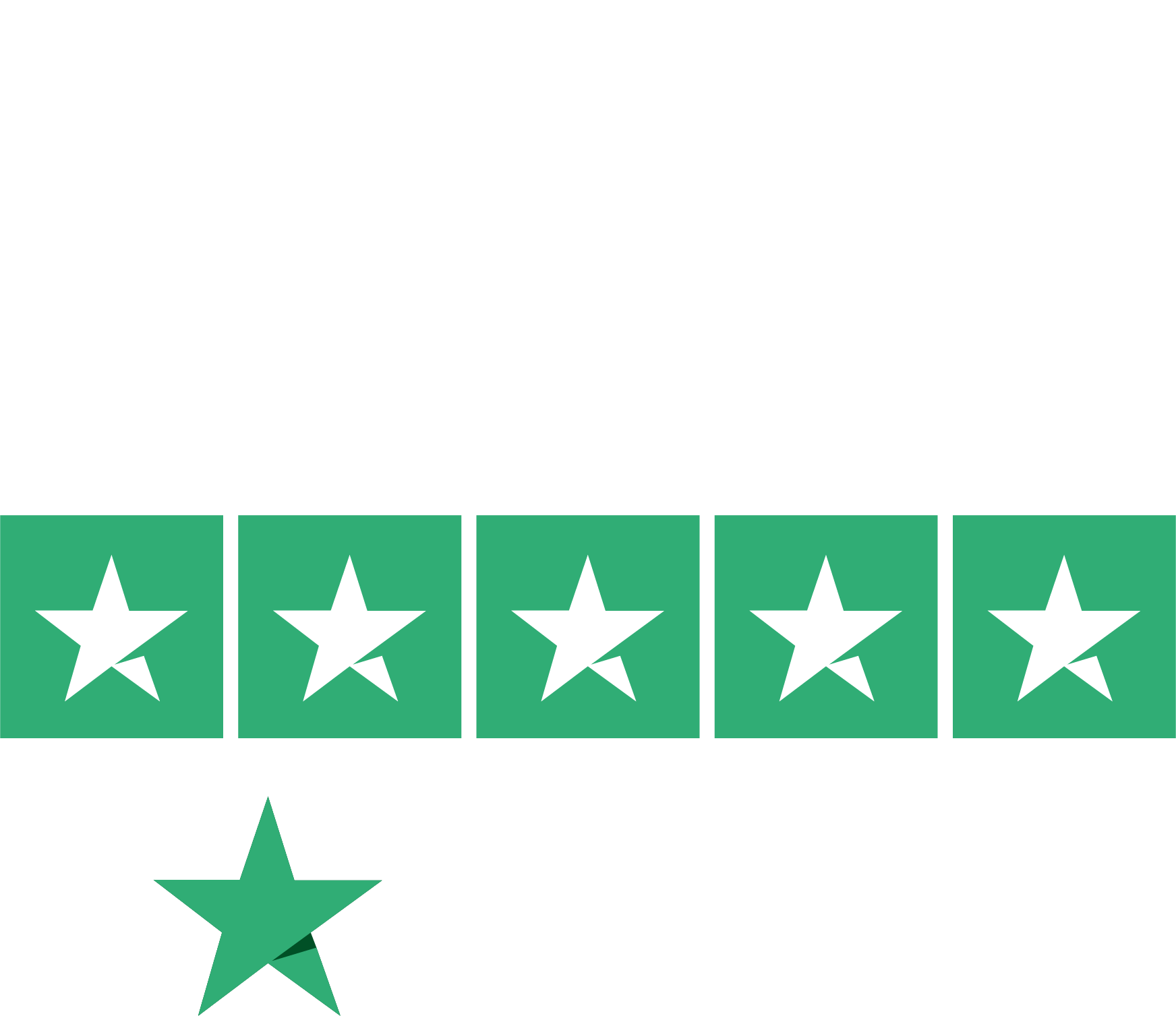Titolo universitario
La più grande facoltà di psicologia del mondo"
Presentazione
La conoscenza approfondita del neurosviluppo nelle sue molteplici implicazioni, in un programma completo, creato per proiettarti ad un alto livello professionale"

Il lavoro della Neuropsicologia in ambito Educativo è complesso e copre un ampio spettro di interventi che richiedono una preparazione molto specifica nelle varie branche dello sviluppo cerebrale. Questa disciplina, profondamente legata alla neurologia e allo studio fisiologico del cervello, risente dei cambiamenti che l'evoluzione delle conoscenze in questa branca scientifica comporta. Questo implica per il professionista la necessità di aggiornarsi costantemente, al fine di mantenersi all'avanguardia in termini di approccio, intervento e follow-up dei casi che possono presentarsi nella sua pratica.
Nel corso di questa specializzazione, lo studente passerà in rassegna tutti gli orientamenti attuali del lavoro del neuropsicologo nelle diverse sfide che la sua professione presenta.
Il funzionamento della memoria, il linguaggio, il rapporto tra lateralità e sviluppo cognitivo, la sensorialità e molti altri aspetti saranno i temi di lavoro e di studio che lo studente potrà integrare nella sua preparazione. Un percorso di studi di alto livello, che favorisce il processo di miglioramento, non solo professionale, ma anche personale dello studente.
Questa sfida è una di quelle che noi di TECH assumiamo come impegno sociale: aiutare i professionisti altamente qualificati a specializzarsi e a sviluppare le loro capacità personali, sociali e lavorative nel corso dei loro studi.
Non solo ti accompagneremo attraverso le conoscenze teoriche offerte, ma ti mostreremo un altro modo di studiare e imparare, più organico, semplice ed efficiente. Lavoreremo per mantenerti motivato e per trasmetterti la passione per l'apprendimento. Ti spingeremo a pensare e a sviluppare il pensiero critico.
Una specializzazione creata per i professionisti che aspirano all'eccellenza e che permetterà di acquisire nuove competenze e strategie in modo rapido ed efficace”
Questo Master privato in Neuropsicologia ed Educazione possiede il programma più completo e aggiornato sul mercato. Le caratteristiche principali del corso sono:
- Ultima tecnologia nel software di e-learning
- Sistema di insegnamento intensamente visivo, supportato da contenuti grafici e schematici di facile assimilazione e comprensione
- Sviluppo di casi di studio presentati da esperti attivi
- Sistemi di video interattivi di ultima generazione
- Insegnamento supportato dalla pratica online
- Sistemi di aggiornamento e riqualificazione permanente
- Apprendimento autoregolato: piena compatibilità con altre attività
- Esercizi pratici per l'autovalutazione e la verifica dell'apprendimento
- Gruppi di appoggio e sinergie educative: domande agli esperti, forum di discussione e conoscenza
- Comunicazione con l'insegnante e lavoro di riflessione individuale
- Sarai in grado di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, con connessione a internet
- Banche di documentazione complementare sempre disponibili, anche dopo il corso
Una profonda e completa immersione nelle strategie e negli approcci di Neuropsicologia ed Educazione”
Il nostro personale docente è composto da professionisti attivi. In questo modo ci assicuriamo di soddisfare l'obiettivo di aggiornamento educativo che ci prefiggiamo. Un team multidisciplinare di professionisti specializzati e con esperienza in diversi ambiti, che svilupperanno le conoscenze teoriche in maniera efficace, ma, soprattutto, metteranno al servizio del programma le conoscenze pratiche derivate dalla loro esperienza: una delle qualità differenziali di questo Master privato.
La padronanza della materia è completata dall'efficacia del design metodologico di questo programma. Sviluppato da un team multidisciplinare di esperti di e-learning, integra gli ultimi progressi della tecnologia educativa. In questo modo, potrai studiare con una serie di strumenti multimediali comodi e versatili, che ti daranno l'operatività di cui hai bisogno nella tua specializzazione.
La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi: un approccio che concepisce l'apprendimento come un processo eminentemente pratico. Per raggiungere questo obiettivo in modalità remota, useremo la telepratica, grazie all'aiuto di un innovativo sistema di video interattivi e al metodo Learning from an Expert, potrai acquisire le conoscenze come se stessi vivendo la situazione che è oggetto di apprendimento. Un concetto che permetterà di integrare e fissare l'apprendimento in modo più realistico e permanente.
I sistemi sensoriali dell'essere umano verranno studiati dal punto di vista del Neuropsicologo, con lo scopo di imparare a intervenire e migliorare"

Tutti i processi di base dello sviluppo cognitivo in relazione all'apprendimento e allo sviluppo scolastico, in una specializzazione intensiva e completa"
Programma
I contenuti di questa specializzazione sono stati sviluppati dai diversi professori di questo programma con uno scopo chiaro: fare in modo che i nostri studenti acquisiscano tutte le competenze necessarie per diventare veri esperti in questo campo.
I contenuti di questo Master privato permetteranno di apprendere tutti gli aspetti delle diverse discipline comprese in questo campo: un programma completo e ben strutturato che ti porterà ai più alti standard di qualità e successo.

Attraverso questo programma completo, sarai in grado di accedere alle conoscenze più avanzate del momento in materia di Neuropsicologia ed Educazione”
Modulo 1. Basi di neuroscienze
1.1. Il sistema nervoso e i neuroni
1.1.1. Introduzione
1.1.2. Sviluppi e ultimi approcci
1.2. Anatomia di base delle strutture legate all'apprendimento
1.2.1. Descrizione
1.2.2. Fisiologia dell'apprendimento
1.3. Processi psicologici legati all'apprendimento
1.3.1. Emozioni e apprendimento
1.3.2. Approcci emotivi
1.4. Le principali strutture cerebrali legate alla funzione motoria
1.4.1. Sviluppo del cervello e abilità motorie
1.4.2. Lateralità e sviluppo
1.5. Il cervello plastico e la neuroplasticità
1.5.1. Definizione di plasticità
1.5.2. Neuroplasticità e istruzione
1.6. Epigenetica
1.6.1. Definizione e origini
1.7. Gli effetti dell'ambiente sullo sviluppo del cervello
1.7.1. Teorie attuali
1.7.2. L'influenza dell'ambiente nello sviluppo del bambino
1.8. Cambiamenti nel cervello del bambino
1.8.1. Lo sviluppo del cervello nell'infanzia
1.8.2. Caratteristiche
1.9. L'evoluzione del cervello degli adolescenti
1.9.1. Lo sviluppo del cervello nell'adolescenza
1.9.2. Caratteristiche
1.10. Il cervello adulto
1.10.1. Caratteristiche del cervello adulto
1.10.2. Il cervello adulto e l'apprendimento
Modulo 2. Neuropsicologia dello sviluppo
2.1. Neuroscienze
2.1.1. Introduzione
2.1.2. Concetto di Neuroscienza
2.1.3. Neuromiti
2.2. Il cervello: struttura e funzionamento
2.2.1. Principali strutture cerebrali
2.2.2. Modello Trino
2.2.3. Modello Bilaterale
2.2.4. Cervello cognitivo e cervello emotivo
2.2.5. I neuroni
2.2.6. Cosa sono i neurotrasmettitori?
2.3. Neuroscienze e apprendimento
2.3.1. Cos'è l'apprendimento?
2.3.2. I neuroni a specchio
2.3.3. Livelli di apprendimento
2.3.4. Stili di apprendimento
2.3.5. Tipi di apprendimento
2.4. Intelligenze multipli
2.4.1. Definizione
2.4.2. Classificazione
2.4.3. Intelligenze multiple e neurodidattica
2.4.4. Intelligenze multiple in classe
2.4.5. Vantaggi e svantaggi nell’Educazione
2.5. Neuroscienza - Educazione
2.5.1. Neuroeducazione
2.5.2. La memoria
2.5.3. L'emozione
2.5.4. L’attenzione
2.5.5. Motivazione
2.5.6. Contributi della neurodidattica alle strategie di apprendimento
2.6. Neuroscienze in classe
2.6.1. La figura del neuroeducatore
2.6.2. Rilevanza neuro-educativa e neuro-pedagogica
2.6.3. Atteggiamento empatico e apprendimento
2.6.4. Applicazioni in classe
2.6.5. Organizzazione della classe
2.7. Il gioco e le nuove tecnologie
2.7.1. Etimologia del gioco
2.7.2. Benefici del gioco
2.7.3. Imparare attraverso il gioco
2.7.4. Il processo neurocognitivo
2.7.5. Principi di base dei giochi educativi
2.7.6. Neuroeducazione e giochi da tavolo
2.7.7. Tecnologia educativa e neuroscienze
2.7.8. Sviluppo delle funzioni esecutive
2.8. Corpo e cervello
2.8.1. La connessione tra corpo e cervello
2.8.2. Il cervello sociale
2.8.3. Come prepariamo il cervello all'apprendimento?
2.8.4. Alimentazione
2.8.5. Riposo e apprendimento
2.9. Le neuroscienze per prevenire l’abbandono scolastico
2.9.1. Benefici delle neuroscienze
2.9.2. Elementi per una pedagogia orientata al successo
2.9.3. Alcuni suggerimenti per migliorare il processo di apprendimento
2.10. Ragione ed emozione
2.10.1. Il binomio ragione-emozione
2.10.2. A cosa servono le emozioni?
2.10.3. Perché educare le emozioni in classe?
2.10.4. Apprendimento efficace attraverso le emozioni
Modulo 3. Neuroeducazione
3.1. Introduzione alla neuroeducazione
3.2. I principali neuromiti
3.3. L’attenzione
3.4. L'emozione
3.5. Motivazione
3.6. L’apprendimento
3.7. La memoria
3.8. Stimolazione e interventi precoci
3.9. L'importanza della creatività nella neuroeducazione
3.10. Metodologie che permettono la trasformazione dell'educazione in neuroeducazione
Modulo 4. Funzionalità visiva e uditiva per la lettura, il linguaggio, le lingue e l'apprendimento
4.1. Visione: funzionamento e basi neuropsicologiche
4.1.1. Introduzione
4.1.2. Sviluppo del sistema visivo alla nascita
4.1.3. Fattori di rischio
4.1.4. Sviluppo di altri sistemi sensoriali durante l'infanzia
4.1.5. Influenza della visione sul sistema visuo-motorio e il suo sviluppo
4.1.6. Visione normale e binoculare
4.1.7. Anatomia degli occhi umani
4.1.8. Funzioni dell'occhio
4.1.9. Altre funzioni
4.1.10. Vie visive alla corteccia cerebrale
4.1.11. Elementi che favoriscono la percezione visiva
4.1.12. Malattie e disturbi della vista
4.1.13. Disturbi o malattie degli occhi comuni: interventi in classe
4.1.14. Sindrome da visione artificiale (CVS)
4.1.15. Osservazione attitudinale dello studente
4.1.16. Riepilogo
4.1.17. Riferimenti bibliografici
4.2. Percezione visiva, valutazione e programmi di intervento
4.2.1. Introduzione
4.2.2. Sviluppo umano: lo sviluppo dei sistemi sensoriali
4.2.3. La percezione sensoriale
4.2.4. Il neurosviluppo
4.2.5. Descrizione del processo percettivo
4.2.6. La percezione del colore
4.2.7. Percezione e abilità visive
4.2.8. Valutazione della percezione visiva
4.2.9. Intervento per migliorare la percezione visiva
4.2.10. Riepilogo
4.2.11. Riferimenti bibliografici
4.3. Monitoraggio dei movimenti oculari
4.3.1. Introduzione
4.3.2. Movimenti oculari
4.3.3. Monitoraggio dei movimenti oculari
4.3.4. Registrazione e valutazione della motilità oculare
4.3.5. Disturbi della motilità oculare
4.3.6. Il sistema visivo e la lettura
4.3.7. Sviluppo di abilità nell'imparare a leggere
4.3.8. Programmi e attività di miglioramento e formazione
4.3.9. Riepilogo
4.3.10. Riferimenti bibliografici
4.4. Movimenti saccadici e la loro implicazione nella lettura
4.4.1. Introduzione
4.4.2. Modelli del processo di lettura
4.4.3. Movimenti saccadici e loro implicazione nella lettura
4.4.4. Come vengono valutati i movimenti saccadici?
4.4.5. Il processo di lettura visiva
4.4.6. La memoria visiva nel processo di lettura
4.4.7. Ricerca per studiare la relazione tra la memoria visiva e la lettura
4.4.8. Difficoltà della lettura
4.4.9. Insegnanti specializzati
4.4.10. Educatori sociali
4.4.11. Riepilogo
4.4.12. Riferimenti bibliografici
4.5. Accomodamento visivo e la sua relazione con la postura in classe
4.5.1. Introduzione
4.5.2. Meccanismi che permettono l'accomodamento o la focalizzazione
4.5.3. Come si valuta l'accomodamento visivo?
4.5.4. Postura del corpo in classe
4.5.5. Programmi di formazione per l'accomodamento visivo
4.5.6. Aiuti per gli alunni ipovedenti
4.5.7. Riepilogo
4.5.8. Riferimenti bibliografici
4.6. Struttura e funzione dell'orecchio
4.6.1. Introduzione
4.6.2. Il mondo del suono
4.6.3. Il suono e la sua propagazione
4.6.4. I recettori uditivi
4.6.5. Struttura dell'orecchio
4.6.6. Sviluppo del sistema uditivo dalla nascita
4.6.7. Sviluppo dei sistemi sensoriali durante l'infanzia
4.6.8. Influenza dell'udito sullo sviluppo dell'equilibrio
4.6.9. Malattie dell'orecchio
4.6.10. Riepilogo
4.6.11. Riferimenti bibliografici
4.7. Percezione uditiva
4.7.1. Introduzione
4.7.2. Linee guida per individuare i problemi di percezione uditiva
4.7.3. Il processo percettivo
4.7.4. Ruolo delle vie uditive nei processi percettivi
4.7.5. Bambini con percezione uditiva compromessa
4.7.6. Test di valutazione
4.7.7. Riepilogo
4.7.8. Riferimenti bibliografici
4.8. Valutazione dell'udito e dei danni all'udito
4.8.1. Introduzione
4.8.2. Valutazione del canale uditivo esterno
4.8.3. Otoscopia
4.8.4. Audiometria ad aria
4.8.5. Udito a conduzione ossea
4.8.6. Curva di soglia del disagio
4.8.7. Audiometria tonale, audiometria vocale e acusometria
4.8.8. Disturbi dell'udito: gradi e tipi di perdita dell'udito
4.8.9. Cause della perdita dell'udito
4.8.10. Aspetti psicobiologici della perdita dell'udito
4.8.11. Riepilogo
4.8.12. Riferimenti bibliografici
4.9. Udito e sviluppo dell'apprendimento
4.9.1. Introduzione
4.9.2. Sviluppo dell'orecchio umano
4.9.3. Programmi, attività e giochi per lo sviluppo uditivo dei bambini
4.9.4. Metodo Berard
4.9.5. Metodo Tomatis
4.9.6. Salute della vista e dell'udito
4.9.7. Adattamenti di elementi curricolari
4.9.8. Riepilogo
4.9.10. Riferimenti bibliografici
4.10. Processi visivi e uditivi coinvolti nella lettura
4.10.1. Introduzione
4.10.2. Monitoraggio dei movimenti oculari
4.10.3. Il sistema visivo e la lettura
4.10.4. Dislessia
4.10.5. Terapie basate sul colore per la dislessia
4.10.6. Ausili per la disabilità visiva
4.10.7. Riepilogo
4.10.8. Riferimenti bibliografici
4.11. Relazione tra visione e udito nel linguaggio
4.11.1. Introduzione
4.11.2. Relazione tra vista e udito
4.11.3. Elaborazione dell'informazione verbale-uditiva e visiva
4.11.4. Programmi d'intervento per i disturbi dell'udito
4.11.5. Linee guida per gli insegnanti
4.11.6. Riepilogo
4.11.7. Riferimenti bibliografici
Modulo 5. Abilità motorie, lateralità e scrittura
5.1. Sviluppo neurologico e apprendimento
5.1.1. Introduzione
5.1.2. Sviluppo percettivo
5.1.3. Basi neuropsicologiche dello sviluppo motorio
5.1.4. Sviluppo della lateralità
5.1.5. Comunicazione interemisferica attraverso il corpo calloso
5.1.6. Ambidestria
5.1.7. Riepilogo
5.1.8. Riferimenti bibliografici
5.2. Sviluppo psicomotorio
5.2.1. Introduzione
5.2.2. Psicomotricità grossolana
5.2.3. Coordinazione dinamica generale: abilità di base
5.2.4. Motricità fine e la sua relazione con la scrittura
5.2.5. Valutazione dello sviluppo psicomotorio
5.2.6. Riepilogo
5.2.7. Riferimenti bibliografici
5.3. Neuropsicologia dello sviluppo motorio
5.3.1. Introduzione
5.3.2. Rapporto tra motricità e psiche
5.3.3. Disturbi dello sviluppo motorio
5.3.4. Disturbi dell'acquisizione della coordinazione
5.3.5. Disturbi del sistema vestibolare
5.3.6. La scrittura
5.3.7. Riepilogo
5.3.8. Riferimenti bibliografici
5.4. Introduzione allo sviluppo della lateralità
5.4.1. Introduzione
5.4.2. Test di lateralità
5.4.3. Linee guida di osservazione per gli insegnanti
5.4.4. Lateralità trasversale
5.4.5. Tipi di lateralità incrociata
5.4.6. Relazione tra dislessia e lateralità
5.4.7. Relazione tra lateralità e problemi di attenzione, memoria e iperattività
5.4.8. Riepilogo
5.4.9. Riferimenti bibliografici
5.5. Sviluppo della lateralità a diverse età
5.5.1. Introduzione
5.5.2. Sviluppo della lateralità a diverse età
5.5.3. Tipi di lateralità
5.5.4. Corpo calloso
5.5.5. Gli emisferi cerebrali
5.5.6. Sviluppo degli stadi prelaterale, controlaterale e laterale
5.5.7. Riepilogo
5.5.8. Riferimenti bibliografici
5.6. Disturbi motori e difficoltà di apprendimento correlate
5.6.1. Introduzione
5.6.2. Disturbi motori
5.6.3. Difficoltà di apprendimento
5.6.4. Riepilogo
5.6.5. Riferimenti bibliografici
5.7. Processo e acquisizione della scrittura
5.7.1. Introduzione
5.7.2. Imparare a leggere
5.7.3. Problemi di comprensione che gli studenti possono sviluppare
5.7.4. Sviluppo evolutivo della scrittura
5.7.5. Storia della scrittura
5.7.6. Basi neuropsicologiche della scrittura
5.7.7. Insegnare a scrivere
5.7.8. Metodi di insegnamento della scrittura
5.7.9. Laboratori di scrittura
5.7.10. Riepilogo
5.7.11. Riferimenti bibliografici
5.8. Disgrafia
5.8.1. Introduzione
5.8.2. Stili di apprendimento
5.8.3. Funzioni esecutive coinvolte nell'apprendimento
5.8.4. Definizione di disgrafia e tipologie
5.8.5. Indicatori comuni di disgrafia
5.8.6. Ausili in classe per studenti con disgrafia
5.8.7. Ausili individuali
5.8.8. Riepilogo
5.8.9. Riferimenti bibliografici
5.9. Il contributo della lateralità allo sviluppo della lettura e della scrittura
5.9.1. Introduzione
5.9.2. Importanza della lateralità nel processo di apprendimento
5.9.3. Lateralità nel processo di lettura e scrittura
5.9.4. Lateralità e difficoltà di apprendimento
5.9.5. Riepilogo
5.9.6. Riferimenti bibliografici
5.10. Il ruolo dello psicologo scolastico e dei consulenti per l'orientamento nella prevenzione, nello sviluppo e nell'educazione dei bambini
5.10.1. Introduzione
5.10.2. Dipartimento di orientamento
5.10.3. Programmi di intervento
5.10.4. Progressi della neuropsicologia sulle difficoltà di apprendimento
5.10.5. Formazione del team docenti
5.10.6. Riepilogo
5.10.7. Riferimenti bibliografici
5.11. Guida per i genitori
5.11.1. Come informare i genitori?
5.11.2. Attività per migliorare il rendimento scolastico
5.11.3. Attività per migliorare lo sviluppo laterale
5.11.4. Strategie per la risoluzione dei problemi
5.11.5. Riepilogo
5.11.6. Riferimenti bibliografici
5.12. Valutazione e interventi psicomotori
5.12.1. Introduzione
5.12.2. Sviluppo psicomotorio
5.12.3. Valutazione psicomotoria
5.12.4. Intervento psicomotorio
5.12.5. Riepilogo
5.12.6. Riferimenti bibliografici
Modulo 6. Metodologia della ricerca
6.1. Metodologia di ricerca
6.1.1. Introduzione
6.1.2. L'importanza della metodologia di ricerca
6.1.3. La conoscenza scientifica
6.1.4. Approcci di ricerca
6.1.5. Riepilogo
6.1.6. Riferimenti bibliografici
6.2. Scelta dell'argomento di ricerca
6.2.1. Introduzione
6.2.2. Il problema di ricerca
6.2.3. Definizione del problema
6.2.4. Scelta della domanda di ricerca
6.2.5. Obiettivi di ricerca
6.2.6. Variabili: tipi
6.2.7. Riepilogo
6.2.8. Riferimenti bibliografici
6.3. La proposta di ricerca
6.3.1. Introduzione
6.3.2. Le ipotesi della ricerca
6.3.3. Fattibilità del progetto di ricerca
6.3.4. Introduzione e giustificazione della ricerca
6.3.5. Riepilogo
6.3.6. Riferimenti bibliografici
6.4. Il quadro teorico
6.4.1. Introduzione
6.4.2. Elaborazione del quadro teorico
6.4.3. Risorse utilizzate
6.4.4. Standard APA
6.4.5. Riepilogo
6.4.6. Riferimenti bibliografici
6.5. Bibliografia
6.5.1. Introduzione
6.5.2. Importanza dei riferimenti bibliografici
6.5.3. Come fare riferimenti secondo gli standard APA?
6.5.4. Formato degli allegati: tabelle e figure
6.5.5. Gestori di bibliografia: cosa sono? e come usarli?
6.5.6. Riepilogo
6.5.7. Riferimenti bibliografici
6.6. Quadro metodologico
6.6.1. Introduzione
6.6.2. Tabella di marcia
6.6.3. Sezioni da contenere nel quadro metodologico
6.6.4. La popolazione
6.6.5. La mostra
6.6.6. Variabili
6.6.7. Strumenti
6.6.8. Procedura
6.6.9. Riepilogo
6.6.10. Riferimenti bibliografici
6.7. Disegni di Ricerca
6.7.1. Introduzione
6.7.2. Tipi di design
6.7.3. Caratteristiche dei disegni utilizzati in psicologia
6.7.4. Disegni di ricerca usati nell'educazione
6.7.5. Disegni di ricerca utilizzati in neuropsicologia educativa
6.7.6. Riepilogo
6.7.7. Riferimenti bibliografici
6.8. Ricerca quantitativa
6.8.1. Introduzione
6.8.2. Disegni randomizzati a grappolo
6.8.3. Disegni a gruppi randomizzati con blocchi
6.8.4. Altri disegni utilizzati in psicologia
6.8.5. Tecniche statistiche nella ricerca quantitativa
6.8.6. Riepilogo
6.8.7. Riferimenti bibliografici
6.9. Ricerca quantitativa II
6.9.1. Introduzione
6.9.2. Disegni unificati intrasoggetto
6.9.3. Tecniche di controllo degli effetti dei disegni intrasoggetto
6.9.4. Tecniche statistiche
6.9.5. Riepilogo
6.9.6. Riferimenti bibliografici
6.10. Risultati
6.10.1. Introduzione
6.10.2. Come raccogliere i dati?
6.10.3. Come analizzare i dati?
6.10.4. Programmi statistici
6.10.5. Riepilogo
6.10.6. Riferimenti bibliografici
6.11. Statistica descrittiva
6.11.1. Introduzione
6.11.2. Variabili nella ricerca
6.11.3. Analisi quantitativa
6.11.4. Analisi qualitativa
6.11.5. Risorse che possono essere utilizzate
6.11.6. Riepilogo
6.11.7. Riferimenti bibliografici
6.12. Test delle ipotesi
6.12.1. Introduzione
6.12.2. Ipotesi statistiche
6.12.3. Come interpretare la significatività (p-value)?
6.12.4. Criteri per l'analisi dei test parametrici e non parametrici
6.12.5. Riepilogo
6.12.6. Riferimenti bibliografici
6.13. Statistiche di correlazione e analisi dell'indipendenza
6.13.1. Introduzione
6.13.2. Correlazione di Pearson
6.13.3. Correlazione di Spearman e chi-quadro
6.13.4. Risultati
6.13.5. Riepilogo
6.13.6. Riferimenti bibliografici
6.14. Statistiche di confronto tra gruppi
6.14.1. Introduzione
6.14.2. Test T di Mann-Whitney e test U di Mann-Whitney
6.14.3. T-test e Wilcoxon Signed Ranges
6.14.4. I risultati
6.14.5. Riepilogo
6.14.6. Riferimenti bibliografici
6.15. Discussione e conclusioni
6.15.1. Introduzione
6.15.2. Qual è la discussione
6.15.3. Organizzazione della discussione
6.15.4. Conclusioni
6.15.5. Limiti e previsioni
6.15.6. Riepilogo
6.15.7. Riferimenti bibliografici
6.16. Preparazione della tesi di master
6.16.1. Introduzione
6.16.2. Copertina e indice
6.16.3. Introduzione e giustificazione
6.16.4. Quadro teorico
6.16.5. Quadro metodologico
6.16.6. I risultati
6.16.7. Programmi di intervento
6.16.8. Discussione e conclusioni
6.16.9. Riepilogo
6.16.10. Riferimenti bibliografici
Modulo 7. Intelligenze multiple, creatività, talento e alte capacità
7.1. Teoria delle intelligenze multiple
7.1.1. Introduzione
7.1.2. Contesto
7.1.3. Concettualizzazione
7.1.4. Convalida
7.1.5. Premesse e principi di base delle teorie
7.1.6. Scienze neuropsicologiche e cognitive
7.1.7. Classificazione delle teorie delle intelligenze multiple
7.1.8. Riepilogo
7.1.9. Riferimenti bibliografici
7.2. Tipi di intelligenze multipli
7.2.1. Introduzione
7.2.2. Tipi di intelligenza
7.2.3. Riepilogo
7.2.4. Riferimenti bibliografici
7.3. Valutazione delle intelligenze multiple
7.3.1. Introduzione
7.3.2. Contesto
7.3.3. Tipi di valutazioni
7.3.4. Aspetti da tenere presenti nella valutazione
7.3.5. Riepilogo
7.3.6. Riferimenti bibliografici
7.4. Creatività
7.4.1. Introduzione
7.4.2. Concetti e teorie di creatività
7.4.3. Approcci allo studio della creatività
7.4.4. Caratteristiche del pensiero creativo
7.4.5. Tipi di creatività
7.4.6. Riepilogo
7.4.7. Riferimenti bibliografici
7.5. Basi neuropsicologiche della creatività
7.5.1. Introduzione
7.5.2. Contesto
7.5.3. Caratteristiche delle persone creative
7.5.4. Prodotti creativi
7.5.5. Basi neuropsicologiche della creatività
7.5.6. Influenza dell'ambiente e del contesto sulla creatività
7.5.7. Riepilogo
7.5.8. Riferimenti bibliografici
7.6. Creatività nel contesto educativo
7.6.1. Introduzione
7.6.2. Creatività in classe
7.6.3. Fasi del processo creativo
7.6.4. Come lavorare sulla creatività?
7.6.5. Relazione tra creatività e pensiero
7.6.6. Cambiamenti nel contesto educativo
7.6.7. Riepilogo
7.6.8. Riferimenti bibliografici
7.7. Metodologie per lo sviluppo della creatività
7.7.1. Introduzione
7.7.2. Programmi per lo sviluppo della creatività
7.7.3. Progetti per lo sviluppo della creatività
7.7.4. Promozione della creatività nel contesto familiare
7.7.5. Riepilogo
7.7.6. Riferimenti bibliografici
7.8. Valutazione della creatività e orientamenti
7.8.1. Introduzione
7.8.2. Considerazioni sulla valutazione
7.8.3. Test di valutazione
7.8.4. Test soggettivi di valutazione
7.8.5. Orientamenti sulla valutazione
7.8.6. Riepilogo
7.8.7. Riferimenti bibliografici
7.9. Grandi capacità e talenti
7.9.1. Introduzione
7.9.2. Relazione tra talento e alta abilità
7.9.3. Relazione tra eredità e ambiente
7.9.4. Fondamenti in neuropsicologia
7.9.5. Modelli di talento
7.9.6. Riepilogo
7.9.7. Riferimenti bibliografici
7.10. Identificazione e diagnosi di abilità elevate
7.10.1. Introduzione
7.10.2. Principali caratteristiche
7.10.3. Come identificare le alte capacità?
7.10.4. Ruolo degli attori coinvolti
7.10.5. Test e strumenti di valutazione
7.10.6. Programmi di intervento
7.10.7. Riepilogo
7.10.8. Riferimenti bibliografici
7.11. Problemi e difficoltà
7.11.1. Introduzione
7.11.2. Problemi e difficoltà a scuola
7.11.3. Miti e credenze
7.11.4. Dyssynchronies
7.11.5. Diagnosi differenziale
7.11.6. Differenze di genere
7.11.7. Necessità educative
7.11.8. Riepilogo
7.11.9. Riferimenti bibliografici
7.12. Relazione tra intelligenze multiple, alte capacità, talento e creatività
7.12.1. Introduzione
7.12.2. Relazione tra intelligenze multiple e creatività
7.12.3. Relazione tra intelligenze multiple, alte capacità e talenti
7.12.4. Differenze tra talento e alte capacità
7.12.5. Creatività, alte capacità e talento
7.12.6. Riepilogo
7.12.7. Riferimenti bibliografici
7.13. Orientamenti e sviluppo delle intelligenze multiple
7.13.1. Introduzione
7.13.2. Consigli agli insegnanti
7.13.3. Sviluppo multidimensionale degli alunni
7.13.4. Arricchimento del curriculum
7.13.5. Strategie a diversi livelli educativi
7.13.6. Riepilogo
7.13.7. Riferimenti bibliografici
7.14. Creatività nella risoluzione dei problemi
7.14.1. Introduzione
7.14.2. Modelli del processo creativo come risoluzione di problemi
7.14.3. Sviluppo di progetti creativi
7.14.4. Riepilogo
7.14.5. Riferimenti bibliografici
7.15. Risposta educativa e sostegno alla famiglia
7.15.1. Introduzione
7.15.2. Linee guida per gli insegnanti
7.15.3. Risposta educativa nella scuola materna
7.15.4. Risposta educativa nella scuola primaria
7.15.5. Risposta educativa nella scuola secondaria
7.15.6. Coordinamento con le famiglie
7.15.7. Realizzazione di programmi
7.15.8. Riepilogo
7.15.9. Riferimenti bibliografici
Modulo 8. Dislessia, discalculia e iperattività
8.1. Concettualizzazione della dislessia
8.1.1. Introduzione
8.1.2. Definizione
8.1.3. Basi neurofisiologiche
8.1.4. Caratteristiche
8.1.5. Sottotipi
8.1.6. Riepilogo
8.1.7. Riferimenti bibliografici
8.2. Valutazione neuropsicologica della dislessia
8.2.1. Introduzione
8.2.2. Criteri diagnostici della dislessia
8.2.3. Come valutare?
8.2.4. Colloquio con il tutor
8.2.5. Lettura e scrittura
8.2.6. Valutazione neuropsicologica
8.2.7. Valutazione di altri aspetti correlati
8.2.8. Riepilogo
8.2.9. Riferimenti bibliografici
8.3. Intervento neuropsicologico della dislessia
8.3.1. Introduzione
8.3.2. Variabili coinvolte
8.3.2. Ambito neuropsicologico
8.3.3. Programmi di intervento
8.3.4. Riepilogo
8.3.5. Riferimenti bibliografici
8.4. Concettualizzazione della discalculia
8.4.1. Introduzione
8.4.2. Definizione di discalculia
8.4.3. Caratteristiche
8.4.4. Basi neurofisiologiche
8.4.5. Riepilogo
8.4.6. Riferimenti bibliografici
8.5. Valutazione neuropsicologica della discalculia
8.5.1. Introduzione
8.5.2. Obiettivi della valutazione
8.5.3. Come valutare?
8.5.4. Relazione
8.5.5. Diagnosi
8.5.6. Riepilogo
8.5.7. Riferimenti bibliografici
8.6. Intervento neuropsicologico per la discalculia
8.6.1. Introduzione
8.6.2. Variabili coinvolte nel trattamento
8.6.3. Riabilitazione neuropsicologica
8.6.4. ntervento di discalculia
8.6.5. Riepilogo
8.6.6. Riferimenti bibliografici
8.7. Concettualizzazione dell'ADHD
8.7.1. Introduzione
8.7.2. Definizione di ADHD
8.7.3. Basi neurofisiologiche
8.7.4. Caratteristiche dei bambini con ADHD
8.7.5. Sottotipi
8.7.6. Riepilogo
8.7.7. Riferimenti bibliografici
8.8. Valutazione neuropsicologica di ADHD
8.8.1. Introduzione
8.8.2. Obiettivi della valutazione
8.8.3. Come valutare?
8.8.4. Relazione
8.8.5. Diagnosi
8.8.6. Riepilogo
8.8.7. Riferimenti bibliografici
8.9. Intervento neuropsicologico di ADHD
8.9.1. Introduzione
8.9.2. Ambito neuropsicologico
8.9.3. Trattamento di ADHD
8.9.4. Altre terapie
8.9.5. Programmi di intervento
8.9.6. Riepilogo
8.9.7. Riferimenti bibliografici
8.10. Comorbilità nei disturbi del neurosviluppo
8.10.1. Introduzione
8.10.2. Disturbi del neurosviluppo
8.10.3. Dislessia e discalculia
8.10.4. Dislessia e ADHD
8.10.5. Discalculia e ADHD
8.10.6. Riepilogo
8.10.7. Riferimenti bibliografici
8.11. Neurotecnologia
8.11.1. Introduzione
8.11.2. Applicata alla dislessia
8.11.3. Applicata alla discalculia
8.11.4. Applicato all'ADHD
8.11.5. Riepilogo
8.11.6. Riferimenti bibliografici
8.12. Orientamento per genitori e insegnant
8.12.1. Introduzione
8.12.2. Orientamento sulla dislessia
8.12.3. Orientamento sulla discalculia
8.12.4. Orientamento sull’all'ADHD
8.12.5. Riepilogo
8.12.6. Riferimenti bibliografici
Modulo 9. Processi neurolinguistici, difficoltà e programmi di intervento
9.1. Basi neurobiologiche coinvolte nel linguaggio
9.1.1. Introduzione
9.1.2. Definizioni del linguaggio
9.1.3. Antecedenti Storici
9.1.4. Riepilogo
9.1.5. Riferimenti bibliografici
9.2. Sviluppo del linguaggio
9.2.1. Introduzione
9.2.2. Emergenza del linguaggio
9.2.3. Acquisizione del linguaggio
9.2.4. Riepilogo
9.2.5. Riferimenti bibliografici
9.3. Approcci neuropsicologici al linguaggio
9.3.1. Introduzione
9.3.2. Processi cerebrali del linguaggio
9.3.3. Aree cerebrali coinvolte
9.3.4. Processi neurolinguistici
9.3.5. Centri cerebrali coinvolti nella comprensione
9.3.6. Riepilogo
9.3.7. Riferimenti bibliografici
9.4. Neuropsicologia della comprensione del linguaggio
9.4.1. Introduzione
9.4.2. Aree cerebrali coinvolti nella comprensione
9.4.3. I suoni
9.4.4. Strutture sintattiche per la comprensione della lingua
9.4.5. Processi semantici e apprendimento significativo
9.4.6. Comprensione della lettura
9.4.7. Riepilogo
9.4.8. Riferimenti bibliografici
9.5. Comunicazione attraverso il linguaggio
9.5.1. Introduzione
9.5.2. Il linguaggio come strumento di comunicazione
9.5.3. Evoluzione del linguaggio
9.5.4. La comunicazione sociale
9.5.5. Riepilogo
9.5.6. Riferimenti bibliografici
9.6. I disturbi del linguaggio
9.6.1. Introduzione
9.6.2. Disturbi del linguaggio e della parola
9.6.3. Professionisti coinvolti nel trattamento
9.6.4. Implicazioni in classe
9.6.5. Riepilogo
9.6.6. Riferimenti bibliografici
9.7. Afasia
9.7.1. Introduzione
9.7.2. Tipi di afasia
9.7.3. Diagnosi
9.7.4. Valutazione
9.7.5. Riepilogo
9.7.6. Riferimenti bibliografici
9.8. Stimolazione del linguaggio
9.8.1. Introduzione
9.8.2. Importanza della stimolazione del linguaggio
9.8.3. Stimolazione fonetico-fonologica
9.8.4. Stimolazione lessico-semantica
9.8.5. Stimolazione morfosintattica
9.8.6. Stimolazione pragmatica
9.8.7. Riepilogo
9.8.8. Riferimenti bibliografici
9.9. Disturbi della lettura e della scrittura
9.9.1. Introduzione
9.9.2. Lettura tardiva
9.9.3. Dislessia
9.9.4. Disortografia
9.9.5. Disgrafia
9.9.6. Dislalia
9.9.7. Trattamento dei disturbi di lettura e scrittura
9.9.8. Riepilogo
9.9.9. Riferimenti bibliografici
9.10. Valutazione e diagnosi delle difficoltà linguistiche
9.10.1. Introduzione
9.10.2. Valutazione del linguaggio
9.10.3. Procedure di valutazione del linguaggio
9.10.4. Test psicologici per la valutazione del linguaggio
9.10.5. Riepilogo
9.10.6. Riferimenti bibliografici
9.11. Interventi nei disturbi del linguaggio
9.11.1. Introduzione
9.11.2. Attuazione di programmi di miglioramento
9.11.3. Programmi di miglioramento
9.11.4. Programmi di miglioramento con le nuove tecnologie
9.11.5. Riepilogo
9.11.6. Riferimenti bibliografici
9.12. Impatto delle difficoltà linguistiche sul rendimento scolastico
9.12.1. Introduzione
9.12.2. Processi linguistici
9.12.3. Incidenza dei disturbi del linguaggio
9.12.4. Relazione tra udito e linguaggio
9.12.5. Riepilogo
9.12.6. Riferimenti bibliografici
9.13. Guida per genitori e insegnanti
9.13.1. Introduzione
9.13.2. Stimolazione del linguaggio
9.13.3. Stimolazione della lettura
9.13.4. Riepilogo
9.13.5. Riferimenti bibliografici
Modulo 10. Alternative educative emergenti per la gestione delle difficoltà di apprendimento
10.1. Introduzione
10.2. Le Tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC)
10.2.1. Fondamenti teorici delle tecnologie di informazione e comunicazione
10.2.2. Sviluppo storico delle TIC
10.2.3. Classificazione delle TIC
10.2.3.1. Sincrone
10.2.3.2. Asincrone
10.2.4. Caratteristiche TIC
10.2.5. Potenzialità delle TIC in vari contesti sociali
10.3. Le TIC nei contesti educativi
10.3.1. Contributo delle TIC all'istruzione in generale
10.3.1.1. L'educazione tradizionale e l'integrazione delle TIC
10.3.1.2. L'impatto delle TIC sull'istruzione nel XXI secolo
10.3.1.3. Apprendimento e insegnamento con le TIC: aspettative, realtà e potenzialità
10.3.2. Contributi delle TIC nell'affrontare le difficoltà di apprendimento
10.3.2.1. Le TIC come risorsa educativa per affrontare le difficoltà di apprendimento
10.3.2.1.1. Insegnamento della lettura
10.3.2.1.2. Insegnamento della scrittura
10.3.2.1.3. Insegnamento della matematica
10.3.2.1.4. Attenzione al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)
10.3.3. Ruolo dell'insegnante nell'uso delle TIC
10.3.3.1. In classe
10.3.3.2. Spazi al di fuori dell'aula
10.4. Gli scacchi e il loro valore pedagogico
10.4.1. Breve storia degli scacchi
10.4.2. Il loro carattere ricreativo
10.4.3. Fondamenti pedagogici della scienza del gioco
10.4.4. Gli scacchi come strumento educativo: nel contesto scolastico e in ambienti socialmente vulnerabili
10.4.5. Potenzialità degli scacchi per il processo di insegnamento-apprendimento degli studenti con difficoltà di apprendimento
10.4.5.1. Contributo degli scacchi all'attività cognitiva
10.4.5.1.1. Attenzione
10.4.5.1.2. Memoria
10.4.5.1.3. Motivazione
10.4.5.1.4. Gestione delle emozioni
10.4.5.1.5. Pensieri strategici
10.4.5.1.6. Intelligenza
10.4.5.1.7. Trasferimento dell'apprendimento
10.4.5.2. Contributi degli scacchi nel contesto delle funzioni esecutive
10.4.5.2.1. Organizzazione
10.4.5.2.2. Pianificazione
10.4.5.2.3. Esecuzione (flessibilità, controllo inibitorio, autocontrollo)
10.4.5.2.4. Valutazione/Revisione
10.5. Gli scacchi come elemento di collegamento della triade scuola-famiglia-comunità nella gestione delle difficoltà di apprendimento
10.5.1. Punti di forza dell'uso degli scacchi a scuola per promuovere la partecipazione delle famiglie al processo educativo
10.5.2. Possibilità offerte dagli scacchi per promuovere la partecipazione della comunità alla scuola
10.6. La meditazione dalla pratica spirituale alla sua attuale espansione
10.6.1. Un breve approccio alla meditazione come strumento educativo
10.6.1.1. Concetto di meditazione
10.6.1.2. Origine della meditazione
10.6.1.3. La sua diffusione in vari campi
10.7. Potenziale educativo della meditazione per la gestione delle difficoltà di apprendimento e l'attenzione alla diversità
10.7.1. Prove scientifiche degli effetti della meditazione sul corpo, sul cervello e sulle relazioni interpersonali
10.7.1.1. Effetti neurologici: effetti strutturali, biochimici e funzionali nel cervello
10.7.1.2. Effetti psicologici
10.7.1.3. Effetti fisici
10.7.2. Impatto della pratica della meditazione sui bambini in età scolare
10.7.3. Impatto della meditazione sulle modalità di azione dell'insegnante
10.7.4. Impatto della pratica della meditazione sul clima scolastico
10.8. Attività per l'integrazione delle conoscenze e la loro applicazione pratica
10.9. Letture consigliate
10.10. Bibliografia

Una specializzazione completa che ti fornirà le conoscenze necessarie per competere con i migliori”
Master Privato in Neuropsicologia ed Educazione
Le neuroscienze sono state a lungo collegate alla pratica psicologica a causa della loro immersione nel comportamento umano da nuove prospettive. Che si tratti di chiarire le basi congenite dei diversi disturbi mentali e psicomotori o di sviluppare nuovi modelli teorico-pratici che facilitino l'apprendimento, lo studio del cervello è di inestimabile aiuto nel campo della psiche. Volendo ottenere il massimo da tali approcci, TECH Università Tecnologica ha ideato il Master in Neuropsicologia ed Educazione: un complemento ottimale per tutto il personale che desidera fornire una nuova direzione ai paradigmi psicoterapeutici, cercando così di migliorare i processi educativi del bambino popolazione e giovani. Grazie al nostro format completamente online, potrai acquisire competenze di intervento psicosociale uniche in comode classi autogestite secondo la tua disponibilità di tempo e accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a internet. L'ampio contenuto multimediale basato sull'analisi di casi clinici e la metodologia Relearning che guida il mercato dell'istruzione superiore contemporanea ti aiuteranno a trasformare la visione delle nuove generazioni ed eccellere sul lavoro.
Specializzati online come neuropsicologo ed educatore
Sia la percezione del mondo che gli stati d'animo risultanti da tali interazioni hanno la loro origine in un unico processo: la sinapsi: questa comunicazione tra le cellule nervose è responsabile del motivo per cui potresti leggere questo testo. Ciascuno di questi impulsi sinaptici contiene circa 4,7 bit di informazioni. Se paragoniamo questi dati al numero totale di neuroni disponibili, significa che il cervello può immagazzinare fino a un trilione di bit: quasi tutto il contenuto che esiste su Internet. La neuropsicologia permette proprio di scavare nelle strutture cerebrali per trovare metodi per sfruttare tutto quel potenziale in campi come l'apprendimento. Il nostro master si occupa di questo approccio. Questo viaggio virtuale coinvolge nove moduli tematici in cui imparerai non solo i fondamenti delle neuroscienze, ma altri aspetti interessanti come le intelligenze multiple, le abilità motorie e la lateralità, i processi linguistici, l'iperattività e, naturalmente, la neuroeducazione. Vuoi portare la tua vocazione ad un altro livello? Iscriviti con noi e fallo in modo soddisfacente.