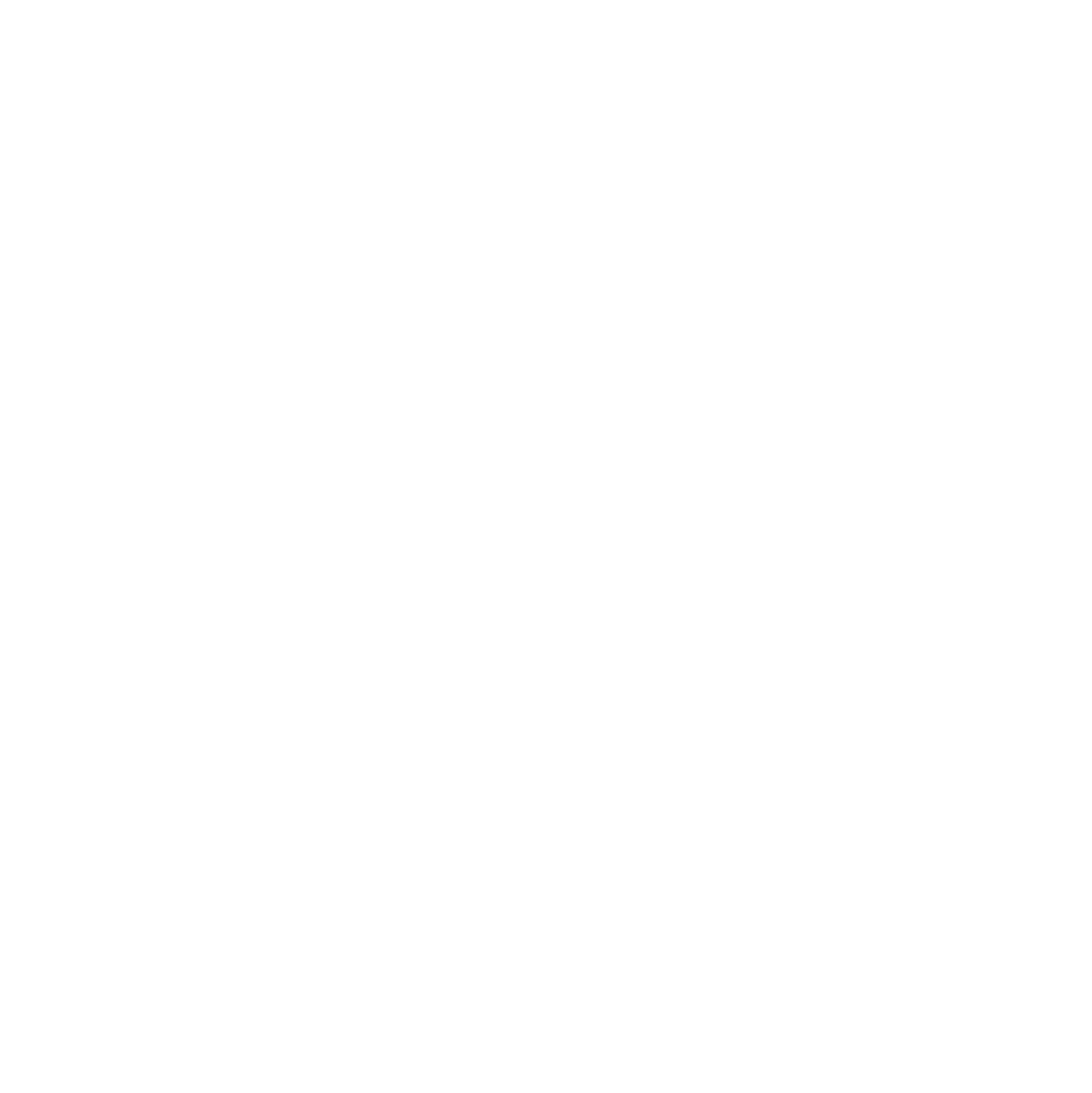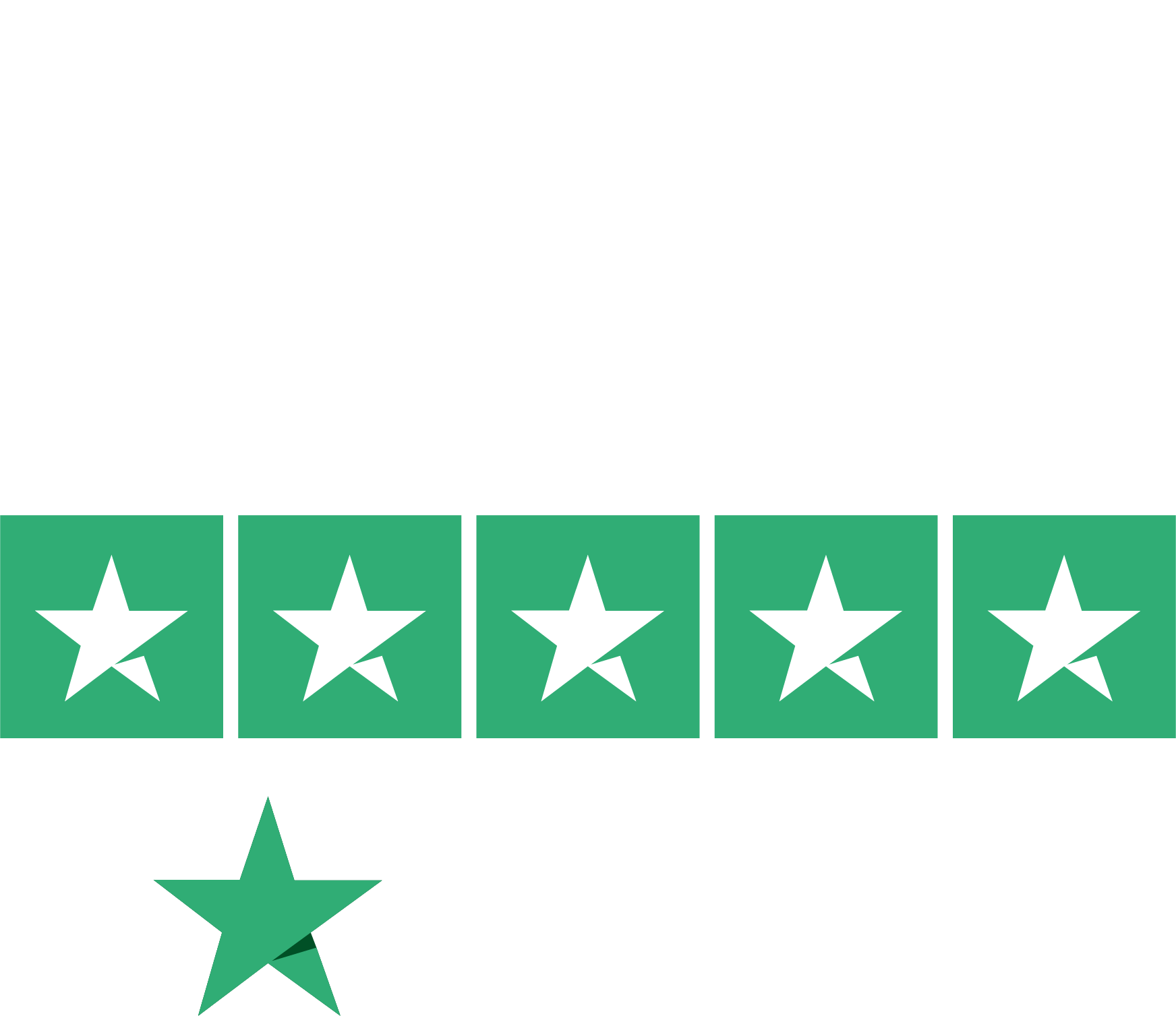Titolo universitario
La più grande facoltà di psicologia del mondo"
Presentazione
Una conoscenza approfondita del neurosviluppo e le sue molteplici implicazioni, in un completo Master specialistico creato per spingerti ad un altro livello professionale.

La neuropsicologia si basa sul metodo scientifico naturale per avvicinarsi allo studio del cervello. Attraverso una combinazione di metodi ipotetico-deduttivi e analitico-induttivi i professionisti di questa disciplina sviluppano l'intervento terapeutico sia negli individui con lesioni cerebrali congenite o sopravvenute , sia negli individui senza lesioni.
Questo Master specialistico possiede due aree di studio distinte e altamente complementari. Da un lato, la neuropsicologia clinica e, dall'altro, la neuroeducazione. L'obiettivo della prima di queste aree è quello di dare allo psicologo la padronanza dei meccanismi neurologici e biochimici che si verificano nella malattia mentale e nella salute. Da parte sua, il lavoro della neuropsicologia nel campo dell'istruzione intende educare i professionisti sugli aspetti cerebrali che influenzano l'istruzione e l'apprendimento.
La comprensione delle strutture chimiche e anatomiche che intervengono in ogni uno dei processi nel campo della salute e anche dei disturbi mentali, porta una visione globale necessaria per il vero dominio nel discernimento dell'essere umano, che si unisce all'ampio spettro dell'intervento in formazione per dare un'ampia conoscenza della materia. La relazione biochimica del cervello e delle strutture limbiche con le emozioni di base, così come il modo in cui il sistema reticolare influenza il nostro comportamento e la nostra coscienza, sono argomenti essenziali di questo programma educativo.
Inoltre, lo psicologo potrà godere di 10 Masterclasses uniche, progettate da un rinomato specialista internazionale in Neuropsicologia Clinica. Grazie alla consulenza di questo esperto, i professionisti potranno essere aggiornati sulle ultime scoperte nella valutazione e nella cura delle persone affette da lesioni cerebrali.
Non solo ti accompagneremo attraverso le conoscenze teoriche che offriamo, ma ti mostreremo un altro modo di studiare e imparare, più organico, più semplice ed efficiente. Lavoreremo per mantenerti motivato e per trasmetterti la passione per l'apprendimento.
Aggiorna le tue competenze in Neuropsicologia Clinica con la guida di uno dei maggiori esperti internazionali. Accederai a 10 Masterclass di prima classe!”
Questo Master specialistico in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione possiede il programma più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- L'ultima tecnologia nel software di e-learning
- Il sistema di insegnamento intensamente visivo, supportato da contenuti grafici e schematici, di facile assimilazione e comprensione
- Lo sviluppo di casi di studio, presentati da esperti attivi
- Sistemi di video interattivi di ultima generazione
- Insegnamento supportato dalla pratica online
- Sistemi di aggiornamento e riciclaggio permanente
- Apprendimento autoregolato: piena compatibilità con altre occupazioni
- Esercizi pratici per l'autovalutazione e la verifica dell'apprendimento
- Gruppi di sostegno e sinergie educative: domande all'esperto, forum di discussione e conoscenza
- Comunicazione con l'insegnante e lavoro di riflessione individuale
- La disponibilità di accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo, fisso o portatile, con una connessione internet
- Banche di documentazione di supporto sempre disponibili, anche dopo il programma
Un programma creato per i professionisti che aspirano all'eccellenza e che ti permetterà di acquisire nuove competenze e strategie in modo fluente ed efficace"
Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti del settore e altre aree correlate, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente.
Contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.
Una profonda e completa immersione nelle strategie e negli approcci in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione"

I sistemi sensoriali dell'essere umano studiati dal punto di vista del neuropsicologo, con lo scopo di intervenire e migliorare.
Programma
I contenuti di questa specializzazione sono stati sviluppati dai diversi professori di questo programma, con uno scopo chiaro: assicurare che i nostri studenti acquisiscano tutte le competenze necessarie per diventare veri esperti in questo campo. Il contenuto di questo Master specialistico ti permetterà di imparare tutti gli aspetti delle diverse discipline coinvolte in questo settore. Un programma completo e ben strutturato che ti porterà ai più alti standard di qualità e successo.

Attraverso uno sviluppo ben segmentazione, sarai in grado di accedere alle conoscenze più avanzate del momento in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione”
Modulo 1. Basi di neuroscienze
1.1. Il sistema nervoso e i neuroni
1.1.1. Introduzione
1.1.2. Sviluppi e ultimi approcci
1.2. Anatomia di base delle strutture legate all'apprendimento
1.2.1. Fisiologia dell'apprendimento
1.3. Processi psicologici legati all'apprendimento
1.3.1. Emozioni e apprendimento
1.3.2. Approcci emotivi
1.4. Le principali strutture cerebrali legate alla funzione motoria
1.4.1. Sviluppo del cervello e abilità motorie
1.4.2. Lateralità e sviluppo
1.5. Il cervello plastico e la neuroplasticità
1.5.1. Definizione di plasticità
1.5.2. Neuroplasticità e istruzione
1.6. Epigenetica
1.6.1. Definizione e origini
1.7. Gli effetti dell'ambiente sullo sviluppo del cervello
1.7.1. Teorie attuali
1.7.2. L'influenza dell'ambiente nello sviluppo del bambino
1.8. Cambiamenti nel cervello del bambino
1.8.1. Lo sviluppo del cervello nell'infanzia
1.8.2. Caratteristiche
1.9. L'evoluzione del cervello degli adolescenti
1.9.1. Lo sviluppo del cervello nell'adolescenza
1.9.2. Caratteristiche
1.10. Il cervello adulto
1.10.1. Caratteristiche del cervello adulto
1.10.2. Il cervello adulto e l'apprendimento
Modulo 2. Neuropsicologia dello sviluppo
2.1. Neuroscienze
2.2. Il cervello: struttura e funzionamento
2.3. Neuroscienze e apprendimento
2.4. Intelligenze multipli
2.5. Neuroscienza - Educazione
2.6. Neuroscienze in classe
2.7. Il gioco e le nuove tecnologie
2.8. Corpo e cervello
2.9. Le neuroscienze per prevenire l’abbandono scolastico
2.10. Ragione ed emozione
Modulo 3. Principi di neuroanatomia
3.1. Classificazione delle fibre nervose (Erlanger e Gasser)
3.1.1. Alfa
3.1.2. Beta
3.1.3. Gamma
3.1.4. Delta
3.1.5. Simpatiche
3.1.6. Preganglionari
3.1.7. Meccanocettori
3.1.8. Nocicettori simpatici
3.1.9. Preganglionari
3.2. Sistema nervoso vegetativo
3.3. Midollo spinale
3.4. Nervi spinali
3.5. Comunicazione afferente ed efferente
3.6. Sostanza grigia
3.7. Sostanza bianca
3.8. Tronco encefalico
3.8.1. Mesencefalo
3.8.2. Ponte di varolio
3.8.3. Bulbo spinale
3.8.4. Cervelletto
3.9. Sistema limbico
3.9.1. Tonsille
3.9.2. Ippocampo
3.9.3. Ippotalamo
3.9.4. Cingolo
3.9.5. Talamo sensoriale
3.9.6. Nucleo di base
3.9.7. Regione grigia periacqueduttale
3.9.8. Ipofisi
3.9.9. Nucleo accumbens
3.10. Corteccia cerebrale (teoria dell'evoluzione del cervello, Carter 2002)
3.10.1. Corteccia parietale
3.10.2. Lobi frontali (6 m)
3.10.3. Sistema limbico (12 m)
3.10.4. Area del linguaggio: 1° Wernicke, 2° Broca. (18 m)
3.11. Lobo frontale orbitale
3.12. Relazioni funzionali del SN con altri organi e sistemi
3.13. Trasmissione motoneuronea
3.14. Sensopercezione.
3.15. Neuroendocrinologia (relazione ipotalamo-sistema endocrino)
3.15.1. Regolazione temperatura
3.15.2. Regolazione della pressione sanguigna
3.15.3. Regolazione dell'assunzione degli alimenti
3.15.4. Regolazione della funzione riproduttiva
3.16. Neuroimmunologia (relazione sistema nervoso-sistema immunitario)
3.17. Mappa che mette in relazione l'emozione con le strutture neuroanatomiche
Modulo 4. Introduzione alla Neuropsicologia
4.1. Introduzione alla Neuropsicologia
4.1.1. Basi e origini della Neuropsicologia
4.1.2. Primi approcci alla disciplina
4.2. Primi approcci alla Neuropsicologia
4.2.1. Primi lavori in Neuropsicologia
4.2.2. Autori e lavori più rilevanti
4.3. Ontogenesi e filogenesi del SNC
4.3.1. Concetto di Ontogenesi e Filogenesi
4.3.2. Ontogenesi e filogenesi del SNC
4.4. Neurobiologia cellulare e molecolare
4.4.1. Introduzione alla neurobiologia
4.4.2. Neurobiologia cellulare e molecolare
4.5. Neurobiologia dei sistemi
4.5.1. Concetto di sistema
4.5.2. Strutture e sviluppo
4.6. Embriologia del sistema nervoso
4.6.1. Principi di embriologia del sistema nervoso
4.6.2. Fasi dell’embriologia del SN
4.7. Introduzione all'anatomia strutturale del SNC
4.7.1. Introduzione all'anatomia strutturale
4.7.2. Sviluppo strutturale
4.8. Introduzione all'anatomia funzionale
4.8.1. Che cos'è l'anatomia funzionale?
4.8.2. Le funzioni più importanti
4.9. Tecniche di neuroimmagine
4.9.1. Concetto di neuroimmagine
4.9.2. Le tecniche più utilizzate
4.9.3. Vantaggi e svantaggi
Modulo 5. Neuroanatomia Funzionale
5.1. Lobo Frontale
5.1.1. Introduzione al Lobo frontale
5.1.2. Caratteristiche principali
5.1.3. Base del suo funzionamento
5.2. Neuropsicologia della corteccia prefrontale dorsolaterale
5.2.1. Introduzione alla corteccia prefrontale dorsolaterale
5.2.2. Caratteristiche principali
5.2.3. Base del suo funzionamento
5.3. Neuropsicologia della corteccia orbitofrontale
5.3.1. Introduzione alla corteccia orbitofrontale
5.3.2. Caratteristiche principali
5.3.3. Base del suo funzionamento
5.4. Neuropsicologia della corteccia prefrontale mediale
5.4.1. Introduzione alla corteccia prefrontale dorsolaterale
5.4.2. Caratteristiche principali
5.4.3. Base del suo funzionamento
5.5. Corteccia motoria
5.5.1. Introduzione alla corteccia motoria
5.5.2. Caratteristiche principali
5.5.3. Base del suo funzionamento
5.6. Lobo Temporale
5.6.1. Introduzione alla corteccia del lobo temporale
5.6.2. Caratteristiche principali
5.6.3. Base del suo funzionamento
5.7. Lobo Parietale
5.7.1. Introduzione alla corteccia del lobo parietale
5.7.2. Caratteristiche principali
5.7.3. Base del suo funzionamento
5.8. Lobo Occipitale
5.8.1. Introduzione alla corteccia del lobo occipitale
5.8.2. Caratteristiche principali
5.8.3. Base del suo funzionamento
5.9. Asimmetria cerebrale
5.9.1. Concetto di Asimmetria cerebrale
5.9.2. Caratteristiche e funzionamento
Modulo 6. Funzioni Cognitive
6.1. Basi neurobiologiche dell'attenzione
6.1.1. Introduzione al concetto di attenzione
6.1.2. Basi e fondamenti neurobiologici dell'attenzione
6.2. Basi neurobiologiche della memoria
6.2.1. Introduzione al concetto di memoria
6.2.2. Basi e fondamenti neurobiologici della memoria
6.3. Basi neurobiologiche del linguaggio
6.3.1. Introduzione al concetto di linguaggio
6.3.2. Basi e fondamenti neurobiologici del linguaggio
6.4. Basi neurobiologiche della percezione
6.4.1. Introduzione al concetto di percezione
6.4.2. Basi e fondamenti neurobiologici della percezione
6.5. Basi neurobiologiche visuo-spaziali
6.5.1. Introduzione alle funzioni visuo-spaziali
6.5.2. Basi e fondamenti delle funzioni visuo-spaziali
6.6. Basi neurobiologiche delle funzioni esecutive
6.6.1. Introduzione alle funzioni esecutive
6.6.2. Basi e fondamenti delle funzioni esecutive
6.7. Prassi
6.7.1. Cosa sono le prassie?
6.7.2. Caratteristiche e tipologie
6.8. Agnosie
6.8.1. Cosa sono le prassie?
6.8.2. Caratteristiche e tipologie
6.9. Cognizione Sociale
6.9.1. Introduzione alla cognizione sociale
6.9.2. Caratteristiche e fondamenti teorici
Modulo 7. Lesione Cerebrale
7.1. Disturbi neuropsicologici e comportamentali di origine genetica
7.1.1. Introduzione
7.1.2. Geni, cromosomi ed ereditarietà
7.1.3. Geni e comportamento
7.2. Disturbo da lesione cerebrale precoce
7.2.1. Introduzione
7.2.2. Il cervello della prima infanzia
7.2.3. Paralisi cerebrale infantile (PCI)
7.2.4. Psico-sindromi
7.2.5. Disturbi dell'apprendimento
7.2.6. Disturbi neurobiologici che influenzano l'apprendimento
7.3. Disturbi vascolari cerebrali
7.3.1. Introduzione ai disturbi cerebrovascolari
7.3.2. Tipi più comuni
7.3.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.4. Tumori cerebrali
7.4.1. Introduzione ai tumori cerebrali
7.4.2. Tipi più comuni
7.4.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.5. Trauma cranio-encefalico
7.5.1. Introduzione ai traumi
7.5.2. Tipi più comuni
7.5.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.6. Infezioni del SN
7.6.1. Introduzione alle infezioni del SN
7.6.2. Tipi più comuni
7.6.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.7. Disturbi epilettici
7.7.1. Introduzione ai disturbi epilettici
7.7.2. Tipi più comuni
7.7.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.8. Alterazioni del livello di coscienza
7.8.1. Introduzione alle alterazioni del livello di coscienza
7.8.2. Tipi più comuni
7.8.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.9. Danno cerebrale acquisito
7.9.1. Concetto di danno cerebrale acquisito
7.9.2. Tipi più comuni
7.9.3. Caratteristiche e sintomatologia
7.10. Disturbi Connessi all'Invecchiamento Patologico
7.10.1. Introduzione
7.10.2. Disturbi psicologici associati all'invecchiamento patologico
Modulo 8. Afasia, Agrafia e Alessia
8.1. Afasia di Broca
8.1.1. Basi e origine dell'Afasia di Broca
8.1.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.1.3. Valutazione e diagnosi
8.2. Afasia di Wernicke
8.2.1. Basi e origine dell'Afasia di Wernicke
8.2.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.2.3. Valutazione e diagnosi
8.3. Afasia di Conduzione
8.3.1. Basi e origine dell'Afasia di conduzione
8.3.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.3.3. Valutazione e diagnosi
8.4. Afasia Globale
8.4.1. Basi e origine dell'Afasia Globale
8.4.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.4.3. Valutazione e diagnosi
8.5. Afasia Transcorticale sensoriale
8.5.1. Basi e origine dell'Afasia di Broca
8.5.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.5.3. Valutazione e diagnosi
8.6. Afasia Transcorticale motoria
8.6.1. Basi e origine dell'Afasia Transcorticale motoria
8.6.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.6.3. Valutazione e diagnosi
8.7. Afasia Transcorticale mista
8.7.1. Basi e origine dell’Afasia Transcorticale mista
8.7.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.7.3. Valutazione e diagnosi
8.8. Afasia Anomica
8.8.1. Basi e origine dell'Afasia anomica
8.8.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.8.3. Valutazione e diagnosi
8.9. Agrafie
8.9.1. Basi e origine delle Agrafie
8.9.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.9.3. Valutazione e diagnosi
8.10. Alessia
8.10.1. Basi e origine delle Alessie
8.10.2. Caratteristiche e sintomatologia principale
8.10.3. Valutazione e diagnosi
Modulo 9. Malattie Neurodegenerative
9.1: Invecchiamento Normale
9.1.1. Processi cognitivi di base nell'invecchiamento normale
9.1.2. Processi cognitivi superiori nell'invecchiamento normale
9.1.3. Attenzione e memoria nei soggetti che invecchiano normalmente
9.2. La Riserva cognitiva e la sua importanza nell'invecchiamento
9.2.1. Riserva cognitiva: definizione e concetti di base
9.2.2. Funzionalità della riserva cognitiva
9.2.3. Variabili che influenzano la riserva cognitiva
9.2.4. Interventi basati sul miglioramento della riserva cognitiva negli anziani
9.3. Sclerosi multipla
9.3.1. Concetti e fondamenti biologici della Sclerosi Multipla
9.3.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.3.3. Profilo del paziente
9.3.4. Valutazione e diagnosi
9.4. Sclerosi Laterale Amiotrofica
9.4.1. Concetti e fondamenti biologici della Sclerosi Laterale Amiotrofica
9.4.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.4.3. Profilo del paziente
9.4.4. Valutazione e diagnosi
9.5. Morbo di Parkinson
9.5.1. Concetti e fondamenti biologici del Morbo di Parkinson
9.5.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.5.3. Profilo del paziente
9.5.4. Valutazione e diagnosi
9.6. Malattia di Huntington
9.6.1. Concetti e fondamenti biologici della Malattia di Huntington
9.6.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.6.3. Profilo del paziente
9.6.4. Valutazione e diagnosi
9.7. Demenza derivata dall’Alzheimer
9.7.1. Concetti e basi biologiche della demenza derivata dall’Alzheimer
9.7.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.7.3. Profilo del paziente
9.7.4. Valutazione e diagnosi
9.8. Demenza di Pick
9.8.1. Concetti e basi biologiche della Demenza di Pick
9.8.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.8.3. Profilo del paziente
9.8.4. Valutazione e diagnosi
9.9. Demenza da Corpi di Lewy
9.9.1. Concetti e fondamenti biologici della Demenza da Corpi di Lewy
9.9.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.9.3. Profilo del paziente
9.9.4. Valutazione e diagnosi
9.10. Demenza Vascolare
9.10.1. Concetti e fondamenti biologici della Demenza Vascolare
9.10.2. Caratteristiche e sintomatologia
9.10.3. Profilo del paziente
9.10.4. Valutazione e diagnosi
Modulo 10. Neuroeducazione
10.1. Introduzione alla Neuroeducazione
10.2. I principali neuromiti
10.3. L’attenzione
10.4. L'emozione
10.5. Motivazione
10.6. L’apprendimento
10.7. La memoria
10.8. Stimolazione e interventi precoci
10.9. L'importanza della creatività nella Neuroeducazione
10.10. Metodologie che permettono la trasformazione dell'educazione in Neuroeducazione
Modulo 11. Funzionalità Visiva e Uditiva per la Lettura, il Linguaggio, le Lingue e l'Apprendimento
11.1. Visione: funzionamento e basi neuropsicologiche
11.1.1. Introduzione
11.1.2. Sviluppo del sistema visivo alla nascita
11.1.3. Fattori di rischio
11.1.4. Sviluppo di altri sistemi sensoriali durante l'infanzia
11.1.5. Influenza della visione sul sistema visuo-motorio e il suo sviluppo
11.1.6. Visione normale e binoculare
11.1.7. Anatomia degli occhi umani
11.1.8. Funzioni dell'occhio
11.1.9. Altre funzioni
11.1.10. Vie visive alla corteccia cerebrale
11.1.11. Elementi che favoriscono la percezione visiva
11.1.12. Malattie e disturbi della vista
11.1.13. Disturbi o malattie degli occhi comuni: Interventi in classe
11.1.14. Sindrome da visione artificiale (CVS)
11.1.15. Osservazione attitudinale dello studente
11.1.16. Riepilogo
11.1.17. Riferimenti bibliografici
11.2. Percezione visiva, valutazione e programmi di intervento
11.2.1. Introduzione
11.2.2. Sviluppo umano: Lo sviluppo dei sistemi sensoriali
11.2.3. La percezione sensoriale
11.2.4. Il neurosviluppo
11.2.5. Descrizione del processo percettivo
11.2.6. La percezione del colore
11.2.7. Percezione e abilità visive
11.2.8. Valutazione della percezione visiva
11.2.9. Intervento per migliorare la percezione visiva
11.2.10. Riepilogo
11.2.11. Riferimenti bibliografici
11.3. Monitoraggio dei movimenti oculari
11.3.1. Introduzione
11.3.2. Movimenti oculari
11.3.3. Monitoraggio dei movimenti oculari
11.3.4. Registrazione e valutazione della motilità oculare
11.3.5. Disturbi della motilità oculare
11.3.6. Il sistema visivo e la lettura
11.3.7. Sviluppo di abilità nell'imparare a leggere
11.3.8. Programmi e attività di miglioramento e formazione
11.3.9. Riepilogo
11.3.10. Riferimenti bibliografici
11.4. Movimenti saccadici e la loro implicazione nella lettura
11.4.1. Introduzione
11.4.2. Modelli del processo di lettura
11.4.3. Movimenti saccadici e loro implicazione nella lettura
11.4.4. Come vengono valutati i movimenti saccadici
11.4.5. Il processo di lettura visiva
11.4.6. La memoria visiva nel processo di lettura
11.4.7. Ricerca per studiare la relazione tra la memoria visiva e la lettura
11.4.8. Difficoltà della lettura
11.4.9. Insegnanti specializzati
11.4.10. Educatori sociali
11.4.11. Riepilogo
11.4.12. Riferimenti bibliografici
11.5. Accomodamento visivo e la sua relazione con la postura in classe
11.5.1. Introduzione
11.5.2. Meccanismi che permettono l'accomodamento o la focalizzazione
11.5.3. Come si valuta l'accomodamento visivo
11.5.4. Postura del corpo in classe
11.5.5. Programmi di formazione per l'accomodamento visivo
11.5.6. Aiuti per gli alunni ipovedenti
11.5.7. Riepilogo
11.5.8. Riferimenti bibliografici
11.6. Struttura e funzione dell'orecchio
11.6.1. Introduzione
11.6.2. Il mondo del suono
11.6.3. Il suono e la sua propagazione
11.6.4. I recettori uditivi
11.6.5. Struttura dell'orecchio
11.6.6. Sviluppo del sistema uditivo dalla nascita
11.6.7. Sviluppo dei sistemi sensoriali durante l'infanzia
11.6.8. Influenza dell'udito sullo sviluppo dell'equilibrio
11.6.9. Malattie dell'orecchio
11.6.10. Riepilogo
11.6.11. Riferimenti bibliografici
11.7. Percezione uditiva
11.7.1. Introduzione
11.7.2. Linee guida per individuare i problemi di percezione uditiva
11.7.3. Il processo percettivo
11.7.4. Ruolo delle vie uditive nei processi percettivi
11.7.5. Bambini con percezione uditiva compromessa
11.7.6. Test di valutazione
11.7.7. Riepilogo
11.7.8. Riferimenti bibliografici
11.8. Valutazione dell'udito e dei danni all'udito
11.8.1. Introduzione
11.8.2. Valutazione del canale uditivo esterno
11.8.3. Otoscopia
11.8.4. Audiometria ad aria
11.8.5. Udito a conduzione ossea
11.8.6. Curva di soglia del disagio
11.8.7. Audiometria tonale, audiometria vocale e acusometria
11.8.8. Disturbi dell'udito: gradi e tipi di perdita dell'udito
11.8.9. Cause della perdita dell'udito
11.8.10. Aspetti psicobiologici della perdita dell'udito
11.8.11. Riepilogo
11.8.12. Riferimenti bibliografici
11.9. Udito e sviluppo dell'apprendimento
11.9.1. Introduzione
11.9.2. Sviluppo dell'orecchio umano
11.9.3. Programmi, attività e giochi per lo sviluppo uditivo dei bambini
11.9.4. Metodo Berard
11.9.5. Metodo Tomatis
11.9.6. Salute della vista e dell'udito
11.9.7. Adattamenti di elementi curricolari
11.9.8. Riepilogo
11.9.10. Riferimenti bibliografici
11.10. Processi visivi e uditivi coinvolti nella lettura
11.10.1. Introduzione
11.10.2. Monitoraggio dei movimenti oculari
11.10.3. Il sistema visivo e la lettura
11.10.4. Dislessia
11.10.5. Terapie basate sul colore per la dislessia
11.10.6. Ausili per la disabilità visiva
11.10.7. Riepilogo
11.10.8. Riferimenti bibliografici
11.11. Relazione tra visione e udito nel linguaggio
11.11.1. Introduzione
11.11.2. Relazione tra vista e udito
11.11.3. Elaborazione dell'informazione verbale-uditiva e visiva
11.11.4. Programmi d'intervento per i disturbi dell'udito
11.11.5. Linee guida per gli insegnanti
11.11.6. Riepilogo
11.11.7. Riferimenti bibliografici
Modulo 12. Motricità, Lateralità e Scrittura
12.1. Neurosviluppo e apprendimento
12.1.1. introduzione
12.1.2. Sviluppo percettivo
12.1.3. Basi neuropsicologiche dello sviluppo motorio
12.1.4. Sviluppo della lateralità
12.1.5. Comunicazione interemisferica attraverso il corpo calloso
12.1.6. Ambidestrismo
12.1.7. Riepilogo
12.1.8. Riferimenti bibliografici
12.2. Sviluppo psicomotorio
12.2.1. introduzione
12.2.2. Abilità psicomotorie grossolane
12.2.3. Coordinazione dinamica generale: competenze di base
12.2.4. La motricità fine e il loro rapporto con la scrittura
12.2.5. Valutazione dello sviluppo psicomotorio
12.2.6. Riepilogo
12.2.7. Riferimenti bibliografici
12.3. Neuropsicologia dello sviluppo motorio
12.3.1. introduzione
12.3.2. Rapporto tra capacità motorie e psiche
12.3.3. Disturbi dello sviluppo motorio
12.3.4. Disturbi dell'acquisizione della coordinazione
12.3.5. Disturbi del sistema vestibolare
12.3.6. Scrittura
12.3.7. Riepilogo
12.3.8. Riferimenti bibliografici
12.4. Introduzione allo sviluppo della lateralità
12.4.1. introduzione
12.4.2. Prove di lateralità
12.4.3. Linee guida per l'osservazione per gli insegnanti
12.4.4. Lateralità incrociata
12.4.5. Tipi di lateralità incrociata
12.4.6. Rapporto tra dislessia e lateralità
12.4.7. Relazione tra lateralità e problemi di attenzione, memoria e iperattività
12.4.8. Riepilogo
12.4.9. Riferimenti bibliografici
12.5. Sviluppo della lateralità in età differenti
12.5.1. introduzione
12.5.2. Definizione di lateralità
12.5.3. Tipi di lateralità
12.5.4. Il corpo calloso
12.5.5. Gli emisferi cerebrali
12.5.6. Sviluppo degli stadi prelaterale, controlaterale e laterale
12.5.7. Riepilogo
12.5.8. Riferimenti bibliografici
12.6. Disturbi motori e relative difficoltà di apprendimento
12.6.1. introduzione
12.6.2. Disturbi motori
12.6.3. Difficoltà di apprendimento
12.6.4. Riepilogo
12.6.5. Riferimenti bibliografici
12.7. Processo e acquisizione della scrittura
12.7.1. Introduzione
12.7.2. Apprendimento della lettura
12.7.3. Problemi di comprensione che gli studenti possono sviluppare
12.7.4. Sviluppo evolutivo della scrittura
12.7.5. Storia della scrittura
12.7.6. Basi neuropsicologiche della scrittura
12.7.7. Insegnare l'espressione scritta
12.7.8. Metodi di insegnamento della scrittura
12.7.9. Laboratori di scrittura
12.7.10. Riepilogo
12.7.11. Riferimenti bibliografici
12.8. Disgrafia
12.8.1. introduzione
12.8.2. Stili di apprendimento
12.8.3. Funzioni esecutive coinvolte nell'apprendimento
12.8.4. Definizione di disgrafia e tipi
12.8.5. Indicatori comuni di disgrafia
12.8.6. Aiuto in classe per gli studenti con disgrafia
12.8.7. Aiuti individuali
12.8.8. Riepilogo
12.8.9. Riferimenti bibliografici
12.9. Il contributo della lateralità allo sviluppo della lettura e della scrittura
12.9.1. introduzione
12.9.2. Importanza della lateralità nei processi di apprendimento
12.9.3. Lateralità nei processi di lettura e scrittura
12.9.4. Lateralità e difficoltà di apprendimento
12.9.5. Riepilogo
12.9.6. Riferimenti bibliografici
12.10. Ruolo dello psicologo scolastico e dei consulenti nella prevenzione, nello sviluppo e nelle difficoltà di apprendimento
12.10.1. Introduzione
12.10.2. Il dipartimento di orientamento
12.10.3. Programmi di intervento
12.10.4. Progressi della neuropsicologia nelle difficoltà di apprendimento
12.10.5. Formazione del gruppo docente
12.10.6. Riepilogo
12.10.7. Riferimenti bibliografici
12.11. Orientamento per i genitori
12.11.1. Come informare i genitori?
12.11.2. Attività per migliorare il rendimento scolastico
12.11.3. Attività per migliorare lo sviluppo laterale
12.11.4. Strategie di risoluzione dei problemi
12.11.5. Riepilogo
12.11.6. Riferimenti bibliografici
12.12. Valutazione e intervento psicomotorio
12.12.1. Introduzione
12.12.2. Sviluppo psicomotorio
12.12.3. Valutazione psicomotoria
12.12.4. Intervento psicomotorio
12.12.5. Riepilogo
12.12.6. Riferimenti bibliografici
Modulo 13. Strategie Metodologiche e Difficoltà di Apprendimento
13.1. Tecniche per migliorare l'autostima
13.1.1. Classificazione
13.1.2. Descrizione
13.2. Modifica della condotta
13.2.1. Identificazione
13.2.2. Approccio
13.3. Strategie di coping e problem-solving
13.3.1. Classificazione
13.3.2. Applicazioni
13.4. Abilità sociali
13.4.1. Descrizione delle carenze
13.4.2. Modelli di intervento
13.5. Intelligenza emotiva, creatività ed educazione emotiva in classe
13.5.1. L'intelligenza emotiva e l'educazione delle emozioni dal modello di Mayer e Salovey
13.5.2. Altri modelli di intelligenza emotiva e trasformazione emotiva
13.5.3. Competenze socio-emotive e creatività a seconda del livello di intelligenza
13.5.4. Concetto di quoziente emotivo, intelligenza e adattamento nelle difficoltà di apprendimento
13.5.5. Risorse pratiche in classe per prevenire la demotivazione negli studenti con difficoltà di apprendimento e la gestione del comportamento dirompente attraverso le emozioni
13.5.6. Test standardizzati per valutare le emozioni
13.6. Pianificazione dell'apprendimento
13.6.1. Risorse per l'attuazione
13.7. Tecniche di studio
13.7.1. Descrizione
13.7.2. Sviluppi applicabili
13.8. Strategie di apprendimento
13.8.1. Strategie di test
13.8.2. Strategie di elaborazione
13.8.3. Strategie organizzative
13.8.4. Strategie metacognitive
13.8.5. Strategie affettive o di sostegno
13.9. Motivazione
13.9.1. Contestualizzazione
13.9.2. Approcci all'insegnamento
13.10. Intervento centrato sulla famiglia
13.10.1. Comprensione delle difficoltà di apprendimento
13.10.2. Accettazione dell’intervento
13.10.3. Presa di decisioni nell’ambito familiare
13.10.4. Comportamenti in famiglia
13.10.5. Progetti con la famiglia
13.10.6. Intelligenza emozionale. Gestione delle emozioni
13.11. Intervento educativo inclusivo
13.11.1. Progetto educativo del centro, Attenzione speciale ai bisogni di apprendimento
13.11.2. Adattamenti strutturali
13.11.3. Cambiamenti organizzativi
13.11.4. Piano di diversità
13.11.5. Piano di formazione docenti
13.11.6. Azioni curriculari
13.11.7. Organizzazione del programma per la scuola dell’infanzia
13.11.8. Organizzazione del programma per la scuola primaria
13.11.9. Organizzazione del programma per la scuola secondaria
13.12. Programmazione neuro-linguistica (PNL) applicata alle difficoltà di apprendimento
13.12.1. Giustificazione e obiettivi
13.12.2. Fondamenti della PNL
13.12.2.1. I fondamenti della PNL
13.12.2.2. I presupposti e le premesse della PNL
13.12.2.3. I livelli neurologici
13.12.3. Le regole della mente
13.12.4. Le credenze
13.12.5. Diversi modi di guardare la realtà
13.12.6. Stati d'animo
13.12.7. Modellare il linguaggio
13.12.8. Accesso alle risorse inconsce
13.13. Apprendimento dinamico in classe
13.13.1. L'apprendimento dinamico secondo Robert Dilts
13.13.2. Attività secondo i diversi stili di apprendimento
13.13.3. Attività secondo il modo in cui gli studenti selezionano le informazioni
13.13.4. Strategie per sviluppare il sistema visivo in classe
13.13.5. Strategie per sviluppare il sistema uditivo in classe
13.13.6. Strategie per sviluppare il sistema cinestetico in classe
13.13.7. Attività secondo il modo in cui gli studenti organizzano le informazioni
13.13.8. Attività di potenziamento dell'emisfero sinistro e dell'emisfero destro
13.13.8.1. Strategie per lavorare con tutto il cervello in classe
13.13.9. Tecniche per lavorare sulle credenze
13.13.10. Tecniche di programmazione neuro-linguistica per migliorare il rendimento scolastico degli studenti
13.13.10.1. Tecniche per riflettere sulla nostra percezione della realtà
13.13.10.1.1. Tecniche per sviluppare il pensiero flessibile
13.13.10.1.2. Tecniche per rimuovere blocchi o limitazioni
13.13.10.1.3. Tecniche per chiarire gli obiettivi
13.13.10.2. Allegati con test, registrazioni, tecniche, analisi della situazione, valutazioni e monitoraggio
13.14. Apprendimento cooperativo con attenzione alla diversità
13.14.1. Definizione e base dell'apprendimento cooperativo
13.14.2. Struttura dell'apprendimento cooperativo
13.14.3. Competenze e capacità da sviluppare
13.14.4. Obiettivi dell'apprendimento cooperativo in un approccio multiculturale
13.14.5. Attuazione in ciascuna delle fasi educative
13.14.5.1. Educazione infantile
13.14.5.1.1. Lavoro di squadra e coesione di gruppo nell'educazione della prima infanzia
13.14.5.1.1.1. Tecniche cooperative nell'educazione della prima infanzia
13.14.5.2. Educazione primaria
13.14.5.2.1. Didattica ed esperienze nell'educazione primaria Strutture semplici
13.14.5.2.2. Ricerca e progetti nell'educazione primaria
13.14.5.3. Educazione Secondaria
13.14.5.3.1. Importanza dei ruoli nell'istruzione secondaria
13.14.5.3.2. Valutazione delle esperienze cooperative nella scuola secondaria
13.14.6. Progettazione di attività e dinamiche di gruppo
13.14.7. Il ruolo dell'insegnante come facilitatore e guida
13.14.8. Valutazione dell'apprendimento cooperativo
13.15. Nuove tecnologie applicate
13.15.1. Diversi approcci e prospettive
13.15.1.1. Tecnologie dell’informazione e la comunicazione TIC
13.15.1.2. Tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza TAC
13.15.1.3. Tecnologie di empowerment e partecipazione TEP
13.15.2. Impatto delle nuove tecnologie nell'educazione
13.15.2.1. Competenza digitale degli studenti
13.15.2.2. Competenza digitale negli insegnanti
13.15.2.3. Il ruolo delle famiglie e la regolazione dell'uso
13.15.3. Educare con l'uso delle nuove tecnologie
13.15.3.1. Contenuti di educazione digitale
13.15.3.2. Strumenti
13.15.3.3. Piattaforme educative
13.15.4. La trasformazione dell'educazione con nuovi metodi di insegnamento
Modulo 14. Intelligenze Multiple, Creatività, Talento e Alte Capacità
14.1. Teoria delle intelligenze multiple
14.1.1. Introduzione
14.1.2. Contesto
14.1.3. Concettualizzazione
14.1.4. Convalida
14.1.5. Premesse e principi di base delle teorie
14.1.6. Scienze neuropsicologiche e cognitive
14.1.7. Classificazione delle teorie delle intelligenze multiple
14.1.8. Riepilogo
14.1.9. Riferimenti bibliografici
14.2. Tipi di intelligenze multipli
14.2.1. Introduzione
14.2.2. Tipi di intelligenza
14.2.3. Riepilogo
14.2.4. Riferimenti bibliografici
14.3. Valutazione delle intelligenze multiple
14.3.1. Introduzione
14.3.2. Contesto
14.3.3. Tipi di valutazioni
14.3.4. Aspetti da tenere presenti nella valutazione
14.3.5. Riepilogo
14.3.6. Riferimenti bibliografici
14.4. Creatività
14.4.1. Introduzione
14.4.2. Concetti e teorie di creatività
14.4.3. Approcci allo studio della creatività
14.4.4. Caratteristiche del pensiero creativo
14.4.5. Tipi di creatività
14.4.6. Riepilogo
14.4.7. Riferimenti bibliografici
14.5. Basi neuropsicologiche della creatività
14.5.1. Introduzione
14.5.2. Contesto
14.5.3. Caratteristiche delle persone creative
14.5.4. Prodotti creativi
14.5.5. Basi neuropsicologiche della creatività
14.5.6. Influenza dell'ambiente e del contesto sulla creatività
14.5.7. Riepilogo
14.5.8. Riferimenti bibliografici
14.6. Creatività nel contesto educativo
14.6.1. Introduzione
14.6.2. Creatività in classe
14.6.3. Fasi del processo creativo
14.6.4. Come lavorare sulla creatività
14.6.5. Relazione tra creatività e pensiero
14.6.6. Cambiamenti nel contesto educativo
14.6.7. Riepilogo
14.6.8. Riferimenti bibliografici
14.7. Metodologie per lo sviluppo della creatività
14.7.1. Introduzione
14.7.2. Programmi per lo sviluppo della creatività
14.7.3. Progetti per lo sviluppo della creatività
14.7.4. Promozione della creatività nel contesto familiare
14.7.5. Riepilogo
14.7.6. Riferimenti bibliografici
14.8. Valutazione della creatività e orientamenti
14.8.1. Introduzione
14.8.2. Considerazioni sulla valutazione
14.8.3. Test di valutazione
14.8.4. Test soggettivi di valutazione
14.8.5. Orientamenti sulla valutazione
14.8.6. Riepilogo
14.8.7. Riferimenti bibliografici
14.9. Grandi capacità e talenti
14.9.1. Introduzione
14.9.2. Relazione tra talento e alta abilità
14.9.3. Relazione tra eredità e ambiente
14.9.4. Fondamenti in neuropsicologia
14.9.5. Modelli di talento
14.9.6. Riepilogo
14.9.7. Riferimenti bibliografici
14.10. Identificazione e diagnosi di abilità elevate
14.10.1. Introduzione
14.10.2. Principali caratteristiche
14.10.3. Come identificare le alte capacità
14.10.4. Ruolo degli attori coinvolti
14.10.5. Test e strumenti di valutazione
14.10.6. Programmi di intervento
14.10.7. Riepilogo
14.10.8. Riferimenti bibliografici
14.11. Problemi e difficoltà
14.11.1. Introduzione
14.11.2. Problemi e difficoltà a scuola
14.11.3. Miti e credenze
14.11.4. Dyssynchronies
14.11.5. Diagnosi differenziale
14.11.6. Differenze di genere
14.11.7. Necessità educative
14.11.8. Riepilogo
14.11.9. Riferimenti bibliografici
14.12. Relazione tra intelligenze multiple, alte capacità, talento e creatività
14.12.1. Introduzione
14.12.2. Relazione tra intelligenze multiple e creatività
14.12.3. Relazione tra intelligenze multiple, alte capacità e talenti
14.12.4. Differenze tra talento e alte capacità
14.12.5. Creatività, alte capacità e talento
14.12.6. Riepilogo
14.12.7. Riferimenti bibliografici
14.13. Orientamenti e sviluppo delle intelligenze multiple
14.13.1. Introduzione
14.13.2. Consigli agli insegnanti
14.13.3. Sviluppo multidimensionale degli alunni
14.13.4. Arricchimento del curriculum
14.13.5. Strategie a diversi livelli educativi
14.13.6. Riepilogo
14.13.7. Riferimenti bibliografici
14.14. Creatività nella risoluzione dei problemi
14.14.1. Introduzione
14.14.2. Modelli del processo creativo come risoluzione di problemi
14.14.3. Sviluppo di progetti creativi
14.14.4. Riepilogo
14.14.5. Riferimenti bibliografici
14.15. Risposta educativa e sostegno alla famiglia
14.15.1. Introduzione
14.15.2. Linee guida per gli insegnanti
14.15.3. Risposta educativa nella scuola materna
14.15.4. Risposta educativa nella scuola primaria
14.15.5. Risposta educativa nella scuola secondaria
14.15.6. Coordinamento con le famiglie
14.15.7. Realizzazione di programmi
14.15.8. Riepilogo
14.15.9. Riferimenti bibliografici
Modulo 15. Dislessia, Discalculia e Iperattività
15.1. Concettualizzazione della dislessia
15.1.1. Introduzione
15.1.2. Definizione
15.1.3. Basi neurofisiologiche
15.1.4. Caratteristiche
15.1.5. Sottotipi
15.1.6. Riepilogo
15.1.7. Riferimenti bibliografici
15.2. Valutazione neuropsicologica della dislessia
15.2.1. Introduzione
15.2.2. Criteri diagnostici della dislessia
15.2.3. Come valutare
15.2.4. Colloquio con il tutor
15.2.5. Lettura e scrittura
15.2.6. Valutazione neuropsicologica
15.2.7. Valutazione di altri aspetti correlati
15.2.8. Riepilogo
15.2.9. Riferimenti bibliografici
15.3. Intervento neuropsicologico della dislessia
15.3.1. Introduzione
15.3.2. Variabili coinvolte
15.3.2. Ambito neuropsicologico
15.3.3. Programmi di intervento
15.3.4. Riepilogo
15.3.5. Riferimenti bibliografici
15.4. Concettualizzazione della discalculia
15.4.1. Introduzione
15.4.2. Definizione di discalculia
15.4.3. Caratteristiche
15.4.4. Basi neuropsicologiche
15.4.5. Riepilogo
15.4.6. Riferimenti bibliografici
15.5. Valutazione neuropsicologica della discalculia
15.5.1. Introduzione
15.5.2. Obiettivi della valutazione
15.5.3. Come valutare
15.5.4. Relazione
15.5.5. Diagnosi
15.5.6. Riepilogo
15.5.7. Riferimenti bibliografici
15.6. Intervento neuropsicologico per la discalculia
15.6.1. Introduzione
15.6.2. Variabili coinvolte nel trattamento
15.6.3. Riabilitazione neuropsicologica
15.6.4. ntervento di discalculia
15.6.5. Riepilogo
15.6.6. Riferimenti bibliografici
15.7. Concettualizzazione dell'ADHD
15.7.1. Introduzione
15.7.2. Definizione di ADHD
15.7.3. Basi neurofisiologiche
15.7.4. Caratteristiche dei bambini con ADHD
15.7.5. Sottotipi
15.7.6. Riepilogo
15.7.7. Riferimenti bibliografici
15.8. Valutazione neuropsicologica di ADHD
15.8.1. Introduzione
15.8.2. Obiettivi della valutazione
15.8.3. Come valutare
15.8.4. Relazione
15.8.5. Diagnosi
15.8.6. Riepilogo
15.8.7. Riferimenti bibliografici
15.9. Intervento neuropsicologico di ADHD
15.9.1. Introduzione
15.9.2. Ambito neuropsicologico
15.9.3. Trattamento di ADHD
15.9.4. Altre terapie
15.9.5. Programmi di intervento
15.9.6. Riepilogo
15.9.7. Riferimenti bibliografici
15.10. Comorbilità nei disturbi del neurosviluppo
15.10.1. Introduzione
15.10.2. Disturbi del neurosviluppo
15.10.3. Dislessia e discalculia
15.10.4. Dislessia e ADHD
15.10.5. Discalculia e ADHD
15.10.6. Riepilogo
15.10.7. Riferimenti bibliografici
15.11. Neurotecnologia
15.11.1. Introduzione
15.11.2. Applicata alla dislessia
15.11.3. Applicata alla discalculia
15.11.4. Applicato all'ADHD
15.11.5. Riepilogo
15.11.6. Riferimenti bibliografici
15.12. Orientamento per genitori e insegnanti
15.12.1. Introduzione
15.12.2. Orientamento sulla dislessia
15.12.3. Orientamento sulla discalculia
15.12.4. Orientamento sull’all'ADHD
15.12.5. Riepilogo
15.12.6. Riferimenti bibliografici
Modulo 16. Processi Neurolinguistici, Difficoltà e Programmi d’Intervento
16.1. Basi neurobiologiche coinvolte nel linguaggio
16.1.1. Introduzione
16.1.2. Definizioni del linguaggio
16.1.3. Antecedenti Storici
16.1.4. Riepilogo
16.1.5. Riferimenti bibliografici
16.2. Sviluppo del linguaggio
16.2.1. Introduzione
16.2.2. Emergenza del linguaggio
16.2.3. Acquisizione del linguaggio
16.2.4. Riepilogo
16.2.5. Riferimenti bibliografici
16.3. Approcci neuropsicologici al linguaggio
16.3.1. Introduzione
16.3.2. Processi cerebrali del linguaggio
16.3.3. Aree cerebrali coinvolte
16.3.4. Processi neurolinguistici
16.3.5. Centri cerebrali coinvolti nella comprensione
16.3.6. Riepilogo
16.3.7. Riferimenti bibliografici
16.4. Neuropsicologia della comprensione del linguaggio
16.4.1. Introduzione
16.4.2. Aree cerebrali coinvolti nella comprensione
16.4.3. I suoni
16.4.4. Strutture sintattiche per la comprensione della lingua
16.4.5. Processi semantici e apprendimento significativo
16.4.6. Comprensione della lettura
16.4.7. Riepilogo
16.4.8. Riferimenti bibliografici
16.5. Comunicazione attraverso il linguaggio
16.5.1. Introduzione
16.5.2. Il linguaggio come strumento di comunicazione
16.5.3. Evoluzione del linguaggio
16.5.4. La comunicazione sociale
16.5.5. Riepilogo
16.5.6. Riferimenti bibliografici
16.6. I disturbi del linguaggio
16.6.1. Introduzione
16.6.2. Disturbi del linguaggio e della parola
16.6.3. Professionisti coinvolti nel trattamento
16.6.4. Implicazioni in classe
16.6.5. Riepilogo
16.6.6. Riferimenti bibliografici
16.7. Afasia
16.7.1. Introduzione
16.7.2. Tipi di afasia
16.7.3. Diagnosi
16.7.4. Valutazione
16.7.5. Riepilogo
16.7.6. Riferimenti bibliografici
16.8. Stimolazione del linguaggio
16.8.1. Introduzione
16.8.2. Importanza della stimolazione del linguaggio
16.8.3. Stimolazione fonetico-fonologica
16.8.4. Stimolazione lessico-semantica
16.8.5. Stimolazione morfosintattica
16.8.6. Stimolazione pragmatica
16.8.7. Riepilogo
16.8.8. Riferimenti bibliografici
16.9. Disturbi della lettura e della scrittura
16.9.1. Introduzione
16.9.2. Lettura tardiva
16.9.3. Dislessia
16.9.4. Disortografia
16.9.5. Disgrafia
16.9.6. Dislalia
16.9.7. Trattamento dei disturbi di lettura e scrittura
16.9.8. Riepilogo
16.9.9. Riferimenti bibliografici
16.10. Valutazione e diagnosi delle difficoltà linguistiche
16.10.1. Introduzione
16.10.2. Valutazione del linguaggio
16.10.3. Procedure di valutazione del linguaggio
16.10.4. Test psicologici per la valutazione del linguaggio
16.10.5. Riepilogo
16.10.6. Riferimenti bibliografici
16.11. Interventi nei disturbi del linguaggio
16.11.1. Introduzione
16.11.2. Attuazione di programmi di miglioramento
16.11.3. Programmi di miglioramento
16.11.4. Programmi di miglioramento con le nuove tecnologie
16.11.5. Riepilogo
16.11.6. Riferimenti bibliografici
16.12. Impatto delle difficoltà linguistiche sul rendimento scolastico
16.12.1. Introduzione
16.12.2. Processi linguistici
16.12.3. Incidenza dei disturbi del linguaggio
16.12.4. Relazione tra udito e linguaggio
16.12.5. Riepilogo
16.12.6. Riferimenti bibliografici
16.13. Guida per genitori e insegnanti
16.13.1. Introduzione
16.13.2. Stimolazione del linguaggio
16.13.3. Stimolazione della lettura
16.13.4. Riepilogo
16.13.5. Riferimenti bibliografici
Modulo 17. Processi di Memoria, Competenze e TICS
17.1. Basi concettuali della memoria
17.1.1. Introduzione e obiettivi
17.1.2. Concetto e definizione di memoria
17.1.3. Processi di base della memoria
17.1.4. Prime ricerche sulla memoria
17.1.5. Classificazione della memoria
17.1.6. Memoria durante lo sviluppo
17.1.7. Strategie generali per la stimolazione della memoria
17.1.8. Riferimenti bibliografici
17.2. Memoria sensoriale
17.2.1. Introduzione e obiettivi
17.2.2. Concetto e definizione
17.2.3. Basi neurobiologiche della memoria sensoriale
17.2.4. Valutazione della memoria sensoriale
17.2.5. Intervento sulla memoria sensoriale in contesti educativi
17.2.6. Attività in famiglia per bambini dai tre ai cinque anni
17.2.7. Caso di intervento sulla memoria sensoriale
17.2.8. Riferimenti bibliografici
17.3. Memoria a breve termine
17.3.1. Introduzione e obiettivi
17.3.2. Concetto e definizione di memoria a breve termine e memoria di lavoro
17.3.3. Basi neurobiologiche della memoria a breve termine e di lavoro
17.3.4. Valutazione della memoria a breve termine e di lavoro
17.3.5. Intervento sulla memoria a breve termine in contesti educativi
17.3.6. Attività per famiglie per alunni dai sei agli undici anni
17.3.7. Studio di caso sull'intervento sulla memoria di lavoro
17.3.8. Riferimenti bibliografici
17.4. Memoria a lungo termine
17.4.1. Introduzione e obiettivi
17.4.2. Concetto e definizione
17.4.3. Basi neurobiologiche della memoria a lungo termine
17.4.4. Valutazione della memoria a lungo termine
17.4.5. Intervento sulla memoria a lungo termine in contesti educativi
17.4.6. Attività per famiglie per alunni dai dodici ai diciotto anni
17.4.7. Studio di caso di intervento sulla memoria a lungo termine
17.5. Disturbi della memoria
17.5.1. Introduzione e obiettivi
17.5.2. Memoria ed emozione
17.5.3. Oblio Teorie dell'oblio
17.5.4. Distorsioni della memoria
17.5.5. Alterazioni della memoria: amnesia
17.5.6. Amnesia dell'infanzia
17.5.7. Altri tipi di disturbi della memoria
17.5.8. Programmi di miglioramento della memoria
17.5.9. Programmi tecnologici per il miglioramento della memoria
17.5.10. Riferimenti bibliografici
17.6. Capacità di pensiero
17.6.1. Introduzione e obiettivi
17.6.2. Sviluppo del pensiero dall'infanzia all'età adulta
17.6.3. Processi base di pensiero
17.6.4. Capacità di pensiero
17.6.5. Pensiero critico
17.6.6. Caratteristiche dei nativi digitali
17.6.7. Riferimenti bibliografici
17.7. Neurobiologia del pensiero
17.7.1. Introduzione e obiettivi
17.7.2. Basi neurobiologiche del pensiero
17.7.3. Distorsioni cognitive
17.7.4. Strumenti di valutazione neuropsicologica
17.7.5. Riferimenti bibliografici
17.8. Intervento cognitivo
17.8.1. Introduzione e obiettivi
17.8.2. Strategie di apprendimento
17.8.3. Tecniche di stimolazione cognitiva in contesti educativi
17.8.4. Metodi di studio a domicilio
17.8.5. Attività nell'ambiente familiare per la stimolazione cognitiva
17.8.6. Studio di caso sull'intervento delle strategie di apprendimento
17.8.7. Riferimenti bibliografici
17.9. Teorie cognitive del pensiero
17.9.1. Introduzione e obiettivi
17.9.2. Teoria dell'apprendimento significativo
17.9.3. Teoria dell'elaborazione delle informazioni
17.9.4. Teoria genetica: costruttivismo
17.9.5. Teoria socio-culturale: socio-costruttivismo
17.9.6. Teoria del connettivismo
17.9.7. Metacognizione: imparare a pensare
17.9.8. Programmi per l'acquisizione di capacità di pensiero
17.9.9. Programmi per l'acquisizione di capacità di pensiero
17.9.10. Caso di studio dell'intervento sulle abilità di pensiero
17.9.11. Riferimenti bibliografici
Modulo 18. Metodologia della Ricerca I
18.1. Metodologia di ricerca
18.1.1. Introduzione
18.1.2. L'importanza della metodologia di ricerca
18.1.3. La conoscenza scientifica
18.1.4. Approcci di ricerca
18.1.5. Riepilogo
18.1.6. Riferimenti bibliografici
18.2. Scelta dell'argomento di ricerca
18.2.1. Introduzione
18.2.2. Il problema di ricerca
18.2.3. Definizione del problema
18.2.4. Scelta della domanda di ricerca
18.2.5. Obiettivi di ricerca
18.2.6. Variabili: Tipologie
18.2.7. Riepilogo
18.2.8. Riferimenti bibliografici
18.3. La proposta di ricerca
18.3.1. Introduzione
18.3.2. Le ipotesi della ricerca
18.3.3. Fattibilità del progetto di ricerca
18.3.4. Introduzione e giustificazione della ricerca
18.3.5. Riepilogo
18.3.6. Riferimenti bibliografici
18.4. Il quadro teorico
18.4.1. Introduzione
18.4.2. Elaborazione del quadro teorico
18.4.3. Risorse utilizzate
18.4.4. Standard APA
18.4.5. Riepilogo
18.4.6. Riferimenti bibliografici
18.5. Bibliografia
18.5.1. Introduzione
18.5.2. Importanza dei riferimenti bibliografici
18.5.3. Come fare riferimenti secondo gli standard APA
18.5.4. Formato degli allegati: Tabelle e Figure
18.5.5. Gestori di bibliografia: Cosa sono e come usarli
18.5.6. Riepilogo
18.5.7. Riferimenti bibliografici
18.6. Quadro metodologico
18.6.1. Introduzione
18.6.2. Tabella di marcia
18.6.3. Sezioni da contenere nel quadro metodologico
18.6.4. La popolazione
18.6.5. La mostra
18.6.6. Variabili
18.6.7. Strumenti
18.6.8. Procedura
18.6.9. Riepilogo
18.6.10. Riferimenti bibliografici
18.7. Disegni di Ricerca
18.7.1. Introduzione
18.7.2. Tipi di design
18.7.3. Caratteristiche dei disegni utilizzati in psicologia
18.7.4. Disegni di ricerca usati nell'educazione
18.7.5. Disegni di ricerca utilizzati in neuropsicologia educativa
18.7.6. Riepilogo
18.7.7. Riferimenti bibliografici
18.8. Ricerca quantitativa
18.8.1. Introduzione
18.8.2. Disegni randomizzati a grappolo
18.8.3. Disegni a gruppi randomizzati con blocchi
18.8.4. Altri disegni utilizzati in psicologia
18.8.5. Tecniche statistiche nella ricerca quantitativa
18.8.6. Riepilogo
18.8.7. Riferimenti bibliografici
18.9. Ricerca quantitativa II
18.9.1. Introduzione
18.9.2. Disegni unificati intrasoggetto
18.9.3. Tecniche di controllo degli effetti dei disegni intrasoggetto
18.9.4. Tecniche statistiche
18.9.5. Riepilogo
18.9.6. Riferimenti bibliografici
18.10. Risultati
18.10.1. Introduzione
18.10.2. Come raccogliere i dati
18.10.3. Come analizzare i dati
18.10.4. Programmi statistici
18.10.5. Riepilogo
18.10.6. Riferimenti bibliografici
18.11. Statistica descrittiva
18.11.1. Introduzione
18.11.2. Variabili nella ricerca
18.11.3. Analisi quantitativa
18.11.4. Analisi qualitativa
18.11.5. Risorse che possono essere utilizzate
18.11.6. Riepilogo
18.11.7. Riferimenti bibliografici
18.12. Test delle ipotesi
18.12.1. Introduzione
18.12.2. Ipotesi statistiche
18.12.3. Come interpretare la significatività (p-value)
18.12.4. Criteri per l'analisi dei test parametrici e non parametrici
18.12.5. Riepilogo
18.12.6. Riferimenti bibliografici
18.13. Statistiche di correlazione e analisi dell'indipendenza
18.13.1. Introduzione
18.13.2. Correlazione di Pearson
18.13.3. Correlazione di Spearman e chi-quadro
18.13.4. Risultati
18.13.5. Riepilogo
18.13.6. Riferimenti bibliografici
18.14. Statistiche di confronto tra gruppi
18.14.1. Introduzione
18.14.2. Test T di Mann-Whitney e test U di Mann-Whitney
18.14.3. T-test e Wilcoxon Signed Ranges
18.14.4. I risultati
18.14.5. Riepilogo
18.14.6. Riferimenti bibliografici
18.15. Discussione e conclusioni
18.15.1. Introduzione
18.15.2. Qual è la discussione
18.15.3. Organizzazione della discussione
18.15.4. Conclusioni
18.15.5. Limiti e previsioni
18.15.6. Riepilogo
18.15.7. Riferimenti bibliografici
18.16. Preparazione della Tesi di Master
18.16.1. Introduzione
18.16.2. Copertina e indice
18.16.3. Introduzione e giustificazione
18.16.4. Quadro teorico
18.16.5. Quadro metodologico
18.16.6. I risultati
18.16.7. Programmi di intervento
18.16.8. Discussione e conclusioni
18.16.9. Riepilogo
18.16.10. Riferimenti bibliografici
Modulo 19. Metodologia della Ricerca II
19.1. La ricerca nell'educazione
19.1.1. Introduzione
19.1.2. Caratteristiche di ricerca
19.1.3. Ricerca in classe
19.1.4. Chiavi necessarie per la ricerca
19.1.5. Esempi
19.1.6. Riepilogo
19.1.7. Riferimenti bibliografici
19.2. La ricerca neuropsicologica
19.2.1. Introduzione
19.2.2. La ricerca neuropsicologica educativa
19.2.3. La conoscenza e il metodo scientifico
19.2.4. Tipi di approcci
19.2.5. Fasi dell'indagine
19.2.6. Riepilogo
19.2.7. Riferimenti bibliografici
19.3. L'etica nella ricerca
19.3.1. Introduzione
19.3.2. Consenso informato
19.3.3. Legge di protezione dei dati
19.3.4. Riepilogo
19.3.5. Riferimenti bibliografici
19.4. Affidabilità e validità
19.4.1. Introduzione
19.4.2. Affidabilità e validità nella ricerca
19.4.3. Affidabilità e validità nella valutazione
19.4.4. Riepilogo
19.4.5. Riferimenti bibliografici
19.5. Variabili di controllo nella ricerca
19.5.1. Introduzione
19.5.2. Scelta di variabili
19.5.3. Controllo delle variabili
19.5.4. Selezione del campione
19.5.5. Riepilogo
19.5.6. Riferimenti bibliografici
19.6. L'approccio di ricerca quantitativa
19.6.1. Introduzione
19.6.2. Caratteristiche
19.6.3. Tappe
19.6.4. Strumenti di valutazione
19.6.5. Riepilogo
19.6.6. Riferimenti bibliografici
19.7. L'approccio di ricerca qualitativa I
19.7.1. Introduzione
19.7.2. L'osservazione sistematica
19.7.3. Fasi dell'indagine
19.7.4. Tecniche di campionatura
19.7.5. Controllo della qualità
19.7.6. Tecniche statistiche
19.7.7. Riepilogo
19.7.8. Riferimenti bibliografici
19.8. L'approccio di ricerca qualitativa II
19.8.1. Introduzione
19.8.2. L'indagine
19.8.3. Tecniche di campionatura
19.8.4. Fasi del sondaggio
19.8.5. Progetti di ricerca
19.8.6. Tecniche statistiche
19.8.7. Riepilogo
19.8.8. Riferimenti bibliografici
19.9. L'approccio di ricerca qualitativa III
19.9.1. Introduzione
19.9.2. Tipi di interviste e caratteristiche
19.9.3. Preparazione al colloquio
19.9.4. Colloqui di gruppo
19.9.5. Tecniche statistiche
19.9.6. Riepilogo
19.9.7. Riferimenti bibliografici
19.10. Progetto di caso singolo
19.10.1. Introduzione
19.10.2. Caratteristiche
19.10.3. Tipologie
19.10.4. Tecniche statistiche
19.10.5. Riepilogo
19.10.6. Riferimenti bibliografici
19.11. La ricerca-azione
19.11.1. Introduzione
19.11.2. Obiettivi di ricerca-azione
19.11.3. Caratteristiche
19.11.4. Fasi
19.11.5. Miti
19.11.6. Esempi
19.11.7. Riepilogo
19.11.8. Riferimenti bibliografici
19.12. Raccolta di informazioni in una ricerca
19.12.1. Introduzione
19.12.2. Tecniche di raccolta dati
19.12.3. Valutazione dell'indagine
19.12.4. Valutazione
19.12.5. Interpretazione di risultati
19.12.6. Riepilogo
19.12.7. Riferimenti bibliografici
19.13. Gestione dei dati nella ricerca
19.13.1. Introduzione
19.13.2. Database
19.13.3. Dati in Excel
19.13.4. Dati in SPSS
19.13.5. Riepilogo
19.13.6. Riferimenti bibliografici
19.14. Diffusione dei risultati in neuropsicologia
19.14.1. Introduzione
19.14.2. Pubblicità
19.14.3. Riviste specializzate
19.14.4. Riepilogo
19.14.5. Riferimenti bibliografici
19.15. Le riviste scientifiche
19.15.1. Introduzione
19.15.2. Caratteristiche
19.15.3. Tipi di riviste
19.15.4. Indicatori di qualità
19.15.5. Invio di articoli
19.15.6. Riepilogo
19.15.7. Riferimenti bibliografici
19.16. Articolo scientifico
19.16.1. Introduzione
19.16.2. Tipi e caratteristiche
19.16.3. Struttura
19.16.4. Indicatori di qualità
19.16.5. Riepilogo
19.16.6. Riferimenti bibliografici
19.17. Congressi scientifici
19.17.1. Introduzione
19.17.2. Importanza dei congressi
19.17.3. Comitato scientifico
19.17.4. Comunicazioni orali
19.17.5. Il poster scientifico
19.17.6. Riepilogo
19.17.7. Riferimenti bibliografici

Aprovecha la oportunidad para conocer los últimos avances en esta materia para aplicarla a tu práctica diaria"
Master Specialistico in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione
Gli studi neurologici hanno fatto notevoli progressi negli ultimi anni, consentendo a professionisti di vari settori di integrare i propri fondamenti nelle proprie discipline. Nel caso della psicologia e dell’educazione, conoscere come funziona il cervello è necessario, non solo per migliorare i processi di ricerca, ma per far avanzare i metodi di assistenza che possono offrire ai pazienti. Per questo motivo, in TECH Università Tecnologica sviluppiamo il Master Specialistico in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione , un programma che affronta in modo completo e aggiornato i concetti e gli argomenti più rilevanti di queste scienze emergenti. Potrai così raggiungere un livello di conoscenza più elevato in questo campo e realizzare interventi di qualità che mettono in risalto le tue capacità e ti rendono un riferimento.
Specializzati in Neuropsicologia Clinica e Neuroeducazione
Attraverso un programma innovativo, con metodologie uniche focalizzate sull'apprendimento online e insieme al supporto di esperti del settore, il nostro Master Specialistico si distingue come un'opportunità nuova, completa ed efficace per specializzarsi nella pratica professionale della neuroeducazione e della neuropsicologia. Approfondirai il funzionamento globale del cervello e il modo in cui alcuni fattori biochimici influenzano la sua attività; Sarai in grado di comprendere, riconoscere e rispondere ai disturbi neurologici più comuni e svilupperai programmi che funzionano come strumento per migliorare i processi di apprendimento e prestazione dei tuoi pazienti. Nella più grande Facoltà di Psicologia troverai gli strumenti necessari per raggiungere un livello di conoscenza più elevato e avanzare in tutti i tuoi obiettivi professionali.