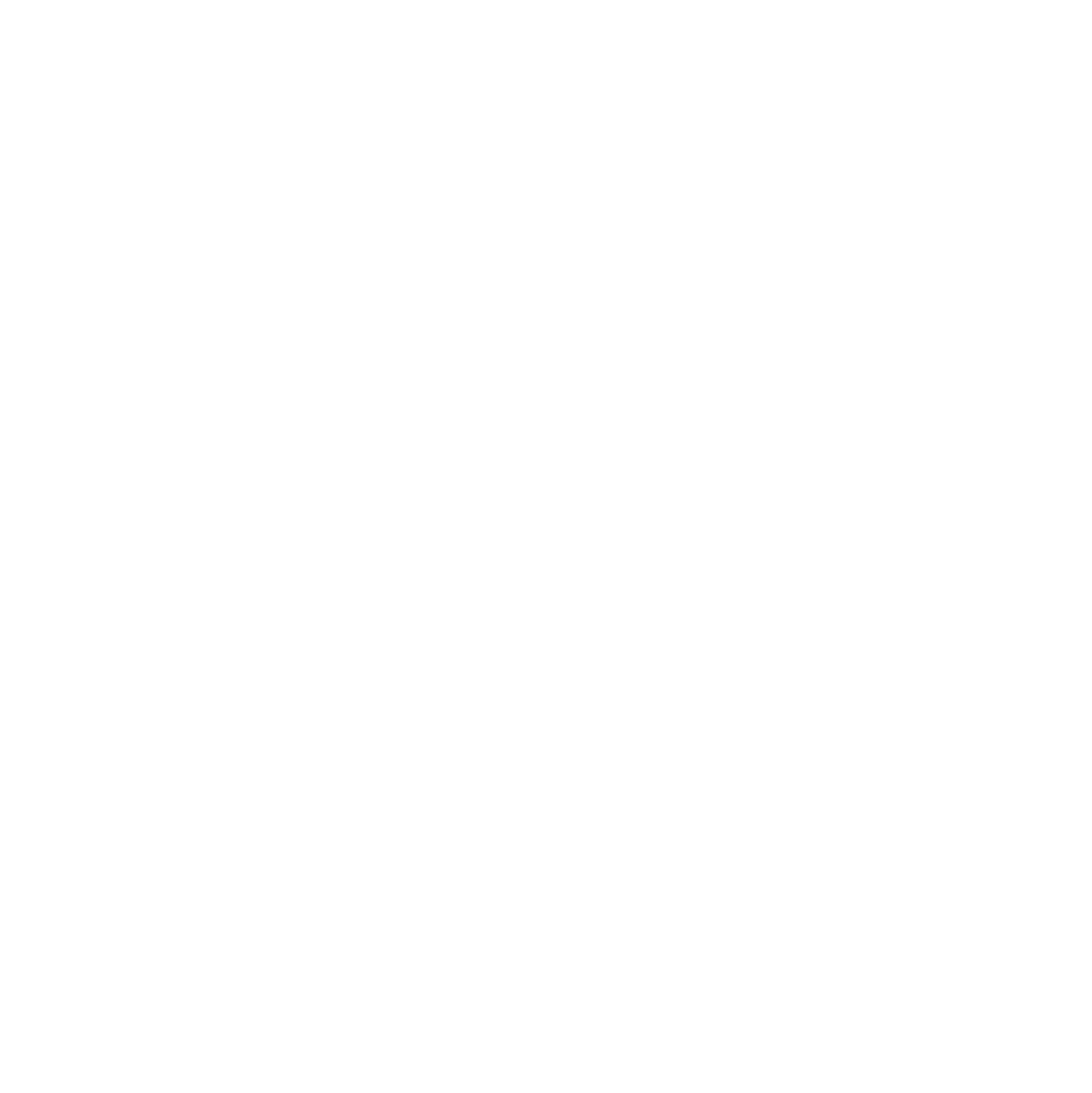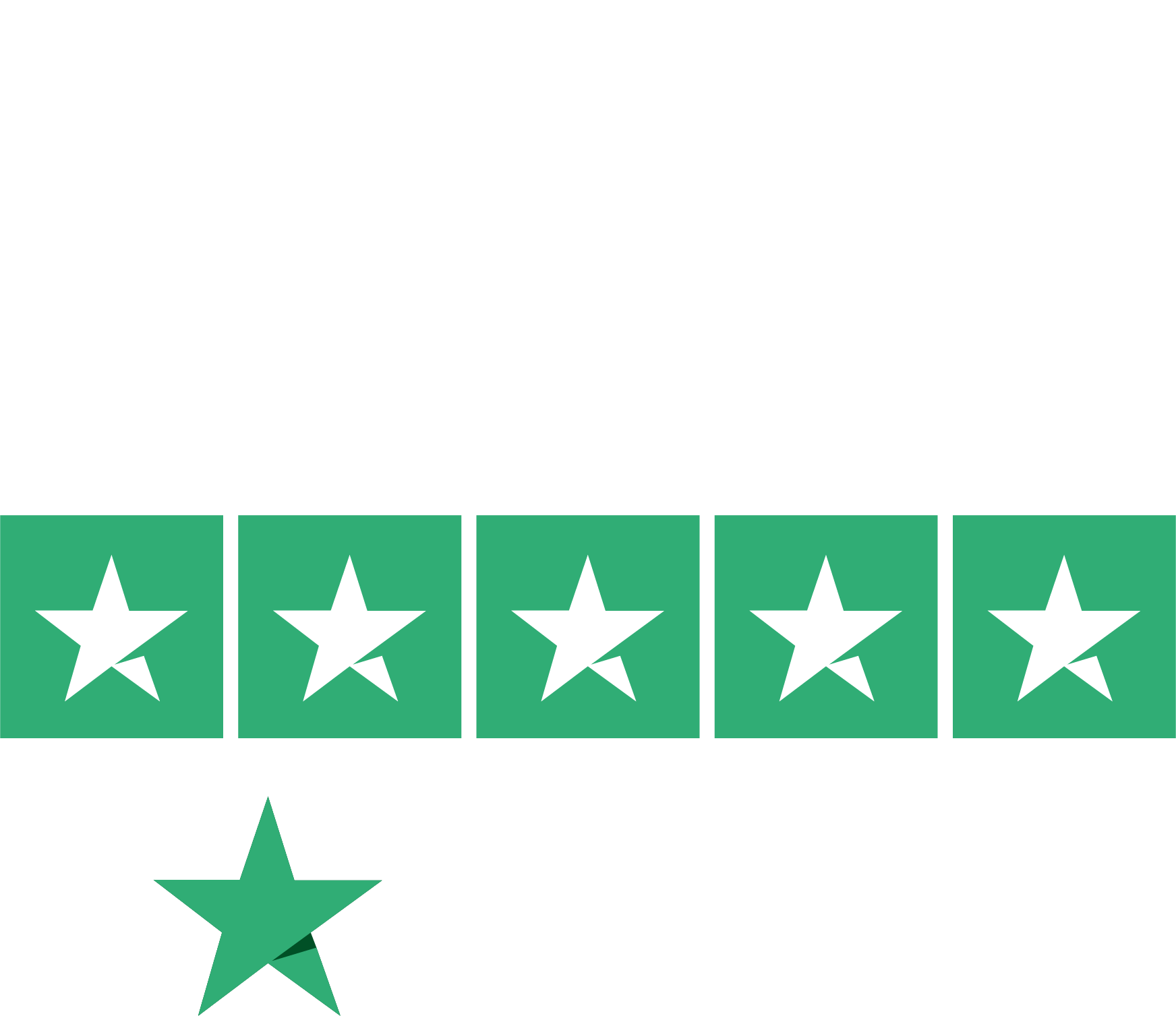Titolo universitario
La più grande facoltà di psicologia del mondo"
Presentazioni
Un programma completo che ti permetterà di conseguire una specializzazione intensiva in ogni singolo aspetto in materia di Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento"
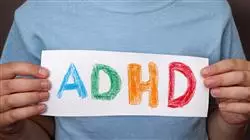
La scuola deve avere una maggiore responsabilità nell'educazione ai valori, nell'incorporazione dell'intelligenza emotiva, nella relazione insegnante/studente, nella convivenza con persone diverse (scuola inclusiva), per offrire ai nostri bambini e giovani uno sviluppo più ottimale in questi tempi di trasformazioni vertiginose.
La prospettiva del paradigma educativo emergente deve essere inclusiva e deve basarsi su un modello biopsicosociale che consideri l'attenzione alla diversità da un approccio globale rivolto all'intera comunità educativa. Gli insegnanti dei diversi gradi di istruzione e delle professioni affini, sia in ambito educativo che socio-sanitario, devono conoscere le caratteristiche di questi studenti, saper individuare i loro bisogni e disporre delle conoscenze e degli strumenti per intervenire a livello socio-familiare e soprattutto educativo.
In aggiunta a questo, la neuroscienza sta fornendo sempre più informazioni e indizi su come funziona il nostro cervello e come apprendere meglio, mettendo in discussione il sistema di insegnamento-apprendimento su cui ci siamo basati negli ultimi tempi. Allo stesso modo, il nostro cervello è continuamente esposto alla presenza, altrimenti inevitabile, delle nuove tecnologie: acquisiamo conoscenze e ci relazioniamo "in connessione continua" con gli altri attraverso gli schermi e questo fatto sta già causando cambiamenti nel modo in cui impariamo.
La specializzazione che presentiamo rappresenta lo sforzo di raccogliere le conoscenze che già possedevamo sulle Difficoltà di Apprendimento, incorporando i nuovi progressi delle neuroscienze, della psicologia educativa e clinica e della pedagogia, nonché gli aspetti delle Nuove Tecnologie che possono aiutare a lavorare con questa popolazione. Si tratta quindi di un Master specialistico unico, che offre una visione ampia e globale inquadrata nel XXI secolo e, allo stesso tempo, ha un approccio pratico, utile e orientato ai problemi reali che incontreremo.
Offre agli studenti una preparazione per diventare competenti in un'area di performance professionale dove non solo padroneggeranno l'uso di tecniche o strumenti per valutare e progettare interventi individuali o di gruppo. Li collocherà anche in un nuovo quadro di lavoro, sempre più caratterizzato dal lavoro collaborativo con altri professionisti, e dalla richiesta fatta agli psicologi di guida e consulenza nella progettazione di ambienti educativi, dove gli studenti con difficoltà di apprendimento devono essere presenti e i loro bisogni educativi specifici possono essere soddisfatti.
Un Master specialistico creato specialmente per i professionisti che cercano la massima qualificazione, con il miglior materiale didattico, lavorando su casi reali e imparando dai migliori esperti del settore"
Questo Master specialistico in Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento possiede il programma più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Sviluppo di casi o situazioni presentati da esperti nelle diverse specialità
- Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici
- Novità, progressi e nuove metodologie di lavoro
- Presentazione di seminari pratici di applicazione delle tecniche e metodologie presentate
- Immagini reali in alta risoluzione nelle dimostrazioni
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- Sistema di apprendimento interattivo basato su algoritmi per sviluppare la capacità di prendere decisioni su situazioni determinate
- Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutore, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
Questo Master specialistico può essere il miglior investimento che tu possa fare nella scelta di un programma di aggiornamento per due motivi: oltre a rinnovare le tue conoscenze in Gestione e Intervento nelle Difficoltà di Apprendimento, otterrai una qualifica rilasciata da TECH Università Tecnologica”
Il suo personale docente comprende professionisti del settore, che apportano la loro esperienza lavorativa a questa specializzazione, nonché specialisti riconosciuti in materia provenienti da diverse aree correlate.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La creazione di questo programma è centrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale il professionista dovrà cercare di risolvere i diversi casi pratici che gli verranno presentati durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.
Cogli l'opportunità di conoscere gli ultimi progressi in questo ambito e applicali al tuo lavoro quotidiano"

Cogli l’opportunità per conoscere gli ultimi progressi in Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento, e migliora la tua capacità docente con la padronanza delle tecniche più innovative: il modo più sicuro di posizionarti tra i migliori"
Programma
La struttura dei contenuti è stata disegnata da una squadra di professionisti dei migliori centri e Università spagnole. Consapevoli della rilevanza dell'attuale specializzazione, hanno creato un percorso didattico in cui ogni materia affronta uno degli aspetti rilevanti per lo sviluppo di un professionista altamente competente. Tutto ciò costituisce un programma di alta intensità e qualità senza pari, che include teoria e pratica virtuale all'avanguardia, e che ti spingerà al livello più completo di padronanza in questo settore.

Questo Master specialistico è un'opportunità incomparabile per ottenere, in un'unica specializzazione, tutte le conoscenze necessarie in materia di Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento"
Modulo 1. Sviluppo neurologico e apprendimento
1.1. Sviluppo neurologico e apprendimento: Sviluppo prenatale
1.2. Sistema nervoso e apprendimento post-natale
1.3. Neuroanatomia dell’apprendimento
1.4. Concetto di plasticità cerebrale
1.5. Sviluppo delle funzioni cognitive superiori
1.6. Processi cognitivi e apprendimento (I): l’attenzione e la scelta delle risorse cognitive
1.7. Processi cognitivi e apprendimento (II): la percezione e l'acquisizione di informazioni
1.8. Processi cognitivi e apprendimento (III): la memoria e il suo funzionamento
1.9. Processi cognitivi e apprendimento (IV): il processo di codifica delle informazioni
1.10. Processi cognitivi e apprendimento (V): Il processo di recupero dell’informazione: il trasferimento dell’apprendimento
1.11. Processi cognitivi e apprendimento (VI): raggruppamento, classificazione e preparazione di categorie e concetti
1.12. Variabili affettive, motivazionali, relazionali (I): variabili personali
1.13. Variabili affettive, motivazionali, relazionali (II): la famiglia
1.14. Variabili affettive, motivazionali, relazionali (III): la Scuola
1.15. Variabili affettive, motivazionali, relazionali (IV): la comunità
Modulo 2. Le difficoltà di apprendimento. Progettare l’intervento
2.1. Difficoltà di apprendimento (I): origine e definizione
2.2. Difficoltà di apprendimento (II): classificazione delle Difficoltà di Apprendimento
2.3. Difficoltà di apprendimento (III): Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Comorbidità
2.4. Difficoltà di apprendimento (IV): Prevalenza delle Difficoltà di Apprendimento
2.5. Difficoltà di apprendimento (V): fattori di rischio e segnali di allarme
2.6. Progettare la Valutazione e l’Intervento (I): condizioni nella valutazione
2.7. Progettare la Valutazione e l’Intervento (II): Intervento precoce
2.8. Progettare la Valutazione e l’Intervento (III): tecniche e strumenti di valutazione
2.9. Progettare la Valutazione e l’Intervento (IV): comunicazione e amministrazione di prove
2.10. Progettare la Valutazione e l’Intervento (V): correzione, interpretazione e implementazione del rapporto di valutazione
2.11. Progettare la Valutazione e l’Intervento (VI): Creazione del piano di intervento
2.12. Progettare la Valutazione e l’Intervento (VII): Follow del piano di Intervento
2.13. Buone pratiche (I): lavoro in rete e comunicazione con la famiglia
2.14. Buone pratiche (II): quadro giuridico e normativo
Modulo 3. Disturbi specifici dell'apprendimento
3.1. L’apprendimento della lettura, scrittura e della matematica nell'infanzia
3.2. Definizione e prevalenza
3.3. Basi neurobiologiche
3.4. Approcci neuropsicologici
3.5. Tipi di Dislessia, Disgrafia e Discalculia
3.6. Criteri diagnostici (I): DSM-V: Con limiti nella lettura (Dislessia), con difficoltà nell’espressione scritta (Disgrafia), con difficoltà in matematica (Discalculia)
3.7. Criteri diagnostici (II): diagnosi differenziale DSM-V e CIE-10
3.8. Valutazione: variabili a valutare e tecniche e strumenti
3.9. Intervento psicologico e psicopedagogico: programmi di intervento
Modulo 4. Disturbi della comunicazione e difficoltà di apprendimento
4.1. Sviluppo del linguaggio nell’infanzia
4.2. Definizione e prevalenza
4.3. Basi neurobiologiche
4.4. Approcci neuropsicologici
4.5. Classificazione delle alterazioni nella comprensione, produzione-espressione e pronuncia
4.6. Criteri diagnostici (I): DSM-5: Disturbo del linguaggio. Disturbo Fonologico
4.7. Criteri diagnostici (II): DSM-5: Disturbo della fluidità di origine infantile (Balbuzie)
4.8. Disturbo della comunicazione sociale (pragmatico)
4.9. Criteri diagnostici (III): Diagnosi differenziale. DSM-5 e CIE-10
4.10. Valutazione: Variabili a valutare e tecniche e strumenti
4.11. Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
Modulo 5. Basi teoriche e metodologiche dell'attenzione alla diversità e alle difficoltà di apprendimento nei bambini
5.1. Introduzione
5.2. Basi filosofiche, sociologiche, psicologiche e pedagogiche dell'attenzione alla diversità e alle difficoltà di apprendimento nei bambini
5.2.1. Definizioni di base
5.2.1.1. La psicologia e i suoi fondamenti
5.2.1.2. La pedagogia e i suoi fondamenti
5.2.1.3. Processo educativo
5.2.1.4. Processo di insegnamento-apprendimento
5.2.2. Contributi della psicologia alla pedagogia in quanto scienza
5.2.2.1. Nell'ordine teorico
5.2.2.2. Nell'ordine metodologico
5.2.2.3. Nell'ordine pratico
5.2.3. Influenza della psicologia educativa sulle difficoltà di apprendimento
5.2.3.1. Prospettiva comportamentale
5.2.3.2. Prospettiva cognitiva (funzioni e processi psichici)
5.2.3.3. Prospettiva affettiva
5.3. La psicopedagogia come scienza che affronta le sfide dell'educazione alla diversità e della cura dei bambini con difficoltà di apprendimento
5.3.1. Oggetto di studio della psicopedagogia
5.3.2. Sistema categoriale della psicopedagogia
5.3.3. Principi della psicopedagogia
5.3.4. Sfide della psicopedagogia nel XXI secolo
5.4. Caratterizzazione psicopedagogica dei bambini e degli adolescenti che frequentano diversi livelli di istruzione
5.4.1. Definizioni di base
5.4.1.1. La personalità e le sue origini
5.4.1.1.1. Fattore biologico
5.4.1.1.2. Fattore innato
5.4.1.1.3. Fattore ereditario
5.4.1.1.4. Fattore genetico
5.4.1.2. Lo sviluppo cognitivo e la sua rilevanza teorico-pratica per la cura delle DSA
5.4.1.2.1. Aspetto organico
5.4.1.2.2. Aspetto maturativo
5.4.1.2.3. Aspetto funzionale
5.4.1.2.4. Aspetto sociale
5.4.1.2.5. Aspetto educativo
5.4.1.3. Apprendimento
5.4.1.3.1. Approccio alla sua concettualizzazione
5.4.1.3.2. Condizioni necessarie per l'apprendimento
5.4.2. Caratteristiche psicopedagogiche dell'alunno della scuola primaria
5.4.2.1. Il bambino da 6 a 8 anni
5.4.2.1.1. Il bambino di prima elementare
5.4.2.1.2. Il bambino di seconda elementare
5.4.2.2. Il bambino da 8 a 10 anni
5.4.2.2.1. Il bambino di terza elementare
5.4.2.2.2. Il bambino di quarta elementare
5.4.2.3. Il bambino da 10 a 12 anni
5.4.2.3.1. Il bambino di quinta elementare
5.4.2.3.2. Il bambino di prima media
5.5. L'apprendimento come processo individuale e sociale
5.5.1. Strategie cognitive
5.5.2. Strategie di apprendimento
5.5.3. Strategie per ricordare
5.5.4. Strategie di fidelizzazione
5.5.5. Strategie di richiamo
5.5.6. Strategie di risoluzione dei problemi
5.6. Il processo di insegnamento-apprendimento nella scuola primaria
5.6.1. Approccio alla sua definizione
5.6.1.1. Processo di insegnamento-apprendimento
5.6.1.2. Processo di insegnamento-apprendimento evolutivo
5.6.2. Caratteristiche del processo di insegnamento-apprendimento evolutivo
5.6.3. Potenzialità del processo di insegnamento-apprendimento evolutivo
5.6.4. La cooperazione, una condizione necessaria nel processo di insegnamento-apprendimento
5.6.4.1. Apprendimento cooperativo
5.6.4.1.1. Definizione
5.6.4.1.2. Tipi di gruppi cooperativi
5.6.4.1.3. Caratteristiche dell’apprendimento cooperativo
5.6.5. Forme di partecipazione all'apprendimento cooperativo
5.6.5.1. In aula
5.6.5.2. In altri spazi di apprendimento della scuola
5.6.5.3. In famiglia
5.6.5.4. Nella comunità
5.6.6. Struttura di una lezione di apprendimento cooperativo
5.6.6.1. Momento di partenza
5.6.6.2. Momento di sviluppo
5.6.6.3. Momento di chiusura
5.6.7. Creare ambienti favorevoli all'apprendimento
Modulo 6. Difficoltà di apprendimento: approccio storico, concettualizzazione, teorie e classificazione
6.1. Introduzione
6.2. Uno sguardo storico sulle difficoltà di apprendimento
6.2.1. Fase di fondazione
6.2.2. Fase di transizione
6.2.3. Fase di consolidamento
6.2.4. Fase attuale
6.3. Una visione critica della sua concettualizzazione
6.3.1. Criteri applicati per la sua definizione
6.3.1.1. Criteri di esclusione
6.3.1.2. Criterio di discrepanza
6.3.1.3. Criterio di specificità
6.3.2. Alcune definizioni e le loro regolarità
6.3.3. Tra eterogeneità e differenziazione
6.3.3.1. Problemi scolastici
6.3.3.2. Risultati insufficienti
6.3.3.3. Difficoltà specifiche di apprendimento
6.3.4. Disabilità di apprendimento vs difficoltà di apprendimento
6.3.4.1. Il disturbo dell'apprendimento
6.3.4.1.1. Definizione
6.3.4.1.2. Caratteristiche
6.3.4.2. Punti di convergenza tra il disturbo e le difficoltà di apprendimento che ne rendono difficile la comprensione
6.3.4.3. Differenze tra disturbi di apprendimento e difficoltà di apprendimento che determinano il loro contesto di applicazione e la loro rilevanza
6.3.4.4. Bisogni educativi specifici (BES) e difficoltà di apprendimento
6.3.4.4.1. Definizione di bisogni educativi specifici
6.3.4.4.2. I BES e le loro differenze e similarità con le difficoltà di apprendimento
6.4. Classificazione delle difficoltà di apprendimento
6.4.1. Sistemi di classificazione internazionale
6.4.1.1. DCM-5
6.4.1.2. ICD-10
6.4.2. Classificazione delle difficoltà di apprendimento nel DCM-5
6.4.3. Classificazione delle difficoltà di apprendimento nel ICD-10
6.4.4. Confronto tra gli strumenti di classificazione
6.5. Principali approcci teorici alle difficoltà di apprendimento
6.5.1. Teorie neurobiologiche o organiciste
6.5.2. Teorie dei processi cognitivi deficitari
6.5.3. Teorie psicolinguistiche
6.5.4. Teorie psicogene
6.5.5. Teorie ambientaliste
6.6. Cause delle difficoltà di apprendimento
6.6.1. Fattori personali o intrinseci
6.6.1.1. Biologici
6.6.1.2. Psicogeni
6.6.2. Fattori contestuali o estrinseci
6.6.2.1. Ambientali
6.6.2.2. Istituzionali
6.7. Modelli di assistenza per le difficoltà di apprendimento
6.7.1. Modelli incentrati sugli aspetti medico-clinici
6.7.2. Modelli incentrati sui processi cognitivi
6.7.3. Modelli incentrati sui deficit osservabili
6.7.4. Modelli incentrati sul piano di studi
6.7.5. Modello di educazione all'assistenza completa
6.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
6.9. Letture consigliate
6.10. Bibliografia
Modulo 7. Riflessioni sulla Diagnosi e sulla Valutazione delle Difficoltà di Apprendimento
7.1. Introduzione
7.2. Diagnosi e caratteristiche distintive
7.2.1. Definizione
7.2.2. Principi e funzioni del processo diagnostico
7.2.3. Caratteristiche della diagnosi
7.2.4. Tipi di diagnosi: precoce e psicopedagogica
7.3. Particolarità del processo di valutazione
7.3.1. Valutazione educativa
7.3.2. Valutazione psicopedagogica
7.4. Relazioni tra la diagnosi e la valutazione
7.4.1. Controversia teorica tra i due concetti
7.4.2. Complementarità dei processi di diagnosi e di valutazione
7.5. Il processo di diagnosi e valutazione delle difficoltà di apprendimento
7.5.1. Definizioni
7.5.1.1. La diagnosi e le sue particolarità
7.5.1.2. La valutazione e le sue particolarità
7.5.2. Tecniche e strumenti per la diagnosi e la valutazione
7.5.2.1. Dall'approccio qualitativo
7.5.2.2. Basato su test standardizzati
7.5.2.3. Approccio di valutazione educativa completa
7.6. Il gruppo di valutazione e la sua composizione da una prospettiva interdisciplinare
7.6.1. Potenzialità della composizione del gruppo di valutazione
7.6.2. Particolarità del gruppo di valutazione in base al funzionamento
7.6.3. Il ruolo di ciascun membro del team nel processo diagnostico
7.7. La relazione psicopedagogica come strumento per comunicare i livelli di sviluppo dello studente con difficoltà di apprendimento
7.7.1. Duplice scopo del rapporto
7.7.1.1. Nella valutazione
7.7.1.2. Nell’attenzione
7.7.2. Aspetti essenziali che ne costituiscono la struttura
7.7.2.1. Dati personali
7.7.2.2. Motivo valutazione
7.7.2.3. Informazioni sullo sviluppo del bambino
7.7.2.3.1. Antecedenti personali
7.7.2.3.2. Antecedenti familiari
7.7.2.3.3. Aspetti psico-sociali
7.7.2.3.4. Aspetti scolastici
7.7.2.3.5. Tecniche e strumenti di valutazione applicati
7.7.2.3.6. Analisi dei risultati ottenuti
7.7.2.4. Conclusioni
7.7.2.5. Raccomandazioni
7.7.3. Particolarità delle modalità di redazione
7.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
7.9. Letture consigliate
7.10. Bibliografia
Modulo 8. Fondamenti di Gestione delle Difficoltà di Apprendimento
8.1. Introduzione
8.2. La prevenzione delle difficoltà di apprendimento
8.2.1. Livelli di prevenzione
8.2.2. Fattori di rischio
8.2.3. Fattore protettivi
8.3. Intervento psicopedagogico nelle DSA
8.3.1. Definizione
8.3.2. Principi
8.3.3. Modelli di intervento psicopedagogico
8.4. L’assistenza educativa completa e le sue implicazioni
8.4.1. Concettualizzazione
8.4.2. Pianificazione strategica
8.4.3. Pianificazione personalizzata
8.4.4. Pianificazione educativa completa
8.5. Intervento psicopedagogico vs Attenzione educativa completa
8.5.1. Posizioni teoriche alla base
8.5.2. Analisi comparativa: punti di convergenza e divergenza
8.5.3. Rilevanza dell'uso nel contesto della diversità
8.6. Considerazioni teoriche sulla gestione scolastica
8.6.1. Definizione e principi della gestione scolastica
8.6.2. Gestione di istituzioni educative o di strutture di assistenza
8.6.2.1. Definizione e caratteristiche del processo di gestione
8.6.2.2. Implicazioni del lavoro interdisciplinare nella gestione della scuola
8.6.2.3. L'importanza dell'articolazione della triade “famiglia-scuola-comunità”
8.6.2.4. Lavoro in rete
8.6.2.4.1. Articolazione intrasettoriale
8.6.2.4.2. Articolazione intersettoriale
8.6.3. L'organizzazione scolastica e il suo impatto sul processo educativo
8.6.3.1. Definizione
8.6.3.2. Lo stile di vira dello studente con DSA
8.6.3.3. L'orario di insegnamento
8.6.3.4. L'organizzazione del processo di insegnamento-apprendimento dello studente con DSA: la classe, i progetti di apprendimento e altre forme di organizzazione
8.6.4. L'attività didattica come elemento trascendentale del processo di insegnamento-apprendimento
8.6.4.1. Organizzazione igienico-pedagogica dell'attività didattica (OHPAD)
8.6.4.2. Carico di insegnamento, capacità di lavoro intellettuale e affaticamento
8.6.4.3. Condizioni dell'ambiente fisico
8.6.4.4. Condizioni dell'ambiente psicologico
8.6.4.5. Relazione dell'OHPAD con la motivazione all'apprendimento dello studente con DSA
8.7. Attenzione alla diversità nel quadro dell'inclusione educativa
8.7.1. Concettualizzazione
8.7.2. Basi teoriche e metodologiche
8.7.2.1. Riconoscimento e rispetto delle differenze individuali
8.7.2.2. Attenzione alla diversità come principio dell'inclusione educativa
8.7.3. Adattamenti didattici come via per l’attenzione alla diversità
8.7.3.1. Definizione
8.7.3.2. Tipi di adattamenti didattici
8.7.3.2.1. Adattamenti metodologici
8.7.3.2.2. Adattamenti nelle attività
8.7.3.2.3. Adattamento dei materiali e dei tempi
8.7.3.2.4. Negli elementi funzionali
8.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
8.9. Letture consigliate
8.10. Bibliografia
Modulo 9. Il linguaggio come elemento determinante nell'assistenza alle Difficoltà di Apprendimento
9.1. Introduzione
9.2. Pensiero e linguaggio: la loro relazione
9.2.1. Teorie che spiegano il suo sviluppo
9.2.2. Pensiero e linguaggio. La loro interdipendenza
9.2.3. La posizione del linguaggio nell'apprendimento
9.3. Relazione tra linguaggio e difficoltà di apprendimento
9.3.1. Comunicazione, linguaggio, parola e linguaggio
9.3.2. Informazioni generali sullo sviluppo del linguaggio
9.3.3. Prevenzione dei problemi del linguaggio
9.4. Lo sviluppo ritardato del linguaggio e le sue implicazioni per le difficoltà di apprendimento
9.4.1. Concettualizzazione del ritardo nello sviluppo del linguaggio e sua caratterizzazione
9.4.2. Cause del ritardo nello sviluppo del linguaggio
9.4.3. Importanza dell'identificazione precoce e dell'assistenza nelle scuole
9.4.4. Ritardo nello sviluppo del linguaggio come fattore di rischio per le difficoltà di apprendimento
9.5. Disturbi del linguaggio più comuni negli studenti
9.5.1. Concetti e delimitazioni
9.5.2. Disturbi del linguaggio orale. Le sue manifestazioni nelle componenti fonetiche, fonologiche, morfo-lessicali, sintattiche, semantiche e pragmatiche
9.5.3. Disturbi del linguaggio: dislalia, disartria, rinolalia, disfonia e balbuzie
9.6. Valutazione del linguaggio
9.6.1. Strumenti di valutazione
9.6.2. Componenti da valutare
9.6.3. Referto di valutazione
9.7. Attenzione ai disturbi del linguaggio all’interno delle istituzioni educative
9.7.1. Disturbi del linguaggio
9.7.2. Disturbi del linguaggio
9.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
9.9. Letture consigliate
9.10. Bibliografia
Modulo 10. Difficoltà di Apprendimento della Lettura: il loro impatto sulla capacità del cittadino nella società della conoscenza
10.1. Introduzione
10.2. La lettura e i suoi processi
10.2.1. Definizione
10.2.2. Processo lessicale: la via lessicale e quella fonologica
10.2.3. Processo sintattico
10.2.4. Processo semantico
10.3. Processo di insegnamento-apprendimento della lettura per la vita
10.3.1. Condizioni o requisiti per imparare a leggere
10.3.2. Metodi per l'insegnamento della lettura
10.3.3. Strategie che favoriscono il processo di apprendimento della lettura
10.4. Prevenzione delle difficoltà di apprendimento della lettura
10.4.1. Fattore protettivi
10.4.2. Fattori di rischio
10.4.3. Strategie di promozione della lettura
10.4.4. Importanza delle principali agenzie educative nella promozione della lettura
10.5. La lettura e le sue difficoltà di apprendimento
10.5.1. Caratterizzazione delle difficoltà di apprendimento della lettura
10.5.2. La dislessia come difficoltà specifica di apprendimento
10.5.3. Principali difficoltà di comprensione della lettura
10.6. Diagnosi e valutazione delle difficoltà di apprendimento della lettura
10.6.1. Caratterizzazione diagnostica
10.6.2. Test standardizzati
10.6.3. Test non standardizzati
10.6.4. Altri strumenti di valutazione
10.7. Affrontare le difficoltà di apprendimento nella lettura
10.7.1. Coscienza lessicale
10.7.2. Coscienza fonologica
10.7.3. Strategie cognitive e metacognitive per promuovere la comprensione della lettura
10.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
10.9. Letture consigliate
10.10. Bibliografia
Modulo 11. Le difficoltà di apprendimento della scrittura come possibilità di comunicazione sostenibile
11.1. Introduzione
11.2. Processo di costruzione e linguaggio scritto
11.2.1. Tappe nello sviluppo della scrittura
11.2.2. Livello di costruzione del linguaggio scritto
11.2.3. Strategie per agevolare la transizione attraverso i livelli di costruzione
11.2.4. Metodi di insegnamento del linguaggio scritto
11.2.5. Modelli di produzione del linguaggio scritto
11.2.5.1. Tipologie testuali
11.3. Processi cognitivi coinvolti nella scrittura
11.3.1. Pianificazione
11.3.2. Produzione
11.3.3. Revisione
11.4. Prevenzione delle difficoltà di apprendimento della scrittura
11.4.1. Fattore protettivi
11.4.2. Fattori di rischio
11.4.3. Strategie per la promozione della produzione linguistica scritta
11.4.4. Importanza delle principali agenzie educative nella promozione della scrittura
11.5. La scrittura e le sue difficoltà di apprendimento
11.5.1. Errori di costruzione del linguaggio scritto
11.5.2. Errori specifici della costruzione del linguaggio scritto
11.5.3. Caratterizzazione delle difficoltà nella produzione della lingua scritta
11.5.4. La disgrafia come difficoltà specifica di apprendimento della scrittura
11.6. Diagnosi e valutazione delle difficoltà di apprendimento della scrittura
11.6.1. Stato dei processi cognitivi deficitari
11.6.2. Indicatori di previsione delle difficoltà di apprendimento nell'apprendimento della scrittura
11.6.3. Cosa valutare a partire dalla seconda elementare nei testi scritti dai bambini?
11.7. Attenzione alle difficoltà di apprendimento nella scrittura
11.7.1. Strategie per favorire l'automazione dei movimenti di scrittura
11.7.2. Strategie per incoraggiare la pianificazione del testo
11.7.3. Strategie per incoraggiare la produzione di testi scritti
11.7.4. Strategie per incoraggiare la revisione del testo scritto
11.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
11.9. Letture consigliate
11.10. Bibliografia
Modulo 12. Difficoltà di apprendimento della matematica
12.1. Introduzione
12.2. Conoscenza matematica, i suoi concetti di base
12.2.1. Concetto di quantità o quantificatori
12.2.2. Concetti spazio-temporali
12.3. Matematica e processi di apprendimento
12.3.1. Classificazione
12.3.2. Seriazione
12.3.3. Corrispondenza
12.3.4. Conservazione dell'oggetto o della sostanza
12.3.5. Reversibilità del pensiero
12.3.6. Strategie cognitive e metacognitive
12.3.6.1. Strategie del modello direttivo
12.3.6.2. Conteggio
12.3.6.3. Fatti numerici
12.4. Il processo di insegnamento-apprendimento della matematica
12.4.1. Sottotitolazione e conteggio: principio di corrispondenza a uno a uno, ordine stabile, cardinalità, astrazione e irrilevanza dell'ordine
12.4.2. Apprendimento delle serie numeriche: acquisizione, elaborazione e consolidamento
12.4.3. Apprendimento della risoluzione del problema: localizzazione dell'incognita e struttura semantica
12.4.4. Apprendimento degli algoritmi
12.5. Prevenire le difficoltà di apprendimento matematico
12.5.1. Fattori protettivi
12.5.2. Fattori di rischio
12.5.3. Strategie per la promozione dell'apprendimento della matematica
12.6. La matematica e le sue difficoltà
12.6.1. Definizione di difficoltà di apprendimento della matematica
12.6.2. Difficoltà nell'apprendimento della matematica legate a: la natura della matematica stessa, l'organizzazione e la metodologia dell'insegnamento, legate all'allievo
12.6.3. Errori comuni: nella risoluzione dei problemi, nei passaggi algoritmici
12.6.4. La discalculia come difficoltà specifica di apprendimento: semantica, percettiva e procedurale
12.6.5. Cause delle difficoltà di apprendimento della matematica
12.6.5.1. Fattori contestuali
12.6.5.2. Fattori cognitivi
12.6.5.3. Fattori neurobiologici
12.7. Diagnosi e valutazione delle difficoltà di apprendimento matematico
12.7.1. Test standardizzati
12.7.2. Test non standardizzati
12.7.3. Diagnosi e valutazione educativa completa
12.8. Attenzione alle difficoltà di apprendimento in matematica
12.8.1. Principi di assistenza
12.8.2. Insegnamento di concetti e procedimenti
12.8.3. Strategie basate nella soluzione di problemi
12.8.4. Strategie didattiche di scoperta
12.9. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
12.10. Letture consigliate
12.11. Bibliografia
Modulo 13. Il disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) come condizione associata a Difficoltà di Apprendimento
13.1. Introduzione
13.2. Approccio al disturbo da deficit di attenzione e iperattività
13.2.1. Prevalenza e significato
13.2.2. Cause del disturbo da deficit di attenzione e iperattività
13.2.2.1. Fattori genetici
13.2.2.2. Fattori neurobiologici
13.2.2.3. Fattori endocrini
13.3. Principali modelli teorici che spiegano l'ADHD
13.3.1. Deficit nel controllo della risposta inibitoria
13.3.2. Modello comportamentale incentrato sulle manifestazioni di disattenzione, iperattività e impulsività
13.3.3. Modello basato sulla disfunzione del sistema esecutivo, consenso attuale
13.4. Caratterizzazione del disturbo da deficit di attenzione e iperattività
13.4.1. Manifestazioni predominanti secondo il DSM-5
13.4.2. Sviluppo dell'ADHD nell'arco della vita
13.4.2.1. Nei neonati
13.4.2.2. Nei bambini della scuola dell’infanzia
13.4.2.3. Nei bambini della scuola primaria
13.4.3. L'ADHD come Disturbo delle Funzioni Esecutive
13.4.3.1. Definizione di funzioni esecutive
13.4.3.2. Memoria operativa o di lavoro
13.4.3.3. Autoregolazione della motivazione, delle emozioni e della veglia
13.4.4. Interiorizzazione del linguaggio
13.4.5. Ricostruzione
13.5. Diagnosi e valutazione dell'ADHD
13.5.1. Diagnosi e valutazione fisiologica: aspetti neuroanatomici, biochimici ed endocrini
13.5.2. Diagnosi e valutazione neuropsicologica (test standardizzati)
13.5.3. Diagnosi e valutazione educativa completa: osservazione e colloquio diagnostico con lo studente; colloquio con i genitori e gli insegnanti; questionario o scale di misurazione per genitori e insegnanti
13.6. Assistenza educativa completa per gli studenti che presentano ADHD
13.6.1. Integrare gli aspetti farmacologici, psicologici e psicopedagogici
13.6.2. Concretizzazione dell'assistenza educativa globale: lavorare direttamente con lo studente, nel contesto scolastico e in quello familiare
13.7. Implicazioni educative per la cura educativa globale dello studente con difficoltà di apprendimento associate all'ADHD
13.7.1. Principali problemi psicosociali dello studente con difficoltà di apprendimento e ADHD
13.7.2. Principali difficoltà di apprendimento nella lettura in tali studenti: riconoscimento delle parole e comprensione del testo
13.7.3. Principali difficoltà di apprendimento nella scrittura in questi studenti: scrittura di parole e scrittura di testi
13.7.4. Principali difficoltà nell'apprendimento della matematica: scarsa automatizzazione dei compiti relativi alla numerazione, all'aritmetica mentale, alle operazioni matematiche e alla risoluzione di problemi
13.8. Attività per l'integrazione della conoscenza e la relativa applicazione pratica
13.9. Letture consigliate
13.10. Bibliografia
Modulo 14. Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), disturbi motori e difficoltà di apprendimento
14.1. I processi di autoregolazione e inibizione
14.2. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (I): definizione e prevalenza
14.3. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (II): basi neurobiologiche
14.4. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (III): approcci neuropsicologici
14.5. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (IV): criteri diagnostici DSM-V
14.6. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (V): diagnosi differenziale DSM-V e CIE-10
14.7. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (VI): valutazione, variabili da valutare, tecniche e strumenti
14.8. Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (VII): intervento psicologico e psicopedagogico: programmi di intervento
14.9. Disturbi motori (I): sviluppo psicomotorio nell'infanzia
14.10. Disturbi motori (II): definizione e prevalenza
14.11. Disturbi motori (III): basi neurobiologiche
14.12. Disturbi motori (IV): criteri diagnostici del DSM-V: Disturbi dello sviluppo del coordinamento
14.13. Disturbi motori (V): Criteri diagnostici DSM-V: Disturbi dei movimenti stereotipati. Disturbi da Tics
14.14. Disturbi motori (VI): diagnosi differenziale. DSM-V e CIE-10
14.15. Disturbi motori (VII): Valutazione: variabili a valutare e tecniche e strumenti
14.16. Disturbi motori (VIII): intervento psicologico e psicopedagogico: programmi di intervento
Modulo 15. Disabilità intellettuale e difficoltà di apprendimento
15.1. Sviluppo cognitivo nel bambino
15.1.1. Sviluppo cognitivo del bambino da 0 a 3 anni
15.1.2. Seconda infanzia (2-7 anni)
15.1.3. Terza infanzia (7-11 anni)
15.1.4. Adolescenza (11-12 anni)
15.2. Concetto di intelligenza
15.2.1. Definizione di intelligenza
15.3. Definizione di disabilità e prevalenza
15.4. Cause della Disabilità Intellettuale
15.5. Criteri diagnostici: DSM-V
15.6. Diagnosi differenziale. DSM-V e CIE-10
15.7. Valutazione: Variabili a valutare e tecniche e strumenti
15.7.1. Diagnosi della DI
15.7.2. Diagnosi della comorbidità
15.7.3. Problemi comportamentali
15.8. Diagnosi delle cause del DI
15.9. Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
Modulo 16. Disturbo dello spettro autistico (DSA) e difficoltà di apprendimento
16.1. Definizione e prevalenza
16.2. Basi neurobiologiche
16.3. Approcci neuropsicologici
16.4. Eziologia dell’autismo
16.5. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e dei Sottotipi secondo DSM-IV
16.6. Criteri diagnostici (I): DSM- V, Disturbo dello spettro autistico
16.7. Criteri diagnostici (II): Diagnosi differenziale. DSM-V e CIE-10
16.8. Valutazione: variabili a valutare e tecniche e strumenti
16.9. Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
Modulo 17. Disturbi e altre circostanze personali e sociali che modulano le difficoltà di apprendimento
17.1. Disturbi disruttivi del controllo degli impulsi e del comportamento e difficoltà di apprendimento
17.1.1. Disturbi disruttivi del controllo degli impulsi e del comportamento (I): controllo di impulsi e comportamento prosociale
17.1.2. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (II): Definizione e prevalenza
17.1.3. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (III): Basi neurobiologiche
17.1.4. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (IV): Approcci neuropsicologici al comportamento antisociale
17.1.5. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (V): Criteri diagnostici DSM-V: Disturbo oppositivo provocatorio Disturbo esplosivo intermittente
17.1.6. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (VI): Criteri diagnostici DSM-V: Disturbo del comportamento
17.1.7. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (VII): Criteri diagnostici DSM-V: Disturbo della personalità antisociale
17.1.8. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (VIII): Diagnosi differenziale. DSM-V e CIE-10
17.1.9. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (IX): Valutazione: Variabili a valutare e tecniche e strumenti
17.1.10. Disturbi disruttivi, del controllo degli impulsi e del comportamento (X): Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
17.2. Bambini/e e ragazzi/e con elevate abilità e difficoltà di apprendimento
17.2.1. Definizione di alta capacità e prevalenza
17.2.2. Criteri di valutazione
17.2.3. Valutazione: Variabili a valutare e tecniche e strumenti
17.2.4. Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
17.3. Altre problematiche
17.3.1. Bambini e ragazzi in situazione di rischio sociale e familiare: Consumo di sostanze, condotte sessuali di rischio, disgregazione e violenza familiare
17.3.2. Bambini ragazzi a rischio di esclusione sociale: Povertà e problema di sradicamento
17.3.3. Bambini e ragazzi in situazione di rischio per la propria salute mentale. Problemi della sfera affettiva
17.3.4. Valutazione: Variabili a valutare e tecniche e strumenti
17.3.5. Intervento psicologico e psicopedagogico: Programmi di Intervento
Modulo 18. Alternative educative emergenti per la gestione delle difficoltà di apprendimento
18.1. Introduzione
18.2. Le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
18.2.1. Fondamenti teorici delle tecnologie di informazione e comunicazione
18.2.2. Sviluppo storico delle TIC
18.2.3. Classificazione delle TIC
18.2.3.1. Sincrone
18.2.3.2. Asincrone
18.2.4. Caratteristiche TIC
18.2.5. Potenzialità delle TIC in vari contesti sociali
18.3. Le TIC nei contesti educativi
18.3.1. Contributo delle TIC all'istruzione in generale
18.3.1.1. L'educazione tradizionale e l'integrazione delle TIC
18.3.1.2. L'impatto delle TIC sull'istruzione nel XXI secolo
18.3.1.3. Apprendimento e insegnamento con le TIC: aspettative, realtà e potenzialità
18.3.2. Contributi delle TIC nell'affrontare le Difficoltà di Apprendimento
18.3.2.1. Le TIC come risorsa educativa per affrontare le difficoltà di apprendimento
18.3.2.1.1. Insegnamento della lettura
18.3.2.1.2. Insegnamento della scrittura
18.3.2.1.3. Insegnamento della matematica
18.3.2.1.4. Attenzione al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD)
18.3.3. Ruolo dell'insegnante nell'uso delle TIC
18.3.3.1. In aula
18.3.3.2. Spazi al di fuori dell'aula
18.4. Gli scacchi e il loro valore pedagogico
18.4.1. Breve storia degli scacchi
18.4.2. Il loro carattere ricreativo
18.4.3. Fondamenti pedagogici della scienza del gioco
18.4.4. Gli scacchi come strumento educativo: nel contesto scolastico e in ambienti socialmente vulnerabili
18.4.5. Potenzialità degli scacchi per il processo di insegnamento-apprendimento degli studenti con difficoltà di apprendimento
18.4.5.1. Contributo degli scacchi all'attività cognitiva
18.4.5.1.1. Attenzione
18.4.5.1.2. Memoria
18.4.5.1.3. Motivazione
18.4.5.1.4. Gestione delle emozioni
18.4.5.1.5. Pensieri strategici
18.4.5.1.6. Intelligenza
18.4.5.1.7. Trasferimento dell'apprendimento
18.4.5.2. Contributi degli scacchi nel contesto delle funzioni esecutive
18.4.5.2.1. Organizzazione
18.4.5.2.2. Pianificazione
18.4.5.2.3. Esecuzione (flessibilità, controllo inibitorio, autocontrollo)
18.4.5.2.4. Valutazione/Revisione
18.5. Gli scacchi come elemento di collegamento della triade scuola-famiglia-comunità nella gestione delle difficoltà di apprendimento
18.5.1. Punti di forza dell'uso degli scacchi a scuola per promuovere la partecipazione delle famiglie al processo educativo
18.5.2. Possibilità offerte dagli scacchi per promuovere la partecipazione della comunità alla scuola
18.6. La meditazione. Dalla pratica spirituale alla sua attuale espansione
18.6.1. Un breve approccio alla meditazione come strumento educativo
18.6.1.1. Concetto di meditazione
18.6.1.2. Origine della meditazione
18.6.1.3. La sua diffusione in vari campi
18.7. Sfruttare il potenziale educativo della meditazione per la gestione delle difficoltà di apprendimento e l'attenzione alla diversità
18.7.1. Prove scientifiche degli effetti della meditazione sul corpo, sul cervello e sulle relazioni interpersonali
18.7.1.1. Effetti neurologici: effetti strutturali, biochimici e funzionali nel cervello
18.7.1.2. Effetti psicologici
18.7.1.3. Effetti fisici
18.7.2. Impatto della pratica della meditazione sui bambini in età scolare
18.7.3. Impatto della meditazione sulle modalità di azione dell'insegnante
18.7.4. Impatto della pratica della meditazione sul clima scolastico
18.8. Attività per l'integrazione delle conoscenze e la loro applicazione pratica
18.9. Letture consigliate
18.10. Bibliografia

Una specializzazione completa che ti condurrà attraverso le conoscenze necessarie per competere tra i migliori"
Master Specialistico in Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento
La frequente comparsa di difficoltà di apprendimento nei moderni contesti educativi evidenzia i loro processi di intervento psicologico come una delle aree più importanti della psicologia degli ultimi anni. Questa situazione si è riflessa nell’aumento esponenziale della domanda di lavoro di professionisti specializzati nella materia. Comprendendo la necessità di un aggiornamento accademico che accompagni la crescita delle opportunità occupazionali nel settore, presso TECH Università Tecnologica abbiamo progettato un Master Specialistico in Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento. In questo Master Specialistico, particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di nuove alternative per l'intervento psicologico e psicopedagogico nella gestione dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Allo stesso modo, si approfondiranno aspetti di aggiornamento quali la conoscenza delle diverse tecniche e strategie utilizzate nella gestione dei casi di difficoltà di apprendimento della matematica; a seguire l'individuazione di nuove tecniche e strumenti utilizzati per la diagnosi e la valutazione delle difficoltà di apprendimento.
Studia un Master Specialistico in Gestione e Intervento Psicologico nelle Difficoltà di Apprendimento
I maggiori disagi che frequentemente accompagnano i processi di approccio psicologico alle difficoltà di apprendimento richiedono, per la loro ottimale risoluzione, la presenza di professionisti specializzati con un'elevata capacità di adattamento e un'ampia gamma di competenze e conoscenze. Nel nostro programma affronterai la conoscenza delle grandi sfide e difficoltà che accompagnano i processi di sviluppo del territorio, contemplando l'importante ruolo dello psicologo nell'evoluzione del settore. Allo stesso modo, questo Master Specialistico approfondirà argomenti quali la conoscenza delle diverse metodologie utilizzate nell'intervento psicopedagogico e psicologico dei giovani con disturbi dirompenti che influenzano i loro processi di apprendimento; seguita dalla conoscenza delle diverse strategie cognitive e metacognitive sviluppate per promuovere la comprensione della lettura nei bambini con difficoltà in questo aspetto.