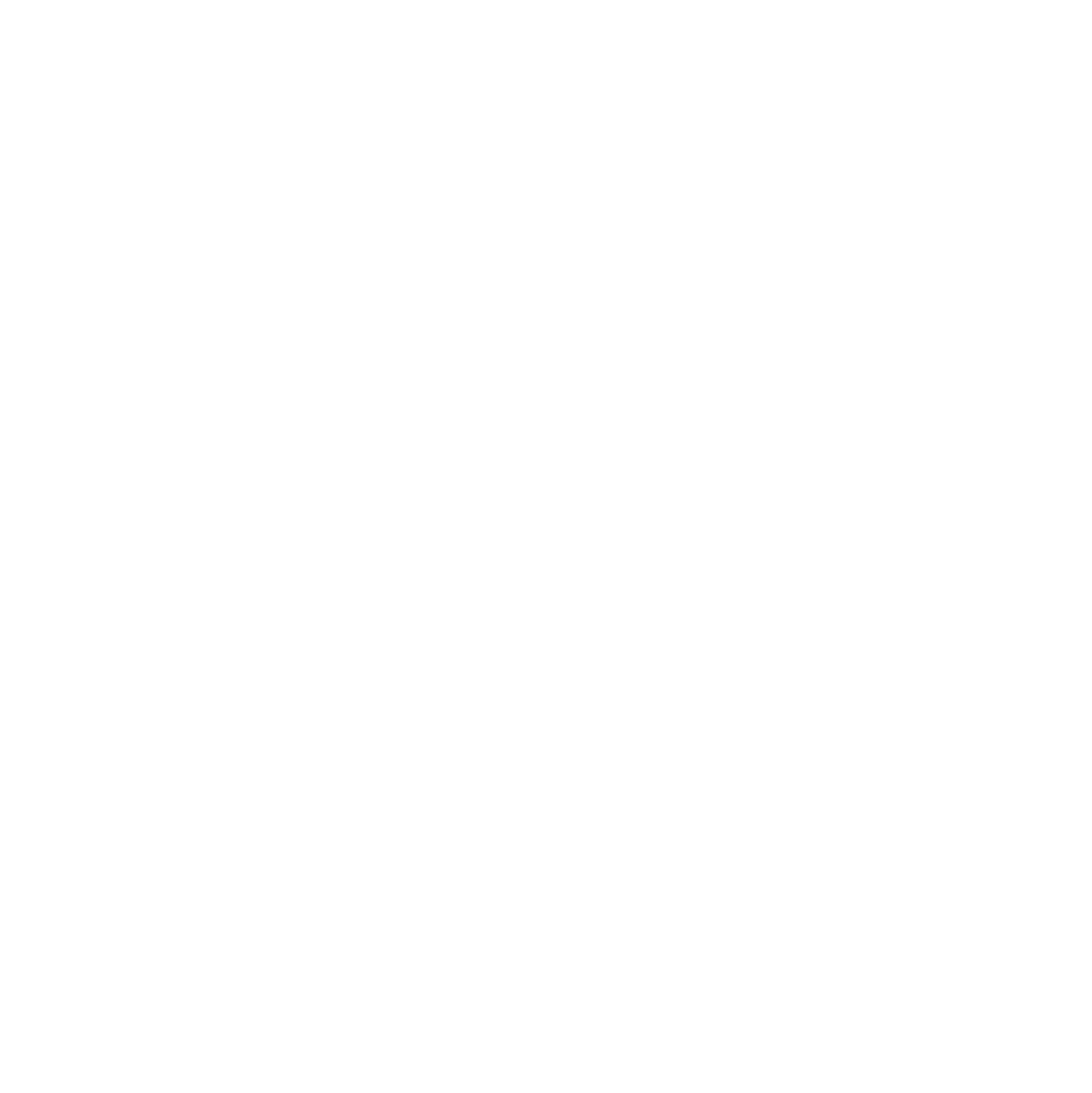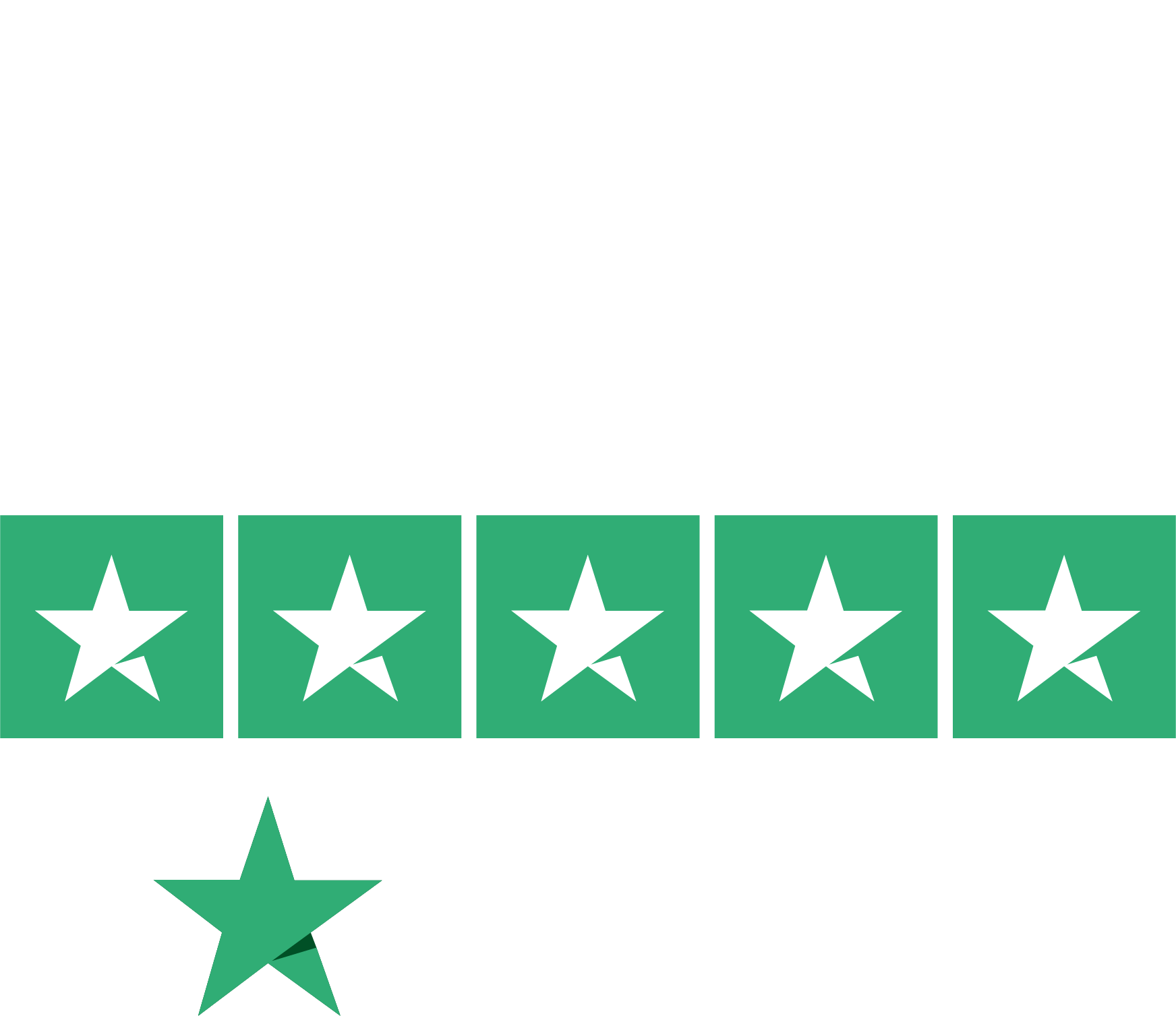Titolo universitario
La più grande facoltà di medicina del mondo"
Presentazione
Garantire l'assistenza sanitaria ai Paesi più bisognosi è essenziale per la sopravvivenza delle loro popolazioni. Se vuoi progredire in questo campo e curare persone con risorse limitate, questo Master privato ti offre tutte le conoscenze essenziali per specializzarti nella cooperazione internazionale"

I Paesi sviluppati devono puntare sulla cooperazione internazionale per migliorare le condizioni di vita delle persone che non hanno risorse sufficienti per mantenersi. La cooperazione internazionale contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle persone più svantaggiate in diversi ambiti: sociale, economico e sanitario, tenendo conto di un punto di vista sostenibile ed egualitario. Una delle esigenze fondamentali di ogni società è l'assistenza sanitaria, per questo è l'ambito in cui devono essere erogate la maggior parte delle risorse al fine di migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini.
TECH offre quindi questo Master privato ai medici che desiderano specializzarsi nel settore umanitario e della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di prepararli a lavorare in regioni con grandi necessità. Questo programma è stato creato da professionisti del mondo dell’istruzione e della cooperazione internazionale per lo sviluppo. Ogni modulo è stato ideato tenendo conto dell'esperienza e della realtà che si trovano nelle diverse regioni del mondo. Frequentando questo programma, lo studente acquisirà le competenze necessarie per lavorare e applicare le conoscenze acquisite nelle diverse funzioni da svolgere all'interno di organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e private.
Inoltre, trattandosi di un programma 100% online, il medico potrà combinare lo studio di questo programma esaustivo con il resto dei suoi impegni quotidiani, scegliendo in ogni momento dove e quando studiare. Una qualifica di alto livello che porterà il professionista medico ai massimi livelli nel suo settore.
La Cooperazione Internazionale permette di migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo, per questo è un compito fondamentale sia in campo sociale che sanitario"
Questo Master privato in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo possiede il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Lo sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Cooperazione Internazionale
- Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni scientifiche e pratiche sulle discipline mediche essenziali per l’esercizio della professione
- Sviluppi sulla cooperazione internazionale
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- La sua particolare enfasi sulle metodologie innovative in Cooperazione Internazionale
- Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
Questo Master privato può essere il miglior investimento al momento di scegliere un programma di aggiornamento per due motivi: oltre a rinnovare le tue conoscenze in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo otterrai una qualifica rilasciata da TECH Università Tecnologica”
Il personale docente del programma comprende prestigiosi professionisti che apportano la propria esperienza, così come specialisti riconosciuti e appartenenti a società scientifiche di primo piano.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La progettazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso accademico. Sarai supportato da un innovativo sistema video interattivo sviluppato da esperti rinomati.
Aumenta la tua fiducia nel processo decisionale aggiornando le tue conoscenze grazie a questo Master privato"

Cogli l'opportunità di conoscere gli ultimi sviluppi in questo campo e di applicarli alla tua pratica quotidiana"
Programma
Il programma è stato progettato sulla base dei requisiti della medicina applicata alla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, seguendo le linee guida proposte dal personale docente di questo Master privato. È stato quindi ideato un percorso di studi i cui moduli offrono un'ampia prospettiva della professione da un punto di vista globale ai fini della sua applicazione a livello internazionale, che incorpora tutti i campi di lavoro coinvolti nello sviluppo delle sue funzioni. A partire dal modulo 1, lo studente vedrà ampliate le sue conoscenze, il che gli permetterà di svilupparsi professionalmente, sapendo di poter contare sul supporto di un gruppo di esperti.

Un programma d'insegnamento molto completo, strutturato in unità didattiche ben sviluppate, orientato a un apprendimento efficace e compatibile con il tuo stile di vita professionale"
Modulo 1. Lo sviluppo dei popoli: Introduzione e sfide
1.1. Lo sviluppo
1.1.1. Introduzione
1.1.2. Cos’è lo sviluppo?
1.1.3. Teorie sociologiche sullo sviluppo
1.1.3.1. Sviluppo attraverso la modernizzazione
1.1.3.2. Sviluppo per unità
1.1.3.3. Teoria dello sviluppo neo-istituzionale
1.1.3.4. Sviluppo grazie alla democrazia
1.1.3.5. Teoria dello sviluppo dell’identità culturale
1.1.4. Attori coinvolti nello sviluppo
1.1.4.1. A seconda di come vengono assegnati, gli aiuti possono essere
1.1.4.2. Secondo la forma
1.1.5. Paesi poveri o impoveriti
1.1.5.1. Cosa si intende per impoverito?
1.1.6. Sviluppo economico, sociale e sostenibile
1.1.7. UNDP
1.1.8. Bibliografia
1.2. Potere, dinamiche e attori nella società internazionale
1.2.1. Introduzione
1.2.2. Elementi del potere
1.2.3. La Società Internazionale
1.2.4. Modelli di Società internazionale
1.2.4.1. Statico
1.2.4.2. Dinamico
1.2.4.3. Globale
1.2.5. Caratteristiche della Società internazionale
1.2.5.1. È una società di riferimento a livello mondiale
1.2.5.2. Si distingue dalla società interstatale
1.2.5.3. La società internazionale richiede una dimensione relazionale
1.2.5.4. La società internazionale gode di un ordine comune
1.2.6. Struttura sociale della società
1.2.7. Struttura della società internazionale
1.2.7.1. Estensione territoriale
1.2.7.2. Diversificazione strutturale
1.2.7.3. Dimensione culturale della società internazionale
1.2.8. Polarizzazione della società internazionale
1.2.8.1. Concetto
1.2.9. Grado di istituzionalizzazione della società internazionale
1.2.10. Bibliografia
1.3. Libero commercio
1.3.1. Introduzione
1.3.2. Disparità di interdipendenza tra i paesi
1.3.3. Imprese transnazionali
1.3.3.1. Cosa sono?
1.3.4. Situazione attuale dei rapporti commerciali
1.3.4.1. Transnazionali e libero commercio
1.3.5. L’OMC
1.3.5.1. Concetto
1.3.5.2. Cenni storici
1.3.5.3. Le attività dell’OMC si basano su tre pilastri
1.3.6. Ronde, conferenze e attività di lobbying
1.3.7. Relazioni commerciali eque
1.3.8. Il CONGDE
1.3.8.1. Proposte del CONGDE
1.3.9. Responsabilità Sociale Corporativa
1.3.10. Un patto globale
1.3.11. Commercio equo
1.3.11.1. Definizione internazionale
1.3.12. Bibliografia
1.4. Sviluppo sostenibile ed educazione
1.4.1. Introduzione
1.4.2. Educazione sullo sviluppo sostenibile ed educazione allo sviluppo sostenibile
1.4.2.1. Principali differenze
1.4.3. Sostenibilità
1.4.3.1. Concetto
1.4.4. Sviluppo sostenibile
1.4.4.1. Concetto
1.4.5. Componenti dello sviluppo sostenibile
1.4.6. Principi dello sviluppo sostenibile
1.4.7. Educazione allo sviluppo sostenibile
1.4.7.1. Definizione
1.4.8. Storia dell’educazione allo sviluppo sostenibile
1.4.8.1. Concetto
1.4.9. Riorientare l’istruzione
1.4.10. Linee guida per lo sviluppo sostenibile
1.4.11. Bibliografia
1.5. Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
1.5.1. Introduzione
1.5.2. Obiettivi di sviluppo del millennio
1.5.2.1. Antecedenti
1.5.3. Campagna del Millennio
1.5.4. Risultati degli ODM
1.5.5. Obiettivi di sviluppo sostenibile
1.5.5.1. Definizione
1.5.5.2. Chi è coinvolto?
1.5.6. Cosa sono gli SDG?
1.5.6.1. Caratteristiche
1.5.7. Differenze tra gli MDG e gli SDG
1.5.8. Agenda di sviluppo sostenibile
1.5.8.1. Agenda 2030
1.5.8.2. Gli SDG sono giuridicamente vincolanti?
1.5.9. Monitoraggio del raggiungimento degli SDG
1.5.10. Bibliografia
1.6. Teorie sullo sviluppo sostenibile
1.6.1. Introduzione
1.6.2. Attori dello sviluppo
1.6.3. Problemi dell’educazione allo sviluppo sostenibile
1.6.3.1. Competenze
1.6.4. L’ONU e il suo impegno per lo sviluppo
1.6.4.1. Storia dell’ONU
1.6.4.2. L’ONU e la sostenibilità
1.6.5. Programma 21: Agenda 21 delle Nazioni Unite
1.6.5.1. Obiettivi dell’Agenda 21
1.6.6. PNUD
1.6.6.1. Storia dell’UNDP
1.6.6.2. Obiettivi dell’UNDP
1.6.7. Altre teorie a sostegno dello sviluppo sostenibile
1.6.7.1. Declino
1.6.8. Teorie alternative sullo sviluppo sostenibile
1.6.8.1. Ecosviluppo
1.6.9. Bibliografia
1.7. Società civile, movimenti sociali e processi di trasformazione
1.7.1. Introduzione
1.7.2. Concetto di movimento sociale
1.7.3. Obiettivi dei movimenti sociali
1.7.4. Struttura dei movimenti sociali
1.7.5. Definizioni dei principali autori
1.7.6. Sfida collettiva
1.7.7. La ricerca di un obiettivo comune
1.7.8. Evoluzione dei movimenti sociali
1.7.9. Partecipazione e consolidamento della democrazia
1.7.10. I movimenti sociali più importanti degli ultimi anni in Europa
1.7.11. Bibliografia
1.8. Sviluppo comunitario partecipativo
1.8.1. Introduzione
1.8.2. Comunità
1.8.2.1. Da chi dipende il successo di una Comunità?
1.8.3. Concetto di partecipazione
1.8.4. Concetto di sviluppo comunitario
1.8.5. Caratteristiche dello sviluppo comunitario
1.8.6. Processi per il raggiungimento dello sviluppo comunitario
1.8.6.1. Diagnosi partecipativa
1.8.6.2. Piano di sviluppo
1.8.6.3. Pianificazione partecipativa
1.8.6.4. Piano di sviluppo comunitario
1.8.7. Dodici lezioni dello sviluppo comunitario partecipativo
1.8.8. Attori chiave
1.8.9. Bibliografia
1.9. Indice di sviluppo umano
1.9.1. Introduzione
1.9.2. Indice di sviluppo umano
1.9.2.1. Principi dell’HDR
1.9.2.2. Obiettivo dell’HDR
1.9.2.3. Limitazioni dell’HDR
1.9.2.4. Tipi di indicatori
1.9.3. Caratteristiche dello sviluppo umano
1.9.4. Metodologia di calcolo dell’HDR
1.9.5. Altri indici di sviluppo umano
1.9.5.1. Indice di sviluppo umano corretto per le disuguaglianze
1.9.5.2. Indice di disuguaglianza di genere
1.9.5.3. Indice di povertà multidimensionale (MPI)
1.9.6. UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite
1.9.7. Conclusioni
1.9.8. Bibliografia
1.10. Associazioni locali per lo sviluppo
1.10.1. Introduzione
1.10.2. Che cos’è un NGDO?
1.10.3. Movimenti statali per lo sviluppo
1.10.4. Povertà zero
1.10.4.1. Obiettivi
1.10.4.2. Strategia d’azione
1.10.4.3. Organizzazioni costitutive
1.10.5. Coordinatore NGDO. Spagna
1.10.5.1. Obiettivo
1.10.5.2. Piano strategico
1.10.5.3. Linee strategiche
1.10.6. Coordinatori automatici
1.10.7. Gruppi di azione sociale
1.10.8. Bibliografia
Modulo 2. Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.1. Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.1.1. Introduzione
2.1.2. Cos’è la Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo?
2.1.2.1. Definizione e concetto
2.1.3. A cosa serve la Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo?
2.1.3.1. Obiettivi/scopo
2.1.4. Obiettivi della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.1.5. Evoluzione della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.1.6. Sistemi internazionali di cooperazione
2.1.6.1. Origine ed evoluzione storica
2.1.7. I piani di ricostruzione dell’Europa nel conflitto bipolare
2.1.8. I processi di decolonizzazione nel dopoguerra
2.1.8.1. Aspetti
2.1.9. Crisi della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.1.9.1. Fattori
2.1.10. Modifiche nella concezione della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.2. Modalità e strumenti della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.2.1. Introduzione
2.2.2. Principali strumenti della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.2.2.1. Cooperazione allo sviluppo
2.2.2.2. Educazione allo sviluppo
2.2.2.3. Assistenza tecnica, qualifica e ricerca
2.2.2.4. Azione umanitaria
2.2.3. Altri strumenti di cooperazione
2.2.3.1. Cooperazione economica
2.2.3.2. Assistenza finanziaria
2.2.3.3. Cooperazione scientifica e tecnologica
2.2.3.4. Aiuti alimentari
2.2.4. Modalità della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.2.4.1. Secondo gli attori che canalizzano i fondi
2.2.5. Tipi di modalità
2.2.5.1. Modalità in base all’origine dei fondi
2.2.6. Tipi di aiuto in base agli attori che gestiscono i fondi della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
2.2.6.1. Bilaterale
2.2.6.2. Multilaterale
2.2.6.3. Cooperazione decentralizzata
2.2.6.4. Cooperazione non governativa
2.2.6.5. Cooperazione imprenditoriale
2.2.7. A seconda della situazione geopolitica e del livello di sviluppo dei paesi donatori e dei paesi riceventi
2.2.8. A seconda della presenza o meno di limitazioni all’utilizzo dei fondi
2.2.9. Altri strumenti di cooperazione. Co-sviluppo
2.2.9.1. Interventi di co-sviluppo
2.2.10. Bibliografia
2.3. Organizzazioni multilaterali
2.3.1. Il sistema di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
2.3.2. Attori della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.3.3. Gli attori del sistema di aiuto pubblico allo sviluppo
2.3.4. Definizioni di organizzazioni internazionali (OI) rilevanti
2.3.5. Caratteristiche delle organizzazioni internazionali
2.3.5.1. Tipi di organizzazioni internazionali
2.3.6. Vantaggi della cooperazione multilaterale
2.3.7. Il contributo delle organizzazioni internazionali al sistema multilaterale
2.3.8. Istituzioni finanziarie multilaterali (IFM)
2.3.8.1. Caratteristiche delle IFM
2.3.8.2. Composizione delle IFM
2.3.8.3. Tipi di istituzioni finanziarie multilaterali
2.3.9. Bibliografia
2.4. Fonti della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.4.1. Introduzione
2.4.2. Differenza tra cooperazione governativa e non governativa
2.4.3. Istituzioni finanziarie multilaterali
2.4.4. Il Fondo Monetario Internazionale
2.4.5. Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. USAID
2.4.5.1. Chi sono?
2.4.5.2. Storia dell’USAID
2.4.5.3. Settori di intervento
2.4.6. Unione Europea
2.4.6.1. Obiettivi della UE
2.4.6.2. Obiettivi generali dell’azione esterna dell’UE
2.4.7. Istituzioni multilaterali non finanziarie
2.4.7.1. Lista delle Istituzioni multilaterali non finanziarie
2.4.7.2. Azioni delle istituzioni multilaterali
2.4.7.3. Non finanziarie
2.4.8. Nazioni Unite
2.4.9. Bibliografia
2.5. Piano generale di cooperazione 2018-2021
2.5.1. Introduzione
2.5.2. Sfide di azione e gestione per la cooperazione
2.5.3. Che cos’è un piano regolatore?
2.5.3.1. Piano generale di cooperazione
2.5.3.2. Aree comprendenti il Quinto Piano Regolatore CE
2.5.4. Obiettivi del Piano regolatore
2.5.4.1. Obiettivi generali dell’azione esterna della CIS
2.5.5. Priorità geografiche di intervento nell’ambito del Piano regolatore della CIS
2.5.6. Agenda 2030
2.5.6.1. Che cos’è l’Agenda 2030?
2.5.6.2. Sviluppo dell’Agenda 2030
2.5.6.3. Specifiche generali
2.5.6.4. Implementazione dell’Agenda 2030
2.5.7. Bibliografia
2.6. Azione umanitaria
2.6.1. Introduzione
2.6.2. L’aiuto umanitario nel contesto internazionale
2.6.3. Tendenze dell’azione umanitaria
2.6.4. Obiettivi principali dell’azione umanitaria
2.6.5. Prima strategia per l’azione umanitaria nella cooperazione allo sviluppo
2.6.6. AECID e l’azione umanitaria
2.6.7. Il finanziamento dell’azione umanitaria e la sua evoluzione
2.6.8. Principi del diritto umano internazionale e dell’azione umanitaria
2.6.9. Riepilogo
2.6.10. Bibliografia
2.7. Approccio di Genere della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.7.1. Introduzione
2.7.2. Cos’è l’approccio di genere?
2.7.3. Perché è importante integrare il genere nei processi di sviluppo?
2.7.4. Approccio di Genere della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
2.7.5. Linee strategiche del lavoro sull’Approccio di Genere nella Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.7.6. Obiettivi del Quinto Piano Regolatore per la Cooperazione in termini di promozione dei diritti e delle opportunità per uomini e donne
2.7.7. Obiettivi prioritari di uguaglianza nella CIS
2.7.8. Strategia settoriale di genere nella cooperazione allo sviluppo
2.7.9. Guida alla trasversalità nell’approccio di genere
2.7.10. Bibliografia
2.8. Approccio alle risorse umane. Nella Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.8.1. Introduzione
2.8.2. Diritti umani
2.8.3. Approccio ai diritti umani nella cooperazione allo sviluppo
2.8.4. Come è nato l’approccio ai diritti umani
2.8.5. Elementi che fornisce l’approccio ai diritti umani alla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
2.8.5.1. Nuovo quadro di riferimento: Norme internazionali sui diritti umani
2.8.5.2. Un nuovo sguardo al capacity building
2.8.5.3. Partecipazione alle politiche pubbliche
2.8.5.4. Rendiconto
2.8.6. Sfide dell’approccio ai Diritti umani negli interventi di cooperazione allo sviluppo
2.8.7. Sfide nell’identificazione e nella formulazione dei progetti
2.8.8. Sfide nella esecuzione dei progetti
2.8.9. Sfide nell’identificazione e nella valutazione dei progetti
2.8.10. Bibliografia
2.9. Mobilità umana e migrazione
2.9.1. Introduzione
2.9.2. Emigrazioni
2.9.2.1. I primi movimenti umani
2.9.2.2. Tipi di migrazione
2.9.2.3. Cause delle migrazioni
2.9.3. Processi migratori nell’era della globalizzazione
2.9.3.1. Migliorare le condizioni di vita
2.9.3.2. Vulnerabilità e migrazione
2.9.4. Sicurezza umana e conflitti
2.9.5. Le sfide del sistema internazionale di asilo
2.9.6. L’OHCHR
2.9.7. Strategia migratoria basata sui diritti umani
2.9.8. Bibliografia
Modulo 3. Progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
3.1. Conoscenze essenziali per la progettazione di politiche di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
3.1.1. Introduzione
3.1.2. Significato del progetto
3.1.3. Tipi di progetti
3.1.4. Ciclo del progetto
3.1.5. Fasi di sviluppo di un progetto
3.1.6. Identificazione
3.1.7. Disegno
3.1.8. Attuazione e monitoraggio
3.1.9. Valutazione
3.1.10. Bibliografia
3.2. L’approccio del quadro logico
3.2.1. Introduzione
3.2.2. Cos’è l’approccio del quadro logico
3.2.3. Approcci al metodo
3.2.4. Definizioni di metodo
3.2.5. Fasi del metodo
3.2.6. Conclusione
3.2.7. Bibliografia
3.3. Identificazione del progetto secondo la LFA (I)
3.3.1. Introduzione
3.3.2. Analisi della partecipazione
3.3.3. Criteri di selezione dei beneficiari del progetto
3.3.4. Schema dei risultati dell’analisi della partecipazione
3.3.5. Difficoltà nell’analisi della partecipazione
3.3.6. Regola d’oro dell’analisi della partecipazione
3.3.7. Caso pratico
3.3.7.1. Malattie nella comunità di Montecito
3.3.7.2. Analisi di partecipazione
3.3.8. Bibliografia
3.4. Identificazione del progetto secondo la LFA (II)
3.4.1. Introduzione
3.4.2. Analisi del problema
3.4.3. Come nasce l’albero dei problemi
3.4.4. Fasi di sviluppo di un albero dei problemi
3.4.5. Problemi nello sviluppo di un albero dei problemi
3.4.6. Conclusione
3.4.6.1. Analisi degli obiettivi
3.4.6.2. Albero dei problemi
3.4.7. Bibliografia
3.5. Identificazione del progetto secondo la LFA (III)
3.5.1. Analisi delle alternative
3.5.2. Come effettuare l’analisi delle alternative
3.5.3. Criteri di valutazione delle alternative
3.5.4. Sequenza di conduzione dell’analisi delle alternative
3.5.5. Conclusione
3.5.6. Bibliografia
3.6. L’approccio del quadro logico alla progettazione
3.6.1. Introduzione
3.6.2. Matrice di pianificazione
3.6.2.1. Logica verticale
3.6.2.2. Logica orizzontale
3.6.3. Origine della matrice di pianificazione
3.6.4. Composizione della matrice di pianificazione
3.6.5. Contenuti della matrice di pianificazione
3.6.6. Bibliografia
3.7. Indicatori e valutazione dei progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo dei popoli
3.7.1. Introduzione
3.7.2. Che cos’è la fattibilità?
3.7.3. Fattori di fattibilità
3.7.4. Valutazione
3.7.5. Tipi di valutazioni
3.7.6. Criteri di valutazione
3.7.7. Progettazione della valutazione
3.7.8. Indicatori di valutazione
3.7.9. Strumenti di raccolta e analisi dei dati
3.7.10. Raccolta delle informazioni
3.7.11. Bibliografia
3.8. Progettazione secondo l’approccio del quadro logico (II): Caso pratico
3.8.1. Introduzione
3.8.2. Presentazione di un caso di studio
3.8.2.1. Malattie nella comunità di Montecito
3.8.3. Annessi
3.8.4. Bibliografia
Modulo 4. Educazione allo sviluppo umano e sostenibile
4.1. Educazione allo sviluppo umano e sostenibile
4.1.1. Introduzione
4.1.2. Crescita economica, sociale e sostenibile
4.1.3. Sviluppo sostenibile, sostenibilità ed educazione
4.1.4. Educazione sullo sviluppo sostenibile ed educazione allo sviluppo sostenibile
4.1.4.1. Differenze principali
4.1.4.2. Sostenibilità
4.1.4.3. Sviluppo sostenibile
4.1.5. Educazione allo sviluppo sostenibile
4.1.6. Bibliografia
4.2. Educazione allo sviluppo e la sua evoluzione
4.2.1. Introduzione
4.2.2. Obiettivi dell’educazione allo sviluppo
4.2.2.1. Obiettivi delle attività di educazione allo sviluppo
4.2.2.2. Finalità dell’educazione allo sviluppo
4.2.3. Dimensioni di educazione allo sviluppo
4.2.4. Storia dell’educazione allo sviluppo
4.2.5. Riorientare l’istruzione
4.2.6. Linee guida per lo sviluppo sostenibile
4.2.7. Esercizi per introdurre il concetto di sviluppo sostenibile
4.2.7.1. Prendi tutto oggi o tutti prendono sempre
4.2.7.2. Prendi tutto oggi o tutti prendono sempre (II)
4.2.7.3. Osservazioni sul gioco Prendi tutto oggi o tutti prendono sempre II
4.2.8. Bibliografia
4.3. Strategie di intervento dell’educazione allo sviluppo
4.3.1. Educazione formale, non formale e informale
4.3.2. Riorientare l’istruzione
4.3.3. Componenti dell’educazione allo sviluppo sostenibile
4.3.4. Linee guida per lo sviluppo sostenibile
4.3.5. Problemi
4.3.6. Quadro di riferimento per l’insegnamento o la discussione di tematiche ambientali
4.3.7. Competenze
4.3.8. Prospettive
4.3.9. Bibliografia
4.4. Le sfide della educazione allo sviluppo nel mondo
4.4.1. Introduzione
4.4.2. Componente dell’educazione allo sviluppo
4.4.2.1. Valori
4.4.3. Sfide e ostacoli all’educazione allo sviluppo
4.4.3.1. Sfide che l’educazione allo sviluppo deve affrontare
4.4.4. Bibliografia
4.5. Educazione, partecipazione e trasformazione sociale
4.5.1. Introduzione
4.5.1.1. L’amministrazione durante il cambiamento
4.5.2. Processo per generare il cambiamento
4.5.2.1. Decidere di agire
4.5.2.2. Sostenere la decisione con una ragione
4.5.2.3. Preparare una strategia di comunicazione per condividere la propria visione con gli stakeholder e la comunità
4.5.2.4. Preparare gli obiettivi finali e intermedi
4.5.2.5. Stabilire le responsabilità e i metodi per la valutazione del programma
4.5.2.6. Rivedere e ripassare gli obiettivi finali e intermedi
4.5.2.7. Premi e celebrazioni
4.5.3. Esercizi per creare obiettivi di sostenibilità per la comunità grazie alla partecipazione del pubblico
4.5.3.1. Conoscere i vicini
4.5.3.2. Creare consenso
4.5.3.3. La comunità attraverso la lente della sostenibilità
4.5.4. Bibliografia
4.6. Attori della educazione allo sviluppo
4.6.1. Introduzione
4.6.2. Attori: L’Amministrazione generale dello Stato
4.6.3. Attori: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione: Segreteria di Stato per la Cooperazione Internazionale e per l’Iberoamerica e i Caraibi (SECIPIC)
4.6.4. Attori: Ministero dell’Istruzione e della Scienza
4.6.5. Altri ministeri
4.6.6. Consiglio di cooperazione
4.6.7. NGDO
4.6.8. Attori: Coordinamento delle organizzazioni non governative per lo sviluppo (CONGDE)
4.6.9. Attori: Spazio Europeo
4.6.10. Altri attori
4.6.10.1. Mezzi di comunicazione
4.6.10.2. Reti, associazioni e movimenti sociali
4.6.11. Attori: Università
4.6.12. Bibliografia
4.7. Educazione allo sviluppo in contesti formali, non formali e informali
4.7.1. Riorientare l’istruzione esistente
4.7.1.1. Aspetti da considerare
4.7.1.2. L’educazione come grande speranza per un futuro sostenibile
4.7.2. La storia della professoressa Mafalda
4.7.2.1. Contesto
4.7.2.2. Struttura
4.7.2.3. Attributi della cittadinanza globale
4.7.2.4. Raccomandazioni pratiche in base ad alcuni fattori determinanti
4.7.3. Bibliografia
4.8. Strategia di educazione allo sviluppo comparativa della Cooperazione
4.8.1. Introduzione
4.8.2. Concetto di educazione non formale
4.8.3. Attività di educazione allo sviluppo nell’educazione non formale
4.8.4. Educazione informale
4.8.5. Ambiti di educazione informale
4.8.5.1. Mezzi di comunicazione
4.8.5.2. Campagne di sensibilizzazione e incidenza politica
4.8.5.3. Studi, ricerche e pubblicazioni
4.8.5.4. Internet e i social network
4.8.6. Raccomandazioni
4.8.7. Bibliografia
4.9. Educazione allo sviluppo. Aree di azione secondo il piano regolatore di cooperazione
4.9.1. Introduzione
4.9.2. Strategia di educazione allo sviluppo del 5° Piano Regolatore CE
4.9.3. Obiettivi del piano regolatore EFA
4.9.4. Strategia settoriale del piano regolatore EFA
4.9.4.1. PAS
4.9.4.2. Strategie
4.9.5. Le linee strategiche di AECID per l’EFA
4.9.6. Generare cittadinanza globale nelle reti sociali
4.9.7. Bibliografia
4.10. Progetti di educazione allo sviluppo nel mondo
4.10.1. Introduzione
4.10.2. Economia sociale "Zafra Local" della ONG movimento páramo, cooperazione e sviluppo
4.10.2.1. Su cosa si basa questo progetto?
4.10.2.2. Obiettivi del progetto
4.10.2.3. La moneta locale al centro del progetto
4.10.2.4. Esempi
4.10.2.5. Esempi in Europa
4.10.2.6. Due formati
4.10.2.7. Moneta per sostenere il commercio locale
4.10.2.8. Moneta per contribuire al consumo locale
4.10.2.9. Moneta solidale
4.10.2.10. Moneta della fiera
4.10.2.11. Processo partecipativo
4.10.3. Bibliografia
Modulo 5. Azione umanitaria e Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
5.1. Azione umanitaria
5.1.1. Introduzione
5.1.2. Cos’è l’Azione umanitaria
5.1.2.1. Concetto/Definizione
5.1.3. Definizione di Umanitaria
5.1.4. A cosa serve l’aiuto umanitario
5.1.5. Obiettivi dell’azione umanitaria
5.1.6. Beneficiari dell’azione umanitaria
5.1.7. Il concetto di soccorso
5.1.8. Aiuti di emergenza
5.1.8.1. Linee d’azione per l’assistenza di emergenza
5.1.9. Aiuti umanitari
5.1.9.1. Differenze tra aiuto umanitario e azione umanitaria
5.1.10. Conclusioni
5.1.11. Bibliografia
5.2. Azione umanitaria e Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
5.2.1. Introduzione
5.2.2. Storia dell’azione umanitaria
5.2.2.1. Umanitarismo moderno
5.2.2.2. Evoluzione
5.2.3. Principi etici e operativi dell’azione umanitaria
5.2.4. Principi umanitari
5.2.4.1. Dilemmi che portano con sé
5.2.5. Umanità
5.2.5.1. Definizione e dilemmi
5.2.6. Imparzialità
5.2.6.1. Definizione e dilemmi
5.2.7. Neutralità
5.2.7.1. Definizione e dilemmi
5.2.8. Indipendenza
5.2.8.1. Definizione e dilemmi
5.2.9. Universalità
5.2.9.1. Definizione e dilemmi
5.2.10. Conclusioni
5.2.11. Bibliografia
5.3. Contenuti e Obiettivi specifici dell’azione umanitaria (I)
5.3.1. Introduzione
5.3.2. Azione umanitaria e Cooperazione allo Sviluppo
5.3.2.1. Umanitarismo classico e nuovo umanitarismo
5.3.2.2. Collegare emergenza e sviluppo
5.3.3. Approccio VARD
5.3.3.1. Concetto di continuum e contiguum
5.3.4. Azione umanitaria e VARD
5.3.5. Preparazione, mitigazione e prevenzione
5.3.6. Ridurre le vulnerabilità e rafforzare le capacità
5.3.7. Bibliografia
5.4. Contenuti e Obiettivi specifici dell’azione umanitaria (II)
5.4.1. Protezione delle vittime
5.4.1.1. Il diritto di asilo e di rifugio
5.4.1.2. Ingerenza umanitaria
5.4.2. Supervisione/monitoraggio internazionale del rispetto
5.4.3. Testimonianza e denuncia delle violazioni dei diritti umani
5.4.4. Lobbying delle ONG
5.4.4.1. Accompagnamento e presenza internazionale
5.4.5. Azione politica di alto livello
5.4.6. Codici di condotta
5.4.7. Progetto ESFERA
5.4.7.1. La Carta umanitaria
5.4.7.2. Gli standard minimi
5.4.7.3. Lo standard umanitario essenziale
5.4.7.4. Valutazione dell’azione umanitaria
5.4.7.5. Perché valutare l’azione umanitaria?
5.4.8. Bibliografia
5.5. Attori dell’azione umanitaria
5.5.1. Introduzione
5.5.2. Quali sono gli attori dell’azione umanitaria?
5.5.3. La popolazione colpita
5.5.4. I Governi coinvolti
5.5.5. Le ONG
5.5.6. Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
5.5.7. Governi donatori
5.5.8. Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite
5.5.9. Unione Europea
5.5.10. Altri attori
5.5.10.1. Enti del settore privato
5.5.10.2. Mezzi di comunicazione
5.5.10.3. Forze armate
5.5.11. Bibliografia
5.6. Le sfide principali per gli attori e l’azione umanitaria
5.6.1. Introduzione
5.6.2. Il Vertice umanitario mondiale
5.6.2.1. L’agenda per l’umanità
5.6.3. Le principali necessità per guardare al futuro
5.6.4. Aumentare il peso e la capacità degli attori locali
5.6.4.1. Carta per il cambiamento
5.6.5. Sfide organizzative per le ONG a livello internazionale
5.6.6. La necessità che le Nazioni Unite considerino le questioni umanitarie come una questione globale
5.6.7. Bibliografia
5.7. OCHA. L’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari
5.7.1. Obiettivi
5.7.2. Nazioni Unite
5.7.3. ONU e azione umanitaria
5.7.4. L’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari OCHA
5.7.4.1. L’origine dell’OCHA
5.7.4.2. L’evoluzione dell’OCHA
5.7.4.3. La riforma umanitaria del 2005
5.7.4.4. L’approccio del cluster
5.7.4.5. Gli strumenti di coordinamento dell’OCHA
5.7.4.6. La missione dell’OCHA
5.7.4.7. Piano strategico OCHA 2018-2021
5.7.5. Bibliografia
5.8. Ufficio per l’azione umanitaria OHA
5.8.1. Obiettivi
5.8.2. Agenzia per la cooperazione internazionale allo sviluppo
5.8.3. Azione umanitaria
5.8.4. Ufficio per l’azione umanitaria (OHA)
5.8.5. Ufficio per l’azione umanitaria (OHA)
5.8.5.1. Obiettivi e funzioni dell’OHA
5.8.5.2. Il finanziamento dell’OHA
5.8.6. Bibliografia
5.9. Confronto tra strategie di azione umanitaria per lo sviluppo
5.9.1. Obiettivi
5.9.2. Introduzione
5.9.3. Il Vertice umanitario mondiale
5.9.3.1. Tendenze al vertice per l’Ufficio per l’azione umanitaria
5.9.4. Piano generale di cooperazione 2018-2021
5.9.5. Progetto START
5.9.5.1. Scopi e obiettivi del progetto START
5.9.5.2. Il team del progetto START
5.9.6. Conclusione
5.9.7. Bibliografia
Modulo 6. Diritti umani (HR) e diritto internazionale umanitario (IHL)
6.1. Diritti umani e diritto internazionale umanitario (IHL)
6.1.1. Introduzione
6.1.2. Concetto e definizione di Diritti umani
6.1.3. Dichiarazione universale dei diritti umani
6.1.3.1. Che cos’è la Dichiarazione universale dei diritti umani?
6.1.3.2. Autori della Dichiarazione universale dei diritti umani
6.1.3.3. Premesse della Dichiarazione universale dei diritti umani
6.1.3.4. Articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani
6.1.4. Bibliografia
6.2. Diritto internazionale umanitario (IHL)
6.2.1. Che cos’è il diritto internazionale umanitario? (IHL)
6.2.2. Rami dell’IHL
6.2.3. Convenzione di Ginevra e regole fondamentali alla base delle convenzioni di Ginevra
6.2.4. Ambito di applicazione del diritto internazionale umanitario
6.2.4.1. Divieti e restrizioni generali su alcuni metodi e mezzi bellici
6.2.4.2. Divieti e restrizioni specifici
6.2.5. Quando si applica l’IHL?
6.2.6. Chi protegge il diritto internazionale umanitario e come?
6.2.7. Bibliografia
6.3. L’ONU e i diritti umani
6.3.1. ONU. Nazioni Unite
6.3.1.1. Che cos’è?
6.3.1.2. Storia dell’ONU
6.3.1.3. ONU e diritti umani
6.3.2. In che modo le Nazioni Unite promuovono e proteggono i diritti umani?
6.3.2.1. Alto Commissario per i diritti umani
6.3.2.2. Consiglio per i diritti umani
6.3.2.3. UNDG-HRM
6.3.2.4. Consiglieri speciali per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere
6.3.3. Conclusioni
6.3.4. Bibliografia
6.4. Strumenti delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani
6.4.1. Introduzione
6.4.2. Strumenti giuridici che assistono le Nazioni Unite nella tutela dei diritti umani
6.4.2.1. Carta Internazionale dei diritti umani
6.4.2.2. Democrazia
6.4.2.3. Altri organismi delle Nazioni Unite incaricati di proteggere i diritti umani
6.4.3. Diversi organismi che si occupano di varie questioni
6.4.4. Segretario Generale
6.4.5. Operazioni di pace delle Nazioni Unite
6.4.6. Commissione sullo stato giuridico e sociale delle donne (CSW)
6.4.7. Bibliografia
6.5. Il Diritto Internazionale dei diritti umani
6.5.1. Introduzione
6.5.2. Cos’è la Carta Internazionale dei diritti umani
6.5.2.1. Caratteristiche della Carta Internazionale dei diritti umani
6.5.3. Principali differenze tra il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale dei Diritti Umani
6.5.4. Crimini contro l’umanità
6.5.4.1. Crimini contro l’umanità nel corso della storia
6.5.5. Bibliografia
6.6. Organizzazioni non governative e diritti umani
6.6.1. Introduzione
6.6.1.1. Che cos’è un NGDO?
6.6.2. ONG e diritti umani
6.6.3. Categorie di ONG per i diritti umani
6.6.4. Caratteristiche principali delle ONG per i diritti umani
6.6.5. Bibliografia
6.7. Violazioni dei diritti umani nel mondo
6.7.1. Introduzione
6.7.2. Casi di violazione dei diritti umani (HRV) per articolo
6.7.2.1. Articolo 3: Diritto di vivere in libertà
6.7.2.2. Articolo 4: Nessuna schiavitù
6.7.2.3. Articolo 5: Nessuna tortura
6.7.2.4. Articolo 13: Libertà di movimento
6.7.2.5. Articolo 18: Libertà di pensiero
6.7.2.6. Articolo 19: Libertà di espressione
6.7.2.7. Articolo 21: Diritto alla democrazia
6.7.3. Bibliografia
6.8. Diritti umani ambientali
6.8.1. La tutela dell’ambiente come diritto umano
6.8.2. L’ambiente ha dei diritti?
6.8.3. Gli sviluppi dei diritti umani nei casi senza diritti
6.8.4. Diritti della natura. Evoluzione
6.8.4.1. Dichiarazione di intenti. Relatore speciale
6.8.5. Diritti ambientali
6.8.5.1. UNEP. Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
6.8.6. Bibliografia
6.9. ONG per i diritti umani
6.9.1. Introduzione
6.9.2. Lista di ONG che lavorano per i diritti umani
6.9.2.1. 1 chilo di aiuti
6.9.2.2. B. Soleil d’Afrique
6.9.2.3. Aasara
6.9.2.4. Acción Andina
6.9.2.5. Acción Global Solidaria
6.9.2.6. Acción Verapaz
6.9.2.7. ADANE. Amics per al Desenvolupament a l’África Negra
6.9.3. Bibliografia
Modulo 7. Comunicazione sociale e trasformativa
7.1. Fondamenti della comunicazione
7.1.1. Introduzione
7.1.2. Che cos’è la comunicazione?
7.1.2.1. Concetto e definizione
7.1.3. Obiettivi, pubblico e messaggi
7.1.4. Diritto all’informazione e alla comunicazione
7.1.4.1. Libertà di espressione
7.1.5. Accesso e partecipazione
7.1.6. Breve panoramica dei media per tipologia
7.1.6.1. Stampa
7.1.6.2. Radio
7.1.6.3. Televisione I
7.1.6.4. Internet e i social network
7.1.7. Conclusioni
7.2. Comunicazione e potere nell’era digitale
7.2.1 Cos’è il potere?
7.2.1.1. Il potere nell’era globale
7.2.2. Fake news, monitoraggio e fughe di notizie
7.2.3. Media di proprietà pubblica
7.2.4. Media commerciali
7.2.4.1. Grandi conglomerati in Europa
7.2.4.2. Grandi conglomerati in America Latina
7.2.4.3. Altri conglomerati
7.2.5. Media alternativi
7.2.5.1. Evoluzione dei media alternativi
7.2.5.2. Tendenze attuali
7.2.5.3. Il problema della finanziamento
7.2.5.4. Giornalismo professionale/giornalismo attivista
7.2.6. Iniziative per la democratizzazione della comunicazione
7.2.6.1. Esempi in Europa
7.2.6.2. Esempi in America Latina
7.2.7. Conclusioni
7.3. Comunicazione e cooperazione internazionale
7.3.1. La comunicazione sociale
7.3.1.1. Concetto
7.3.1.2. Tematiche
7.3.2. Attori: associazioni e centri di ricerca
7.3.2.1. Movimenti sociali
7.3.3. Reti di collaborazione e scambio
7.3.4. Cooperazione, educazione alla trasformazione sociale e comunicazione
7.3.4.1. Tipi di comunicazione delle ONG
7.3.5. Codici di condotta
7.3.5.1. Marketing sociale
7.3.6. Comunicazione educativa
7.3.7. Lavorare con i media alternativi
7.3.8. Lavorare con i media pubblici e commerciali
7.3.9. Comunicazione e cooperazione in tempi di crisi
7.3.9.1. Impatto nell’ambito tecnico e occupazionale
7.3.9.2. Impatto sui movimenti sociali
7.3.10. Tensioni tra giornalismo professionale e giornalismo attivista
7.4. Comunicazione e parità di genere
7.4.1. Introduzione
7.4.2. Concetti chiave
7.4.3. Le donne nei media
7.4.3.1. Rappresentanza e visibilità
7.4.4. Produzione e processo decisionale nei media
7.4.5. La Piattaforma d’azione di Pechino (capitolo J)
7.4.6. Comunicazione femminista e linguaggio inclusivo
7.4.6.1. Concetti di base
7.4.7. Come identificare ed evitare gli stereotipi?
7.4.8. Linee guida, buone pratiche
7.4.9. Esempi di iniziative
7.4.10. Conclusioni
7.5. Comunicazione e sviluppo sostenibile
7.5.1. Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)
7.5.1.1. Proposta e limiti
7.5.2. L’Antropocene
7.5.2.1. Cambiamento climatico e sviluppo umano
7.5.3. Comunicazione NGDO sui "disastri naturali"
7.5.3.1. Copertura regolare da parte dei mass media
7.5.4. Possibilità di incidenza delle ONG
7.5.5. Difensori dell’ambiente in America Latina
7.5.5.1. I dati: minacce e morti
7.5.6. Come possono le ONG comunicare il lavoro dei difensori dei diritti umani?
7.6. Comunicazione e migrazione
7.6.1. Introduzione
7.6.2. Concetti e dati chiave
7.6.3. Il discorso dell’odio e le sue basi
7.6.3.1. Disumanizzazione e vittimizzazione
7.6.4. Necropolitica
7.6.5. Copertura regolare da parte dei mass media
7.6.6. Social network, WhatsApp e bullismo
7.6.7. Possibilità di incidenza delle ONG
7.6.7.1. Come riconoscere i pregiudizi?
7.6.7.2. Superare l’eurocentrismo
7.6.8. Buone pratiche e linee guida su comunicazione e migrazione
7.6.9. Conclusioni
7.7. Comunicazione e costruzione della pace
7.7.1. Introduzione
7.7.2. Giornalismo di pace vs. Giornalismo di guerra
7.7.2.1. Caratteristiche
7.7.3. Breve panoramica storica sul bellicismo
7.7.4. Comunicazione sui conflitti armati e sui processi di pace
7.7.5. Giornalisti nei conflitti armati
7.7.6. Possibilità per le NGDO
7.7.6.1. Spostare l’attenzione sulla soluzione
7.7.7. Ricerca e linee guida
7.8. Comunicazione educativa per avanzare
7.8.1. Introduzione
7.8.2. Pedagogia e educazione popolare
7.8.3. L’alfabetizzazione mediatica
7.8.4. Progetti di comunicazione educativa
7.8.4.1. Caratteristiche
7.8.4.2. Attori
7.8.5. Trasversalità della comunicazione per il cambiamento sociale
7.8.5.1. La componente di comunicazione in altri progetti
7.8.6. L’importanza della comunicazione interna nelle ONG
7.8.7. Comunicazione a partner e collaboratori
7.8.8. Conclusioni
7.9. Cultura digitale e ONG dello sviluppo
7.9.1. Introduzione
7.9.2. Cambiamenti di paradigma e nuovi spazi
7.9.2.1. Caratteristiche e principali attori e reti
7.9.3. La tirannia del click
7.9.4. L’imposizione della brevità
7.9.5. Partecipazione cittadina nella società digitale
7.9.5.1. Cambiamenti nella solidarietà e nell’attivismo nella cultura digitale
7.9.6. Promuovere la partecipazione delle ONG agli spazi digitali
7.9.7. Parametri della comunicazione 2.0 nelle ONG
7.9.8. Conclusioni
7.10. In pratica
7.10.1. Introduzione
7.10.2. Elaborazione di piani di comunicazione organizzativa
7.10.2.1. Introduzione ai piani di comunicazione
7.10.3. Piani di comunicazione per progetti e azioni
7.10.4. Contenuti di base ed errori comuni nei siti web
7.10.5. Piani di pubblicazione nei social
7.10.6. Gestione delle crisi e dei problemi imprevisti sui social media
7.10.7. Soggetto, verbo e predicato
7.10.7.1. Ripassando alcune nozioni
7.10.8. Conclusioni
Modulo 8. Uguaglianza e cooperazione
8.1. Generi e cooperazione
8.1.1. Introduzione
8.1.2. Concetti chiave
8.1.2.1. Questioni di genere da considerare
8.1.3. Empowerment
8.1.3.1. Introduzione
8.1.3.2. Concetto di empowerment
8.1.3.3. Cos’è l’empowerment?
8.1.3.4. Breve storia dell’empowerment
8.1.4. Il movimento femminista nel mondo
8.1.4.1. Concetto
8.1.4.2. Breve storia del femminismo nel mondo
8.1.5. Bibliografia
8.2. Evoluzione storica dei movimenti femministi. Principali correnti
8.2.1. Introduzione
8.2.1.1. Antecedenti Storici
8.2.2. Precursori del movimento femminista
8.2.3. Le suffragiste negli Stati Uniti e in Europa
8.2.4. Suffragiste in America Latina
8.2.5. Il femminismo come movimento sociale o nuovo femminismo
8.2.6. Femminismo contemporaneo
8.2.6.1. I femminismi del XXI secolo
8.2.6.2. Evoluzione dei principali movimenti femministi
8.2.7. Bibliografia
8.3. Patriarcati regionali e movimenti femministi
8.3.1. Patriarcato
8.3.1.1. Introduzione
8.3.1.2. Concetto di patriarcato
8.3.1.3. Concetto di matriarcato
8.3.1.4. Caratteristiche principali del patriarcato nel mondo
8.3.2. Movimenti storici influenti delle donne nel mondo
8.3.2.1. Evoluzione dei diritti delle donne
8.3.2.1.1. Prima convenzione per i diritti delle donne
8.3.2.1.2. Giornata internazionale della donna: un giorno per le donne
8.3.2.1.3. La medicina contro le mutilazioni genitali femminili
8.3.2.1.4. Rivolta delle donne ad Aba
8.3.2.1.5. Il mondo del lavoro in continua evoluzione
8.3.2.1.6. Sul lavoro e in sciopero, con forza
8.3.2.1.7. Nascita delle Nazioni Unite
8.3.2.1.8. Alle donne del mondo
8.3.2.1.9. Le indimenticabili farfalle
8.3.2.1.10. Attivisti, unitevi
8.3.2.1.11. CEDAW
8.3.2.1.12. Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne
8.3.2.1.13. Programma di azione della CIPD
8.3.2.1.14. Dichiarazione e Piattaforma d’azione di Pechino
8.3.2.1.15. Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza
8.3.2.1.16. Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite
8.3.2.1.17. Azione collettiva per la pace
8.3.2.1.18. La Gulabi Gang: giustizia per le donne
8.3.2.1.19. Sfidare lo status quo
8.3.3. Bibliografia
8.4. Divisione del lavoro: assetti tradizionali e dinamiche contemporanee
8.4.1. Introduzione
8.4.2. Divisione sessuale del lavoro
8.4.2.1. Vincoli intrinseci ed estrinseci alla partecipazione al lavoro delle donne
8.4.2.2. Segregazione verticale e orizzontale delle donne nel lavoro retribuito
8.4.2.3. Mascolinità e lavoro retribuito
8.4.3. Divisione del lavoro tra uomini e donne
8.4.4. Femminilizzazione della povertà
8.4.5. Dati sulla partecipazione al lavoro, sul divario di genere e sulle diverse forme di inserimento nel mercato del lavoro
8.4.5.1. Indicazioni
8.4.5.2. Occupate per settore di attività
8.4.5.3. Occupate a seconda del tipo di lavoro
8.4.5.4. Occupate a seconda della situazione professionale
8.4.5.5. Occupate a seconda del tipo di posto di lavoro
8.4.6. Bibliografia
8.5. Politiche assistenziali ed economia
8.5.1. Cura per la vita
8.5.2. Effetti sulla vita delle donne
8.5.2.1. Valore associato al lavoro non retribuito nella sfera domestica e ad altri lavori assistenziali
8.5.2.2. Concetto di conciliazione
8.5.2.3. Misure adottate per ottenere la riconciliazione
8.5.3. Attività di cura e lavori domestici. Bambini che frequentano centri di educazione e cura. Famiglie con persone a carico
8.5.3.1. Frequenza settimanale delle attività di cura e lavori domestici. UE-28
8.5.3.2. Ore settimanali dedicate alle attività di cura e lavori domestici
8.5.3.3. Persone di 16 anni e più che si occupano di persone a carico (per età e sesso)
8.5.4. Nuove mascolinità
8.5.5. Bibliografia
8.6. Genere e migrazione
8.6.1. Cause e situazione globale della migrazione
8.6.2. Sviluppo storico della migrazione
8.6.3. Fenomeno della femminilizzazione della migrazione
8.6.4. Caratteristiche dei flussi migratori in una prospettiva di genere
8.6.5. Gli effetti dei processi migratori sulle donne
8.6.6. Conclusione
8.6.7. Strategia migratoria sensibile alle differenze di genere
8.6.8. Bibliografia
8.7. Il sistema di cooperazione internazionale allo sviluppo in una prospettiva di genere
8.7.1. Introduzione
8.7.2. Il sistema internazionale di cooperazione allo sviluppo
8.7.2.1. Obiettivi della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
8.7.2.2. Politiche e strumenti di cooperazione internazionale allo sviluppo da una prospettiva di genere
8.7.2.3. Linee strategiche del lavoro sull’Approccio di Genere nella Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
8.7.3. Genere e advocacy
8.7.4. Genere e sviluppo
8.7.5. Pianificazione orientata al genere
8.7.5.1. Linee guida per i processi di pianificazione
8.7.6. Quadri di associazione nazionale e strumenti di cooperazione disponibili
8.7.7. Linee guida per la trasversalità
8.7.7.1. Liste di verifica
8.7.7.2. Lista di controllo della fase 1. Fase 0
8.7.8. Bibliografia
8.8. Politiche pubbliche con una prospettiva di genere
8.8.1. Introduzione
8.8.2. Economia dello sviluppo
8.8.2.1. Basi economiche dello sviluppo
8.8.2.2. Definizione di economia dello sviluppo
8.8.2.3. Evoluzione dell’economia dello sviluppo
8.8.3. Economia di genere
8.8.4. Politiche pubbliche con una prospettiva di genere
8.8.5. Metodologia di bilancio di genere
8.8.6. Indice di sviluppo umano in relazione al genere
8.8.6.1. Concetto
8.8.6.2. Parametri dell’indice di sviluppo umano
8.8.7. Bibliografia
8.9. Prospettiva di genere nella Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
8.9.1. Il genere nella cooperazione internazionale. Sviluppi Storici
8.9.2. Concetti di base |
8.9.2.1. Uguaglianza di genere
8.9.2.2. Parità di genere
8.9.2.3. Identità di genere
8.9.2.4. Mascolinità
8.9.2.5. Patriarcato
8.9.2.6. Divisione sessuale del lavoro
8.9.2.7. Ruoli di genere
8.9.2.8. Approccio settoriale
8.9.2.9. Approccio trasversale
8.9.2.10. Esigenze pratiche
8.9.2.11. Interessi strategici di genere
8.9.3. Perché è importante integrare il genere nei processi di sviluppo?
8.9.4. Decalogo della trasversalità nell’approccio di genere
8.9.5. Indicatori di genere
8.9.5.1. Concetto
8.9.5.2. Aree che possono essere oggetto di indicatori
8.9.5.3. Caratteristiche degli indicatori di genere
8.9.5.4. Finalità degli indicatori di genere
8.9.6. Bibliografia
Modulo 9. Diritti ambientali
9.1. Diritti ambientali
9.1.1. Introduzione
9.1.2. Che cos’è?
9.1.3. Che cos’è il diritto ambientale?
9.1.4. Caratteristiche del diritto ambientale
9.1.5. Natura giuridica
9.1.6. Antecedenti
9.1.7. Storia
9.1.8. Obiettivo del diritto ambientale
9.1.8.1. Fonti
9.1.9. Principi
9.1.10. Scopi
9.2. Diritti ambientali
9.2.1. Cosa intendiamo per ambiente?
9.2.2. Cosa sono i nostri diritti ambientali?
9.2.2.1. Quali sono?
9.2.3. Diritto a godere di un ambiente sano
9.2.4. Diritto di accesso all’informazione
9.2.5. Diritto di partecipazione alla gestione ambientale
9.2.6. Diritto di accesso alla giustizia ambientale
9.2.7. Principi generali del diritto ambientale
9.2.8. Conferenze e accordi internazionali
9.2.8.1. Stoccolma 1972
9.2.8.2. Rio de Janeiro 1992
9.2.9. Norme a tutela dei diritti ambientali
9.2.10. Conclusione
9.3. Obblighi di legge in materia ambientale
9.3.1. Introduzione
9.3.2. Quali sono i doveri ambientali?
9.3.2.1. Definizione e concetto
9.3.3. Quali sono i nostri diritti ambientali?
9.3.4. Obbligo di conservazione dell’ambiente
9.3.5. Obbligo di rispettare gli standard ambientali
9.3.6. Obbligo di vigilanza cittadina
9.3.7. Obbligo di informazione
9.3.8. Obbligo di risarcimento del danno ambientale
9.3.9. Conclusioni
9.4. Partecipazione dei cittadini alla tutela dell’ambiente
9.4.1. Introduzione
9.4.2. Monitoraggio ambientale partecipativo
9.4.2.1. Introduzione
9.4.2.2. Concetto di monitoraggio
9.4.2.3. Che cos’è il monitoraggio ambientale partecipativo?
9.4.2.4. A cosa serve?
9.4.2.5. Chi può partecipare?
9.4.2.6. Piano di monitoraggio ambientale partecipativo
9.4.2.7. Area di influenza di un progetto o di un’attività
9.4.2.8. Tappe del monitoraggio ambientale partecipativo
9.4.2.9. Fasi
9.5. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. UNEP
9.5.1. Introduzione
9.5.2. Definizione e concetto
9.5.3. Obiettivo dell’UNEP
9.5.3.1. Obiettivo generale
9.5.4. Storia ed evoluzione
9.5.4.1. Dove e quando è nato l’UNEP?
9.5.5. Missione dell’UNEP
9.5.6. Attività
9.5.7. Sede dell’UNEP
9.5.7.1. A livello nazionale e internazionale
9.5.8. Quarto Programma di Montevideo per lo sviluppo e la revisione periodica del diritto ambientale
9.5.8.1. Concetto, obiettivi e finalità
9.5.9. Conclusione
9.6. Cambiamento ambientale globale e cambiamento climatico
9.6.1. Introduzione
9.6.2. Ambiente globale
9.6.2.1. Concetto
9.6.3. Cambiamento climatico
9.6.3.1. Concetto
9.6.4. Evoluzione della teoria del cambiamento climatico
9.6.5. Cambiamento ambientale globale
9.6.5.1. Passato e presente
9.6.6. Caratteristiche del cambiamento ambientale globale
9.6.6.1. Variazioni del livello del mare
9.6.7. Conseguenze del cambiamento ambientale globale
9.6.8. Pericoli, rischi e vulnerabilità futura
9.6.9. Il cambiamento climatico e il suo impatto sull’agricoltura
9.6.10. Strategie di sopravvivenza e dilemmi
9.6.10.1. Emigrazione
9.7. Diritti ambientali nel mondo
9.7.1. Introduzione
9.7.2. Paesi in lotta per i diritti ambientali
9.7.3. Ecuador
9.7.4. Spagna
9.7.5. Messico
9.7.6. Perù
9.7.7. Lo sviluppo sostenibile
9.7.7.1. Concetto
9.7.8. Storia ed evoluzione
9.7.9. Ottica dello sviluppo sostenibile. (SS)
9.7.10. Legge generale sullo sviluppo forestale sostenibile
9.7.10.1. Descrizione
9.7.10.2. Obiettivo
Modulo 10. Le NGODS e la solidarietà locale, regionale e internazionale
10.1. Le ONG
10.1.1. Introduzione
10.1.2. Significato dell’acronimo ONG
10.1.3. Che cos’è una ONG?
10.1.3.1. Definizione e concetto
10.1.4. Condizioni delle ONG
10.1.5. Storia ed evoluzione delle ONG
10.1.5.1. Quando e come nascono?
10.1.6. Funzioni delle ONG
10.1.7. Finanziamento delle ONG
10.1.7.1. Fondi pubblici
10.1.7.2. Fondi privati
10.1.8. Tipologie di ONG
10.1.9. Funzionamento delle ONG
10.1.10. Il lavoro delle ONG
10.2. Tipologie di ONG
10.2.1. Introduzione
10.2.2. Classificazione delle ONG a livello mondiale
10.2.2.1. Tipi di classificazione
10.2.3. Tipi di ONG a seconda del loro orientamento
10.2.3.1. Quanti tipi esistono a seconda del loro orientamento?
10.2.4. ONG di carità
10.2.5. ONG di servizi
10.2.6. ONG partecipative
10.2.7. ONG di difesa
10.2.8. Tipi di ONG in base alla loro area di attività
10.2.8.1. Aree
10.2.9. ONG con base comunitaria
10.2.10. ONG di cittadinanza
10.2.11. ONG nazionali
10.2.12. ONG internazionali
10.3. ONG: sviluppo e solidarietà
10.3.1. Introduzione
10.3.2. I cambiamenti nella cooperazione internazionale allo sviluppo e il suo rapporto con le ONG
10.3.2.1. Linee principali
10.3.3. Il "Terzo Mondo" e le ONG
10.3.4. L’era umanitaria. Dall’intervento al villaggio globale
10.3.4.1. Medici senza frontiere, Medici del mondo, ecc.
10.3.5. Movimenti contro il Terzo Mondo
10.3.6. ONG e scienza
10.3.6.1. Ricerca scientifica
10.3.7. La forza lavoro delle ONG
10.3.8. Pregiudizi ideologici delle ONG
10.3.9. Conclusione
10.4. Legislazione delle ONG
10.4.1. Che tipo di legislazione è applicabile alle ONG?
10.4.1.1. Introduzione
10.4.2. Leggi specifiche
10.4.3. Leggi generiche
10.4.4. Normativa statale
10.4.4.1. Tipi di leggi e decreti
10.4.5. Obblighi delle associazioni
10.5. Tipi di associazioni esistenti
10.5.1. Introduzione
10.5.2. Differenze tra associazioni, sindacati, federazioni o coordinamenti e conferenze
10.5.3. Associazioni giovanili
10.5.3.1. Definizione e concetto
10.5.4. Legislazione sulle associazioni giovanili
10.5.5. Caratteristiche principali delle associazioni giovanili
10.5.6. Coordinatori
10.5.6.1. Definizione e concetto
10.5.6.2. Obiettivi
10.5.7. Caratteristiche dei coordinatori
10.5.8. Federazioni
10.5.8.1. Definizione e concetto
10.5.9. Caratteristiche e obiettivi delle federazioni
10.5.10. Tipi di federazioni
10.6. AECID e altre agenzie di cooperazione regionale
10.6.1. Introduzione
10.6.2. L’AECID
10.6.2.1. Significato dell’acronimo
10.6.3. Definizione e concetto
10.6.4. Obiettivi
10.6.5. Missione
10.6.5.1. Visione dell’agenzia
10.6.6. Struttura
10.6.7. Uffici tecnici di AECID
10.6.8. Modalità e strumenti di cooperazione
10.6.9. Fondo per la promozione dello sviluppo
10.6.10. Conclusione
10.7. Settori di cooperazione AECID
10.7.1. Introduzione
10.7.2. Acqua e risanamento
10.7.2.1. Come lavorano?
10.7.3. Crescita economica
10.7.3.1. Come lavorano?
10.7.4. Cultura e scienza
10.7.4.1. Come lavorano?
10.7.5. Genere
10.7.5.1. Come lavorano?
10.7.6. Istruzione
10.7.6.1. Come lavorano?
10.7.7. Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e nutrizione
10.7.7.1. Come lavorano?
10.7.8. Governance democratica
10.7.8.1. Come lavorano?
10.7.9. Mezzo ambientale e cambiamento climatico
10.7.9.1. Come lavorano?
10.7.10. Salute
10.7.10.1. Come lavorano?
10.8. Paesi in cui AECID collabora
10.8.1. Introduzione
10.8.2. Priorità geografiche
10.8.2.1. Cosa sono?
10.8.3. Paesi e territori del partenariato
10.8.3.1. Presente e futuro
10.8.4. America Latina
10.8.4.1. 12 progetti
10.8.5. Caraibi
10.8.6. Nord Africa e Medio Oriente
10.8.6.1. Quattro progetti
10.8.7. Africa Sub-Sahariana Occidentale
10.8.7.1. Tre progetti
10.8.8. Africa Centrale, Orientale e Meridionale
10.8.8.1. Tre progetti
10.8.9. Asia
10.8.9.1. Un progetto
10.9. Strategia e gestione di una ONG
10.9.1. Introduzione
10.9.2. Gestione di una ONG
10.9.3. Pianificazione strategica di una ONG
10.9.3.1. Che cos’è?
10.9.3.2. Come si fa?
10.9.4. Gestione della qualità delle ONG
10.9.4.1. Qualità e impegno
10.9.5. Gli stakeholder
10.9.5.1. Relazione degli stakeholder
10.9.6. Responsabilità sociale delle ONG
10.9.7. Rischio etico di terzi
10.9.8. Rapporto tra ONG e settore privato
10.9.9. Trasparenza e responsabilità
10.9.10. Conclusione
10.10. ONG nazionali e internazionali
10.10.1. ONG nazionali
10.10.1.1. Principali progetti
10.10.2. ONG internazionali
10.10.2.1. Principali progetti
10.10.3. ACNUR
10.10.3.1. Storia
10.10.3.2. Obiettivi
10.10.3.3. Principali aree di lavoro
10.10.4. Mercy Corps
10.10.4.1. Chi sono?
10.10.4.2. Obiettivi
10.10.4.3. Aree di lavoro
10.10.5. Plan Internacional
10.10.5.1. Chi sono?
10.10.5.2. Obiettivi
10.10.5.3. Principali aree di lavoro
10.10.6. Medici senza frontiere
10.10.6.1. Chi sono?
10.10.6.2. Obiettivi
10.10.6.3. Aree di lavoro
10.10.7. Ceres
10.10.7.1. Chi sono?
10.10.7.2. Obiettivi
10.10.7.3. Principali aree di lavoro
10.10.8. Oxfam Intermón
10.10.9. UNICEF
10.10.10. Save the children

Un'esperienza formativa unica, chiave e decisiva per potenziare il tuo sviluppo professionale"
Master Privato in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
Le attività umanitarie in campo medico inquadrate in questo tipo di progetti sono di vitale importanza per contribuire al raggiungimento degli obiettivi proposti dall'Assemblea Generale, in particolare quelli relativi alla salute e al benessere e alla riduzione delle disuguaglianze. In quest'ottica, in TECH Università Tecnologica abbiamo creato questo Master Privato incentrato sull'applicazione tecnica delle teorie dello sviluppo e sul loro impatto sulla sfera economica, sociale, culturale e politica. Grazie al nostro piano di studi completo, gli studenti saranno in grado di comprendere i fondamenti delle strutture che regolano il funzionamento globale delle nazioni per approfondire la comprensione delle vie di accesso disponibili che favoriscono lo scambio di risorse e servizi. Offre inoltre una serie di contenuti che riguardano le sfide di questo lavoro, il ruolo delle ONG nella costruzione di reti di solidarietà locale, regionale e internazionale e i fattori che evidenziano la rilevanza della promozione dei diritti umani, con particolare attenzione all'istruzione, all'uguaglianza e alla qualità dell'ambiente. A livello pratico-amministrativo, vengono presentati assi tematici che affrontano il ciclo di gestione dei progetti, concentrandosi sulle tecniche analitiche per l'attuazione delle politiche, come ad esempio il quadro logico.
Master Privato in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
Studiare questo corso post-laurea in TECH offre ai professionisti l'opportunità di immergersi completamente nelle iniziative globali di lotta alla povertà, attraverso l'acquisizione di competenze per l'attuazione di azioni umanitarie. Padroneggiando la conoscenza delle realtà regionali, del coordinamento degli obiettivi globali e del sistema di relazioni internazionali (attori, interessi, patti), saranno in grado di promuovere quadri d'azione innovativi che contribuiscano alla gestione adeguata dei rischi a cui sono esposte le popolazioni. Tutto questo si baserà, ovviamente, su un'analisi approfondita delle loro esigenze di base e delle priorità settoriali e geografiche. In questo modo, il Master Privato sarà in grado, in primo luogo, di comprendere a fondo i diversi contesti (micro/macro), il che gli permetterà di promuovere i rispettivi processi di sviluppo, verificando gli ostacoli e rispondendo alle situazioni di crisi e di emergenza.