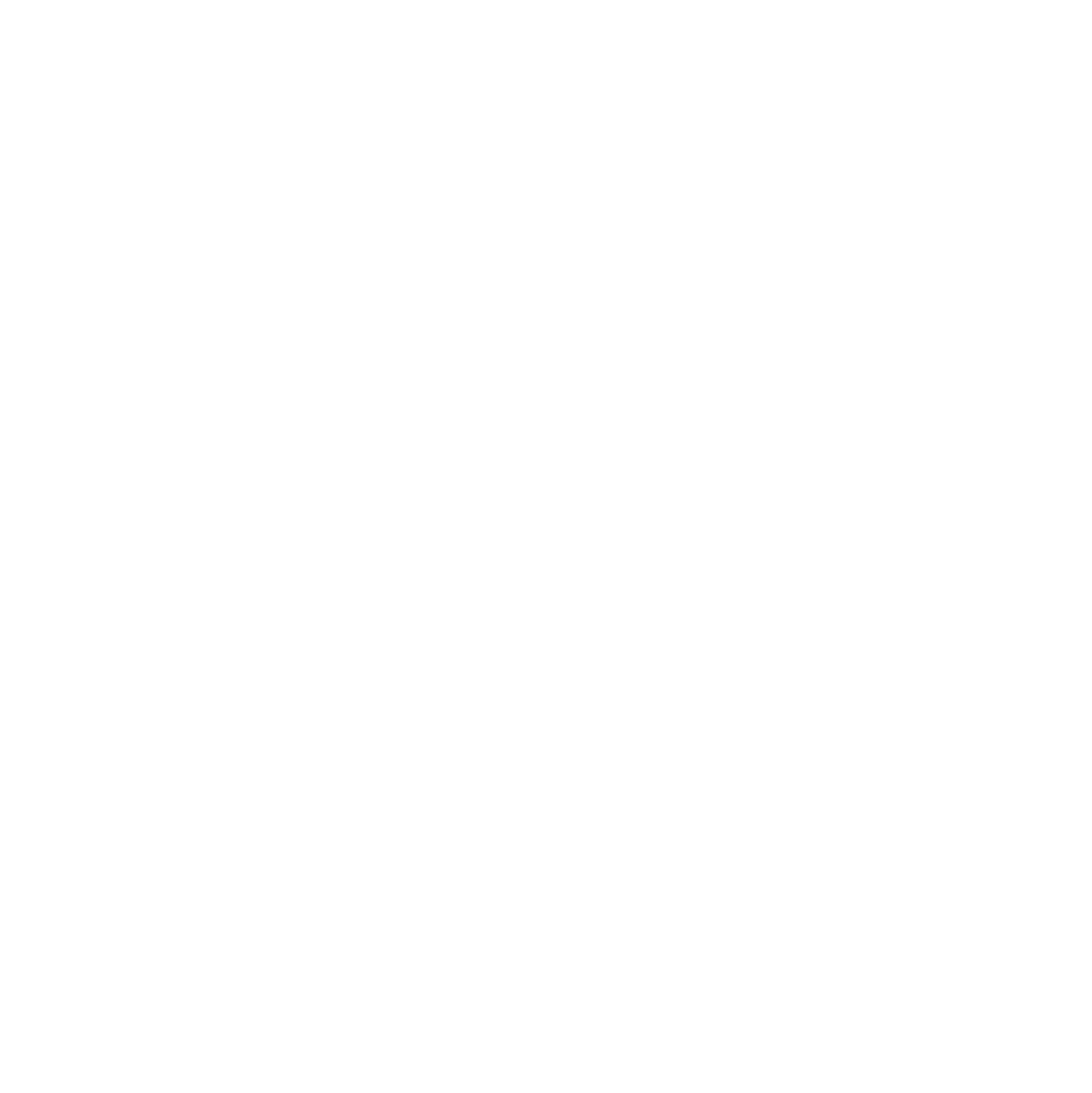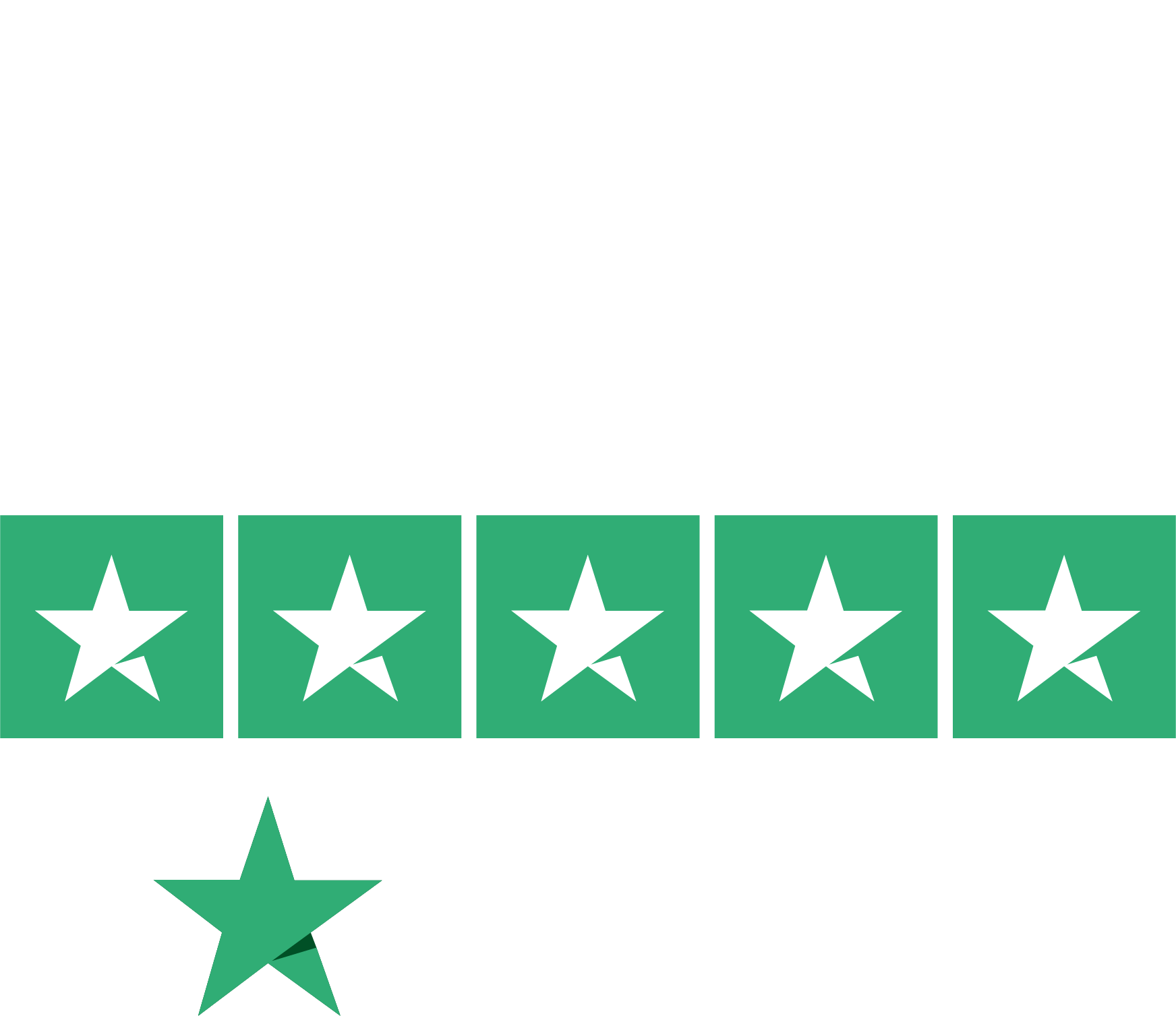Titolo universitario
La più grande facoltà di medicina del mondo"
Presentazione
Questo Master semipresenziale ti mostrerà i progressi ottenuti negli ultimi studi clinici diagnosticati con tumore di origine sconosciuta"

Lo studio di Linfomi, Sarcomi, Melanomi o Carcinomi è sempre più frequente da parte di prestigiosi centri di ricerca che investono tempo e risorse nella conoscenza approfondita dell'origine degli stessi, per poter ottenere trattamenti efficaci. Uno scenario che a volte sembra lontano, ma che negli ultimi anni ha raggiunto importanti traguardi grazie ai progressi raggiunti attraverso l'Epidemiologia, la Genetica, la Biomedicina e la Bioinformatica Aree multidisciplinari che cercano di ridurre il numero esistente, in cui un paziente su cinque con diagnosi di tumore di origine sconosciuta. Su questa linea, TECH ha progettato questo Master semipresenziale che fornisce ai professionisti del settore medico le conoscenze più avanzate e aggiornate sulla realtà attuale dei tumori orfani, dei tumori agnostici e dei tumori di origine sconosciuta. Tutto questo è completato da un tirocinio pratico in cui potrai aggiornare le tue conoscenze direttamente in uno dei migliori ospedali nell'approccio e nello studio di questo tipo di cancro.
Gli studenti avranno così accesso a un quadro teorico 100% online, con contenuti multimediali che li condurranno ai più recenti sviluppi della ricerca clinica sui tumori rari, ai nuovi modelli di sperimentazione clinica, alla farmacologia, alla medicina di precisione e agli aspetti molecolari che riguardano le sindromi ereditarie. Un programma a cui si può accedere comodamente da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet e in qualsiasi momento della giornata.
Una volta completata questa fase, il professionista entrerà in un tirocinio pratico che segnerà senza dubbio il percorso di aggiornamento delle sue conoscenze in questo campo. Questo istituto ha selezionato i migliori ambienti clinici, in modo che i laureati possano accedere alle tecniche, ai metodi e alle procedure più innovative in questo settore in soli 3 mesi. In questo modo sarà in grado, insieme ai migliori, di integrare questa metodologia nella sua pratica quotidiana.
Un'opportunità unica che consente ai medici di aggiornare le proprie conoscenze sui tumori di origine sconosciuta, attraverso una qualifica universitaria di qualità, compatibile con la loro vita professionale quotidiana e con i migliori specialisti del settore.
Un'esperienza educativa unica, cruciale e decisiva per crescere professionalmente"
Questo Master semipresenziale in Tumore di Origine Sconosciuta possiede il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Sviluppo di oltre 100 casi clinici presentati da professionisti esperti in Cancro
- I suoi contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici, sono pensati per fornire informazioni scientifiche e assistenziali su quelle discipline mediche che sono essenziali per la pratica professionale
- Valutazione del paziente per i pazienti lungo-sopravviventi con tumori a bassa incidenza
- Piani completi di azione sistematizzata per le principali Sintomatologia nell'unità di Origine sconosciuta
- Presentazione di workshop pratici sulle tecniche diagnostiche e terapeutiche nel paziente critico
- Sistema di apprendimento interattivo, basato su algoritmi per il processo decisionale riguardante le situazioni cliniche presentate
- Guide di pratiche cliniche sull’approccio a diverse patologie
- Con una speciale enfasi sulla medicina basata su prove e metodologie di ricerca di tumori
- Questo sarà integrato da lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e lavoro di riflessione individuale.
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
- Possibilità di svolgere un tirocinio clinico all’interno di uno dei migliori centri ospedalieri
Svolgi un tirocinio intensivo di 3 settimane presso un centro prestigioso che ti mostrerà il cambiamento di paradigma del cancro di origine sconosciuta nell'era molecolare"
In questa proposta di Master, di natura professionalizzante e in modalità Semipresenziale, il programma è finalizzato all'aggiornamento professionale di esperti in Cancro che svolgono le loro funzioni in unità specializzate e che richiedono un elevato livello di qualificazione. I contenuti sono basati sulle ultime evidenze scientifiche, orientati in modo didattico per integrare le conoscenze teoriche nella pratica medica, e gli elementi teorico-pratici faciliteranno l'aggiornamento delle conoscenze e permetteranno di prendere decisioni nella gestione dei pazienti.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale. La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale si deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il programma. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.
Questo Master semipresenziale ti mostrerà i progressi compiuti con i pazienti adolescenti e con i bambini lungo-sopravviventi"

Scopri le tecniche più avanzate di Biologia Molecolare applicate al Cancro Midollare della Tiroide"
Pianificazione del corso
Il piano di studi di questo Master semipresenziale è stato creato per offrire la conoscenza più rigorosa ed esaustiva del cancro di origine sconosciuta nell'arco di 12 mesi. Per questo, il professionista dispone di video riassuntivi di ogni argomento, video in dettaglio, letture essenziali e casi di studio a cui si può accedere in qualsiasi momento della giornata da un computer, un tablet o un cellulare con una connessione a Internet. Inoltre, al termine di questa fase teorica, inizierà una fase pratica presso un ospedale di grande prestigio internazionale.

Hai a disposizione strumenti pedagogici multimediali innovativi che ti forniranno contenuti dinamici e visivi sugli studi dei tumori rari"
Modulo 1. La realtà dei tumori orfani, agnostici e di origine sconosciuta
1.1. Tumore a bassa incidenza
1.1.1. Cancro poco frequente, raro e ultra-raro
1.1.2. Tumori orfani
1.1.3. Tumori agnostici
1.1.4. Tumore di origine sconosciuta
1.2. Epidemiologia del cancro poco frequente
1.2.1. Incidenza e prevalenza dei tumori poco frequenti
1.2.2. Tendenze degli indici a livello europeo
1.3. Sopravvivenza nei tumori poco frequenti
1.3.1. Dati sulla sopravvivenza a livello europeo
1.3.2. Cause delle differenze di sopravvivenza
1.4. Medicina di precisione e tumori poco frequenti
1.4.1. Medicina di precisione
1.4.2. Giustificazione della medicina di precisione nei tumori poco frequenti
1.4.3. Esperienze cliniche con la medicina di precisione nei tumori poco frequenti
1.4.4. Applicazione della genomica nella diagnosi e nel trattamento dei tumori poco frequenti
1.5. Modelli assistenziali per tumori poco frequenti
1.5.1. Registri tumorali
1.5.2. Reti di esperti
1.5.3. Unità di riferimento
1.5.4. Tumor Board Review
1.6. Ruolo della Biobanca nella ricerca clinica
1.6.1. Biobanca
1.6.2. Regolazione legislativa
1.6.3. La Biobanca nella gestione dei tumori poco frequenti
1.7. Aspetti metodologici della ricerca clinica sui tumori poco frequenti
1.7.1. Importanza della ricerca clinica sui tumori poco frequenti
1.7.2. Difficoltà di ricerca sui tumori poco frequenti
1.7.3. Nuovi modelli di studio clinico
1.7.4. Inferenza bayesiana
1.7.5. Nanoscienza applicata a tumori rari o bioinformatica e nuovi modelli matematici di studio dei tumori rari
1.8. Legislazione
1.8.1. Quadro Europeo
1.8.2. Agenzie di regolamentazione
1.9. Accesso ai farmaci
1.9.1. Accesso ai farmaci
1.9.2. Terapie off Label
1.10. Aspetti psicologici e sociali dei tumori a bassa incidenza
1.10.1. Aspetti psicologici di questo spettro di patologia
1.10.2. Problemi sociali che colpiscono il paziente con tumore raro
Modulo 2. Strumenti di biologia molecolare per l’approccio agnostico del tumore raro
2.1. Concetti di oncologia molecolare
2.1.1. Concetti di genetica
2.1.2. Concetti di epigenetica
2.1.3. Concetti di DNA
2.1.4. Concetti di RNA
2.2. Studio del DNA tumorale I.Biopsia solida
2.2.1. Genoma
2.2.2. Esoma
2.2.3. Pannelli di sequenziamento
2.3. Studio del DNA tumorale II. Biopsia liquida
2.3.1. Piattaforme disponibili
2.3.2. Applicazioni attuali
2.4. Studio del DNA germinale
2.4.1. Varianti e polimorfismi
2.4.2. Alterazioni nella linea germinale
2.5. Studio del RNA messaggero
2.5.1. Trascrittomica
2.5.2. Pannelli di sequenziamento (Nanostring)
2.5.3. Single cell RNA
2.6. Epigenetica I.Metilazione e pannelli di metilazione
2.6.1. Metilazione
2.6.2. Pannelli di metilazione
2.7. Epigenetica II. RNA non codificante, modifiche della cromatina
2.7.1. Long Non Coding RNA
2.7.2. MicroRNA
2.7.3. Rimodellamento della cromatina
2.8. Modelli funzionali I.Rilevamento dei farmaci in colture cellulari primarie e organoidi
2.9. Biologia molecolare in Immunoncologia I
2.9.1. Tumore Mutation Burden
2.9.2. Neoantigeni
2.9.3. Il Microbiota
2.9.4. Terapia cellulare adottiva
2.10. Biologo molecolare in Immunoncologia II. Modelli funzionali
2.10.1. Coltura di linfociti
2.10.2. Metodi murini umanizzati
Modulo 3. Tumori della pleura, del mediastino e della parete toracica: Il tumore del polmone come paradigma dei nuovi tumori rari ma non orfani. Tumori della testa e del collo
3.1. Tumori di origine pleurica: mesotelioma
3.1.1. Introduzione e epidemiologia
3.1.2. Eziologia e patogenesi
3.1.3. Presentazione clinica
3.1.4. Diagnosi e stadiazione
3.1.5. Fattori prognostici
3.1.6. Trattamento e raccomandazioni (guidelines/consenso)
3.1.7. Prospettive future
3.2. Tumori del mediastino: timoma e carcinoma timico
3.2.1. Introduzione e epidemiologia
3.2.2. Eziologia e patogenesi
3.2.3. Presentazione clinica
3.2.4. Diagnosi e stadiazione
3.2.5. Fattori prognostici
3.2.6. Trattamento e raccomandazioni (guidelines/consenso)
3.2.7. Futuro
3.3. Tumori della parete toracica
3.3.1. Introduzione e epidemiologia
3.3.2. Eziologia e patogenesi
3.3.3. Presentazione clinica
3.3.4. Diagnosi e classificazione
3.3.5. Fattori prognostici
3.3.6. Trattamento e raccomandazioni
3.3.7. Futuro
3.4. NET di origine polmonare: carcinoide tipico, atipico e carcinoma a cellule grandi
3.4.1. Introduzione e epidemiologia
3.4.2. Eziologia e patogenesi
3.4.3. Presentazione clinica
3.4.4. Diagnosi e classificazione
3.4.5. Fattori prognostici
3.4.6. Trattamento e raccomandazioni
3.4.7. Futuro
3.5. Il tumore polmonare come paradigma di medicina personalizzata: tecniche diagnostiche e ruolo della biopsia liquida
3.5.1. Introduzione
3.5.2. Tipi di campioni in base all’approccio diagnostico
3.5.3. Ottimizzazione nella gestione di campionamento
3.5.4. Tempo di risposta e caratteristiche del rapporto
3.5.5. Eterogeneità tumorale: Ruolo della biopsia liquida
3.5.6. Tecniche di diagnosi molecolare: IHQ, FISH, RT-PCR, NGS
3.5.7. Raccomandazioni delle guide
3.6. Mutazioni: EGFR, BRAF, MET, KRAS
3.6.1. Introduzione: epidemiologia, profilo del paziente, tecniche diagnostiche e malattia cerebrale
3.6.2. Fattori prognostici
3.6.3. Prima linea del trattamento diretto
3.6.4. Meccanismi di resistenza
3.6.5. Trattamento di 2L e successive linee
3.6.6. Ruolo della chemioterapia +/- immunoterapia
3.6.7. Futuro
3.7. Traslocazioni: ALK, ROS-1
3.7.1. Introduzione: epidemiologia, profilo del paziente, tecniche diagnostiche e malattia cerebrale
3.7.2. Fattori prognostici
3.7.3. Prima linea del trattamento diretto
3.7.4. Meccanismi di resistenza
3.7.5. Trattamento di 2L e successive linee
3.7.6. Ruolo della chemioterapia +/- immunoterapia
3.7.7. Futuro
3.8. Riordinamento/amplificazioni: NTRK, RET, MET, HER-2
3.8.1. Introduzione: epidemiologia, profilo del paziente, tecniche diagnostiche e malattia cerebrale
3.8.2. Fattori prognostici
3.8.3. Prima linea del trattamento diretto
3.8.4. Meccanismi di resistenza
3.8.5. Trattamento di 2L e successive linee
3.8.6. Ruolo della chemioterapia +/- immunoterapia
3.8.7. Futuro
3.9. Carcinoma nasofaringeo e tumori delle ghiandole salivari: Tumori nasali e dei seni paranasali
3.9.1. Carcinoma nasofaringeo
3.9.1.1. Introduzione
3.9.1.2. Dati epidemiologici
3.9.1.3. Eziologia ed eziopatogenesi
3.9.1.4. Manifestazioni cliniche
3.9.1.5. Metodi diagnostici e diagnosi di estensione
3.9.1.6. Trattamento multidisciplinare
3.9.2. Tumori delle ghiandole salivari
3.9.2.1. Tumori delle ghiandole salivari maggiori
3.9.2.2. Tumori delle ghiandole salivari minori
3.9.3. Tumori nasali e dei seni paranasali
3.9.3.1. Epidemiologia
3.9.3.2. Eziopatogenesi, istologia e storia naturale
3.9.3.3. Clinica, diagnosi e stadiazione
3.9.3.4. Trattamento
3.10. Melanomi, sarcomi e sindromi linfoproliferative di testa e collo: Tumori rari. Ameloblastoma. Tumori neuroendocrini di testa e collo
3.10.1. Melanoma della testa e del collo
3.10.1.1. Fattori eziologici, epidemiologici e clinici
3.10.1.2. Aspetti diagnostici e terapeutici
3.10.1.3. Presentazioni speciali del melanoma alla testa e al collo
3.10.2. Sarcomi della testa e del collo
3.10.2.1. Eziopatogenesi ed epidemiologia
3.10.2.2. Aspetti clinici
3.10.2.3. Diagnosi
3.10.2.4. Aspetti terapeutici
3.10.3. Sindromi linfoproliferative di testa e collo
3.10.3.1. Fattori eziologici
3.10.3.2. Procedure di stadiazione
3.10.3.3. Schema clinico delle neoplasie del sistema linfoide
3.10.4. Tumori ai denti
3.10.4.1. Classificazione dei tumori odontogeni
3.10.5. Ameloblastoma
3.10.6. Tumori neuroendocrini di testa e collo
3.10.6.1. Carcinoma neuroendocrino di origine epiteliale
3.10.6.2. Carcinoide atipico
3.10.6.3. Carcinoma neuroendocrino a piccole cellule
3.10.6.4. Carcinoma neuroendocrino a grandi cellule
3.10.6.5. Carcinoma neuroendocrino di origine neurale
Modulo 4. Tumori digerenti rari. Tumori neuroendocrini dell'apparato digerente. Tumore alla tiroide
4.1. Tumori dell’intestino tenue. Tumori dell'appendice
4.1.1. Tumori dell’intestino tenue
4.1.1.1. Epidemiologia. Fattori di rischio
4.1.1.2. Patogenesi, profilo molecolare e sindromi ereditarie
4.1.1.3. Caratteristiche cliniche. Sottotipi istologici
4.1.1.4. Diagnosi e stadiazione. Prognosi
4.1.1.5. Trattamento della malattia localizzata. Monitoraggio
4.1.1.6. Trattamento della malattia metastatica
4.1.2. Tumori dell'appendice
4.1.2.1. Epidemiologia
4.1.2.2. Istologia: Stadiazione
4.1.2.3. Clinica. Diagnosi
4.1.2.4. Trattamento della malattia localizzata
4.1.2.5. Trattamento della malattia metastatica
4.1.2.6. Pseudomixoma peritoneale
4.2. Tumore del canale anale
4.2.1. Epidemiologia Fattori di rischio
4.2.2. VPH, genotipi: Patogenesi molecolare
4.2.3. Anatomia patologica Stadiazione
4.2.4. Clinica. Diagnosi
4.2.5. Trattamento della malattia localizzata. Monitoraggio
4.2.6. Trattamento della malattia metastatica. Immunoterapia
4.3. Tumori del fegato e delle vie biliari intraepatiche. Neoplasie della cistifellea e delle vie biliari extraepatiche
4.3.1. Epatocarcinoma
4.3.1.1. Aspetti epidemiologici
4.3.1.2. Processo diagnostico
4.3.1.3. Stadiazione
4.3.1.4. Gestione della malattia locale: trapianto vs. resezione
4.3.1.5. Gestione della malattia locale: tecniche ablative
4.3.1.6. Gestione della malattia localmente avanzata
4.3.1.6.1. Radioembolizzazione
4.3.1.6.2. Chemioembolizzazione transarteriosa
4.3.1.6.3. Radioterapia
4.3.1.7. Trattamento della malattia metastatica
4.3.2. Tumori delle vie biliari
4.3.2.1. Caratterizzazione delle tre entità che conformano il gruppo
4.3.2.2. Aspetti epidemiologici
4.3.2.3. Fattori di rischio
4.3.2.4. Espressività clinica
4.3.2.5. Aspetti diagnostici
4.3.2.6. Criteri di irretrattabilità
4.3.2.7. Aspetti fisiologici
4.3.2.8. Aspetti molecolari. Classificazione molecolare
4.3.2.9. Alterazioni genomiche descritte
4.3.2.10. Trattamento della malattia localizzata
4.3.2.10.1. Chirurgia
4.3.2.10.2. Criteri adiuvanti
4.3.2.10.3. Monitoraggio
4.3.2.11. Trattamento della malattia avanzata
4.3.2.11.1. Trattamento della malattia localmente avanzata
4.3.2.11.2. Trattamento della malattia metastatica
4.3.2.12. Monitoraggio
4.4. Tumori stromali gastrointestinali
4.4.1. Aspetti clinici ed epidemiologici
4.4.2. Processo diagnostico dei GIST
4.4.2.1. Radiologia
4.4.2.2. Istologia
4.4.2.3. Biologia molecolare
4.4.3. Trattamento della malattia localizzata
4.4.3.1. Aspetti chirurgici
4.4.3.2. Fattori prognostici dopo la resezione
4.4.3.3. Trattamento adiuvante
4.4.3.4. Trattamento neoadiuvante
4.4.4. Trattamento della malattia avanzata
4.4.4.1. Chirurgia nel contesto della malattia avanzata
4.4.4.2. Trattamento sistemico
4.4.4.3. Monitoraggio
4.5. Tumori neuroendocrini: tumori dell’intestino tenue
4.5.1. Epidemiologia
4.5.2. Anatomia patologica Grado istologico. Ki67 e indice mitotico
4.5.3. Fattori molecolari: Biomarcatori
4.5.4. Clinica. Sindrome carcinoide
4.5.5. Diagnosi e stadiazione. Prognosi
4.5.6. Trattamento della malattia localizzata. Monitoraggio
4.5.7. Trattamento della malattia metastatica. Trattamenti dell’ipersecrezione non ormonale
4.6. Tumori neuroendocrini: tumori del pancreas
4.6.1. Epidemiologia
4.6.2. Anatomia patologica. Grado istologico
4.6.3. Fattori molecolari: Biomarcatori
4.6.4. Clinica. Sindrome carcinoide
4.6.5. Diagnosi e stadiazione. Prognosi
4.6.6. Trattamento della malattia localizzata. Monitoraggio
4.6.7. Trattamento della malattia metastatica. Trattamento della sindromi dell’ipersecrezione non ormonale
4.6.8. Trattamento delle linee avanzate
4.7. Cancro della tiroide
4.7.1. Introduzione
4.7.2. Incidenza e epidemiologia
4.7.3. Aspetti clinici ed diagnosi
4.7.4. Aspetti generali del trattamento
4.7.5. Raccomandazioni delle guide e livello di evidenza
4.8. Tumore differenziato alla tiroide
4.8.1. Diagnosi, anatomia patologica e biologa molecolare
4.8.2. Stadiazione e valutazione dei rischi
4.8.3. Gestione del tumore primario
4.8.4. Gestione della malattia avanzata
4.8.5. Monitoraggio e sopravvissuti a lungo
4.9. Tumore alla tiroide anaplastico
4.9.1. Diagnosi, anatomia patologica e biologa molecolare
4.9.2. Stadiazione e valutazione dei rischi
4.9.3. Gestione del tumore primario
4.9.4. Gestione della malattia avanzata
4.9.5. Monitoraggio e sopravvissuti a lungo
4.10. Tumore midollare alla tiroide
4.10.1. Diagnosi, anatomia patologica e biologa molecolare
4.10.2. Stadiazione e valutazione dei rischi
4.10.3. Gestione del tumore primario
4.10.4. Gestione della malattia avanzata
4.10.5. Monitoraggio e sopravvissuti a lungo
Modulo 5. Tumori rari dell’area ginecologica: Tumori rari al seno. Oncologia genitourinaria dei tumori rari
5.1. Tumore ovarico raro
5.1.1. Tumori dei cordoni sessuali
5.1.2. Tumore della granulosa
5.1.3. Tumori germinali della donna
5.1.4. Sarcoma alle ovaie
5.1.5. Tumore ovarico ereditario
5.2. Tumore uterino raro
5.2.1. Adenosarcoma
5.2.2. Tumore mulleriano misto
5.2.3. Sarcoma uterino
5.2.4. Carcinoma endometriale ereditario
5.3. Tumore della cervice raro
5.3.1. Adenocarcinoma
5.3.2. Tumore della cervice non associato a HPV
5.3.3. Sarcomi della cervice
5.4. Altri tumori rari dell’area ginecologica
5.4.1. Tumore della vulva
5.4.2. Tumore vaginale
5.5. Tumori rari al seno
5.5.1. Classificazione dei tumori rari al seno
5.5.2. Aspetti diagnostici e terapeutici
5.6. Tumori germinali
5.6.1. Aspetti generali: eziologia ed epidemiologia
5.6.2. Aspetti clinici e classificazione
5.6.3. Aspetti diagnostici e terapeutici dei tumori germinali
5.7. Tumori a bassa incidenza alla prostata
5.7.1. Adenocarcinoma con varianti istologiche
5.7.1.1. Adenocarcinoma NOS
5.7.1.2. Adenocarcinoma delle cellule acinari
5.7.1.3. Adenocarcinoma mucinoso
5.7.1.4. Adenocarcinoma a cellule ad anello
5.7.1.5. Adenocarcinoma con differenziazione neuroendocrina
5.7.1.6. Adenocarcinoma ossifilo
5.7.1.7. Adenocarcinoma spindle cell
5.7.1.8. Carcinoma linfoepiteliale
5.7.2. Carcinoma a cellule squamose con varianti istologiche
5.7.2.1. Carcinoma squamoso
5.7.2.2. Carcinoma adenosquamoso
5.7.3. Carcinoma infiltrante dei dotti
5.7.3.1. Carcinoma cribroso
5.7.3.2. Carcinoma solido NOS
5.7.3.3. Adenocarcinoma papillare NOS
5.7.4. Carcinoma delle cellule transizionali
5.7.5. Tumori della ghiandola salivar-like
5.7.5.1. Carcinoma cistico adenoide
5.7.5.2. Carcinoma basaloide
5.7.5.3. Carcinoma basocellulare
5.7.6. Nuova disposizione molecolare nel tumore alla prostata
5.8. Tumori poco frequenti alla vescica e al tratto urinario superiore
5.8.1. Carcinoma delle cellule transizionali
5.8.2. Carcinoma squamoso con varianti
5.8.3. Adenocarcinoma con varianti
5.8.4. Tumori della ghiandola salivar-like
5.8.5. Sottotipi molecolari del tumore alla vescica
5.9. Tumori renali poco frequenti
5.9.1. Aspetti generali del tumore renale non a cellule chiare
5.9.2. Epidemiologia ed eziopatogenesi
5.9.3. Classificazione dei tumori renali non a cellule chiare
5.9.4. Diagnosi e trattamento
5.10. Tumore al pene
5.10.1. Epidemiologia ed eziopatogenesi
5.10.2. Aspetti clinici ed diagnosi
5.10.3. Stadiazione del tumore al pene
5.10.4. Malattia localizzata
5.10.5. Malattia localmente avanzata e metastatica
Modulo 6. Sindromi ereditarie, dalla biologia all’applicazione clinica: Tumori pediatrici e tumori del bambino nell’adulto
6.1. Predisposizione ereditaria ai tumori endocrini e neuroendocrini
6.1.1. Aspetti clinici
6.1.2. Aspetti molecolari
6.2. Melanoma familiare e genodermatosi
6.2.1. Aspetti generali
6.2.2. Aspetti clinici
6.2.3. Aspetti molecolari
6.3. Neurofibromatosi. Sindrome di Li Fraumeni
6.3.1. Aspetti generali della neurofibromatosi
6.3.2. Aspetti clinici
6.3.3. Aspetti molecolari
6.3.4. Aspetti generali della sindrome di Li Fraumeni
6.3.5. Aspetti clinici
6.3.6. Aspetti molecolari
6.4. Sindromi ereditarie nei bambini
6.4.1. Aspetti generali
6.4.2. Aspetti clinici
6.4.3. Aspetti molecolari
6.5. Aspetti generali del cancro pediatrico
6.5.1. Epidemiologia ed eziopatogenesi
6.5.2. Aspetti clinici del cancro pediatrico
6.5.3. Aspetti diagnostici e terapeutici
6.5.4. La biologia molecolare e la sua applicazione al cancro pediatrico
6.6. Tumori intraoculari
6.6.1. Medulloepitelioma
6.6.2. Retinoblastoma
6.7. Tumori oculari del bambino
6.7.1. Tumori orbitali
6.7.1.1. Rabdomiosarcoma
6.7.1.2. Adenoma pleomorfo della ghiandola lacrimale
6.7.1.3. Metastasi orbitale
6.7.2. Tumori intraoculari
6.7.2.1. Rabdomiosarcoma
6.7.2.2. Adenoma pleomorfo della ghiandola lacrimale
6.8. Tumori ossei, germinali e altri tumori pediatrici
6.8.1. Sarcoma di Ewing
6.8.2. Tumori delle cellule germinali
6.8.3. Altri tumori pediatrici
6.9. Cure palliative nei bambini
6.9.1. Aspetti peculiari delle CP nel bambino affetto da cancro
6.10 Tumori pediatrici negli adulti
6.10.1. Aspetti generali dei tumori pediatrici nell'adulto
6.10.2. Classificazione dei tumori dello sviluppo
6.10.3. Aspetti diagnostici
6.10.4. Difficoltà di trattamento
6.10.5. Nuovi approcci nella gestione dei tumori dell'adulto nei bambini: nuovi disegni metodologici
Modulo 7. Tumori muscolo-scheletrici: Tumori epiteliali. Tumori del sistema nervoso centrale. Tumori oculari
7.1. Sarcomi delle ossa e dei tessuti molli: classificazione, caratteristiche e approccio diagnostico alla terapia
7.1.1. Informazioni generali ed epidemiologia
7.1.2. Eziopatogenesi e classificazione
7.1.3. Aspetti clinici
7.1.4. Aspetti diagnostici e terapeutici
7.2. Sarcomi dei tessuti molli
7.2.1. Liposarcoma
7.2.2. Rabdomiosarcoma
7.2.3. Leiomiosarcoma
7.2.4. Sarcoma sinoviale
7.2.5. Angiosarcoma
7.2.6. Linfangiosarcoma
7.2.7. Tumore maligno della guaina nervoso-periferica
7.2.8. Sarcomi dei tessuti molli specifici
7.2.8.1. Sarcomi con cariotipo complesso
7.2.8.2. Sottotipi di traslocazione specifica
7.2.8.3. Sarcomi dello sviluppo
7.2.8.4. Sarcoma alveolare dei tessuti molli
7.2.8.5. Sarcoma a cellule chiare
7.2.8.6. PEComa
7.2.8.7. Tumore fibroso solitario
7.2.8.8. Tumore miofibroblastico infiammatorio
7.2.8.9. Tumore desmoplastico delle cellule rotonde
7.2.8.10. Tumori mesenchimali con comportamento localmente aggressivo
7.3. Sarcomi dello scheletro
7.3.1. Condrosarcoma
7.3.2. Fibrosarcoma
7.3.3. Sarcoma a cellule chiare
7.3.4. Cordoma
7.4. Sarcoma viscerale
7.4.1. Aspetti generali dei sarcomi viscerali a bassa incidenza
7.4.2. Classificazione dei sarcomi viscerali
7.4.3. Aspetti diagnostici e terapeutici
7.4.4. Aspetti molecolari
7.5. Tumori del sistema nervoso centrale: Classificazione, caratteristiche e approccio diagnostico e terapeutico
7.5.1. Classificazione
7.5.2. Epidemiologia ed eziopatogenesi
7.5.3. Caratteristiche cliniche generali
7.5.4. Algoritmo diagnostico
7.5.5. Approccio terapeutico
7.6. Tumori del sistema nervoso centrale: oligodendrogliomi e tumori astrocitari diffusi. Tumori ependimali. Tumori dei plessi coroidei. Tumori neuronali e misti gliali-neuronali
7.6.1. Oligodendrogliomi e astrocitomi diffusi
7.6.2. Tumori ependimali
7.6.3. Tumori dei plessi coroidei
7.6.4. Tumori neuronali e misti gliali-neuronali
7.7. Tumori della regione pineale. Tumori embrionali. Linfoma del sistema nervoso centrale. Tumori delle cellule germinali. Tumori della regione sellare. Miscellanea
7.7.1. Tumori della regione pineale
7.7.2. Tumori embrionali
7.7.3. Linfoma del sistema nervoso centrale
7.7.4. Tumori delle cellule germinali
7.7.5. Tumori della regione sellare
7.7.6. Miscellanea
7.8. Tumori maligni della base del cranio: Craniofaringioma e tumore fibroso solitario/emangiopericitoma
7.8.1. Cordoma
7.8.2. Condrosarcoma
7.8.3. Craniofaringioma
7.8.4. Tumore fibroso solitario: Emangiopericitoma
7.9. Tumori della pelle e degli annessi cutanei
7.9.1. Classificazione, caratteristiche e approccio diagnostico e terapeutico
7.9.2. Tumori originati nelle strutture benigne
7.9.2.1. Porocarcinoma
7.9.2.2. Idradenocarcinoma
7.9.2.3. Spiradenocarcinoma
7.9.2.4. Cilindrocarcinoma
7.9.3. Tumori ghiandolari analoghi
7.9.3.1. Carcinoma adenoide cistico
7.9.3.2. Carcinoma secretorio
7.9.3.3. Carcinoma apocrino
7.9.3.4. Carcinoma cribroso
7.9.3.5. Tumore misto maligno
7.9.3.6. Mioepitelioma maligno
7.9.4. Tumori con differenziazione follicolare pilifera
7.9.4.1. Carcinoma trichilemmale
7.9.4.2. Carcinoma pilomatricale
7.9.5. Tumori originari nell’area facciale
7.9.5.1. Carcinoma mucinoso
7.9.5.2. Carcinoma istiocitoide
7.9.5.3. Carcinoma muco-secretorio endocrino della ghiandola sudoripara
7.9.6. Sarcomi cutanei
7.9.6.1. Fibroxantoma atipico
7.9.6.2. Angiosarcoma
7.9.6.3. Dermatofibrosarcoma protuberans
7.9.6.4. Sarcoma di Kaposi non HIV e altri sarcomi
7.9.7. Miscellanea
7.9.7.1. Carcinoma adrenale microcistico
7.9.7.2. Carcinoma adenosquamoso
7.9.7.3. Adenocarcinoma
7.10. Tumori oculari dell’adulto
7.10.1. Tumori palpebrali
7.10.2. Carcinoma basocellulare
7.10.3. Carcinoma epidermoide
7.10.4. Cherantoacantoma
7.10.5. Melanoma lentigo maligna
7.10.6. Tumori congiuntivali
7.10.7. Neoplasia squamosa congiuntivale
7.10.8. Melanoma congiuntivale
7.10.9. Tumori del melanoma dell'uvea anteriore: melanoma dell’iris
7.10.10. Tumori del melanoma dell'uvea posteriore: melanoma del coroide
7.10.11. Metastasi coroidea
7.10.12. Metastasi orbitale
Modulo 8. Tumori agnostici
8.1. Concetto di trattamento agnostico: nuove entità oncologiche
8.1.1. Concetti
8.1.2. Trattamenti agnostici con approvazione delle agenzie
8.1.3. Trattamenti agnostici in fase di sviluppo
8.2. Famiglia del Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)
8.2.1. Struttura e funzione del NTRK
8.2.2. Algoritmo di identificazione di pazienti con fusioni di NTRK
8.2.3. Spettro clinico di tumori con fusioni di NTRK
8.3. Trattamento con inibitori NTRK
8.3.1. Aspetti generali
8.3.2. Indicazioni
8.3.3. Risultati dello studio pivotale
8.3.4. Risultati nella pratica clinica
8.3.5. Tossicità degli inibitori di NTRK
8.4. Tumori con instabilità dei microsatelliti
8.4.1. Significato dell’instabilità dei microsatelliti
8.4.2. Algoritmo di identificazione di pazienti con instabilità dei microsatelliti
8.4.3. Spettro clinico dei tumori instabili
8.5. Trattamento dei tumori con instabilità dei microsatelliti
8.5.1. Aspetti generali
8.5.2. Indicazioni
8.5.3. Risultati dello studio pivotale
8.5.4. Risultati nella pratica clinica
8.6. Verso il trattamento agnostico del tumore toracico e alla testa/al collo
8.6.1. Aspetti generali
8.6.2. Indicazioni e risultati
8.6.3. Tossicità
8.7. Verso il trattamento agnostico nei tumori digerenti
8.7.1. Aspetti generali
8.7.2. Indicazioni e risultati
8.7.3. Tossicità
8.8. Verso il trattamento agnostico del tumore urologico e ginecologico
8.8.1. Aspetti generali
8.8.2. Indicazioni e risultati
8.8.3. Tossicità
8.9. Verso il trattamento agnostico dei tumori del SNC
8.9.1. Aspetti generali
8.9.2. Indicazioni e risultati
8.9.3. Tossicità
8.10. Lo sviluppo del trattamento agnostico in altri tumori
8.10.1. Aspetti generali
8.10.2. Indicazioni e risultati
8.10.3. Tossicità
Modulo 9. Tumore di Origine Sconosciuta
9.1. Introduzione ed epidemiologia
9.1.1. Incidenza
9.1.2. Incidenza
9.1.3. Prognosi
9.1.4. Fattori di rischio
9.2. Spettro clinico della malattia
9.2.1. Classificazione
9.2.2. Sottogruppi di pazienti in base alla loro presentazione
9.3. Aspetti anatomopatologici della malattia
9.3.1. Considerazioni generali
9.3.2. Istologia
9.3.3. Profilo immunoistochimico raccomandato
9.4. Diagnosi del tumore di origine sconosciuta
9.4.1. Prove diagnostiche raccomandate
9.4.2. Ruolo del PET-TC
9.4.3. Algoritmo diagnostico
9.5. Tumore di origine sconosciuta nell’era molecolare
9.5.1. Cambio di paradigma
9.5.2. Profilo molecolare orientato all'origine anatomica
9.5.3. Profilo molecolare orientato all'identificazione di alterazioni genomiche
9.6. Trattamento classico del tumore di origine sconosciuta
9.6.1. Sottogruppo con buona prognosi
9.6.2. Sottogruppo con cattiva prognosi
9.7. Trattamento con obiettivi specifici nell'era molecolare
9.7.1. Cambio di paradigma: dalla clinica alla biologa molecolare
9.7.2. Profilo molecolare orientato all'origine tumorale
9.7.3. Profilo molecolare orientato all’obiettivo terapeutico
9.8. Studi clinici: nuovi disegni
9.9. Ruolo dei Registri dei Tumori: Comitato Clinico e Molecolare
9.9.1. Registri tumorali
9.9.2. Biobanche
9.9.3. Comitato Clinico e Molecolare
9.10. Raccomandazioni delle guide
Modulo 10. Terapia di supporto, gestione delle intossicazioni da trattamento antineoplastico, cure palliative e assistenza ai pazienti lungodegenti con tumori a bassa incidenza
10.1. Aumento della sopravvivenza e della qualità di vita associato alle cure di supporto nel paziente oncologico
10.1.1. Valutazione della qualità di vita in oncologia
10.1.2. Impatto del trattamento di supporto nelle qualità di vita
10.1.3. Impatto del trattamento di supporto nella sopravvivenza
10.2. Trattamento del dolore oncologico e dei sintomi associati
10.2.1. Dolore basale nel paziente oncologico
10.2.2. Dolore incidentale nel paziente oncologico
10.2.3. Tipi di dolore: somatico, viscerale, neuropatico
10.2.4. Valutazione diagnostica del dolore
10.2.5. Trattamento del dolore: 1ª e 2ª fase
10.2.6. Trattamento oppioide: Rotazione di oppioidi
10.2.7. Tossicità del trattamento oppioide
10.2.8. Farmaci coadiuvanti
10.2.9. Tecniche di intervento
10.2.10. Tecniche non farmacologiche
10.3. Tossicità del trattamento antineoplastico: Chemioterapia
10.3.1. Meccanismi di azione della chemioterapia
10.3.2. Valutazione della tossicità della chemioterapia
10.3.3. Tossicità più frequenti
10.3.3.1. Tossicità dell'apparato digerente
10.3.3.2. Tossicità nella pelle e nelle mucose
10.3.3.3. Tossicità ematologica
10.3.3.4. Neurotossicità
10.3.3.5. Cardiotossicità
10.3.3.6. Nefrotossicità
10.4. Tossicità del trattamento antineoplastico: terapia mirata
10.4.1. Meccanismi d’azione delle terapie mirate
10.4.2. Valutazione della tossicità della terapia mirata
10.4.3. Tossicità più frequenti
10.4.3.1. Tossicità dell'apparato digerente
10.4.3.2. Tossicità nella pelle e nelle mucose
10.4.3.3. Tossicità ematologica
10.4.3.4. Gestione dell’ipertensione tossica
10.4.3.5. Cardiotossicità
10.4.3.6. Eventi di trombosi
10.5. Tossicità del trattamento antineoplastico: immunoterapia
10.5.1. Meccanismi di azione dell’immunoterapia
10.5.2. Valutazione della tossicità dell’immunoterapia
10.5.3. Tossicità più frequenti
10.5.3.1. Tossicità dell'apparato digerente
10.5.3.2. Tossicità nella pelle e nelle mucose
10.5.3.3. Tossicità respiratoria
10.5.3.4. Tossicità neurologica
10.5.4. Tossicità in persone speciali
10.6. Tossicità grave del trattamento oncologico: Criteri di ammissione in Terapia Intensiva del paziente oncologico
10.6.1. Spettro di tossicità grave nel paziente trattato con immunoterapia
10.6.2. Ri-trattamento dopo la tossicità limitante del trattamento
10.6.3. Sindrome da tempesta di citochine
10.6.4. Tossicità neurologica grave
10.6.5. Tossicità respiratoria grave
10.6.6. Aspetti relazionati con l’ammissione in Terapia Intensiva del paziente oncologico
10.7. Cure alla fine della vita: Concetti associati con il paziente terminale. Sedazione palliativa
10.7.1. Modelli di attenzione al paziente in situazione palliativa
10.7.2. Concetto di malattia terminale
10.7.3. Principali sindromi alla fine della vita
10.7.4. Diagnosi dell’agonia: Situazione negli ultimi giorni
10.7.5. Sedazione palliativa
10.8. Sopravvissuti al tumore a lungo termine: programmi di monitoraggio
10.8.1. Introduzione e definizione del concetto di sopravvissuto al tumore a lungo termine
10.8.2. Tassi di sopravvivenza e stime del numero di sopravvissuti al tumore a lungo termine
10.8.3. Modelli di monitoraggio dei sopravvissuti al tumore a lungo termine
10.9. Sopravvissuti al tumore a lungo termine: Conseguenze più frequenti
10.9.1. Identificazione dei problemi specifici dei sopravvissuti a lungo termine
10.9.2. Richiesta di attenzione sanitaria e non
10.10. Situazioni speciali: sopravvissuti a lungo termine con malattia, bambini e adolescenti sopravvissuti a lungo termine
10.10.1. Paziente malato e sopravvissuto a lungo termine
10.10.2. Adolescente sopravvissuto a lungo termine

Questo programma ti farà immergere nei principali trattamenti adiuvanti e neoadiuvanti utilizzati nei pazienti oncologici”
Master Semipresenziale in Tumore di Origine Sconosciuta
TECH Global University ti offre un'opportunità unica per specializzarti nel campo del cancro di origine sconosciuta, una delle sfide più complesse e affascinanti della medicina di oggi. Il nostro innovativo programma di master semi-presenziale in cancro di origine sconosciuta ti fornirà gli strumenti necessari per affrontare questo enigma medico e diventare un esperto altamente qualificato in materia. In TECH, comprendiamo che la necessità di un aggiornamento specializzato nel campo del cancro di origine sconosciuta è sempre più pressante. Per questo motivo, abbiamo progettato un programma di studio rigoroso e completo che combina la flessibilità dell'istruzione online con l'esperienza pratica che acquisirai in rinomate cliniche, ospedali e centri di ricerca associati a TECH.
Trova nuove forme di ricerca sulle malattie sconosciute
Il nostro programma di master si concentra sul fornire le conoscenze più aggiornate sul cancro di origine sconosciuta, nonché gli strumenti diagnostici e terapeutici più avanzati. Imparerai a conoscere le più recenti tecniche di imaging, biopsie molecolari e analisi genetiche, che ti permetteranno di identificare la possibile origine del cancro e stabilire la causa sottostante di questa patologia. Inoltre, avrai l'opportunità di partecipare a stage faccia a faccia in cliniche, ospedali e centri specializzati riconosciuti nel campo del cancro, dove potrai applicare le tue conoscenze in un ambiente reale e lavorare a fianco di professionisti esperti. Questi stage ti forniranno una preziosa esperienza pratica e ti permetteranno di stabilire connessioni professionali che ti apriranno nuove porte nella tua carriera. Se sei pronto a diventare un esperto di cancro di origine sconosciuta e fare la differenza nella vita dei pazienti, non perdere l'opportunità di unirti al nostro Master semi-presenziale in cancro di origine sconosciuta presso TECH Global University. Iscriviti oggi stesso e fai un passo avanti nella tua carriera medica! Salva vite!