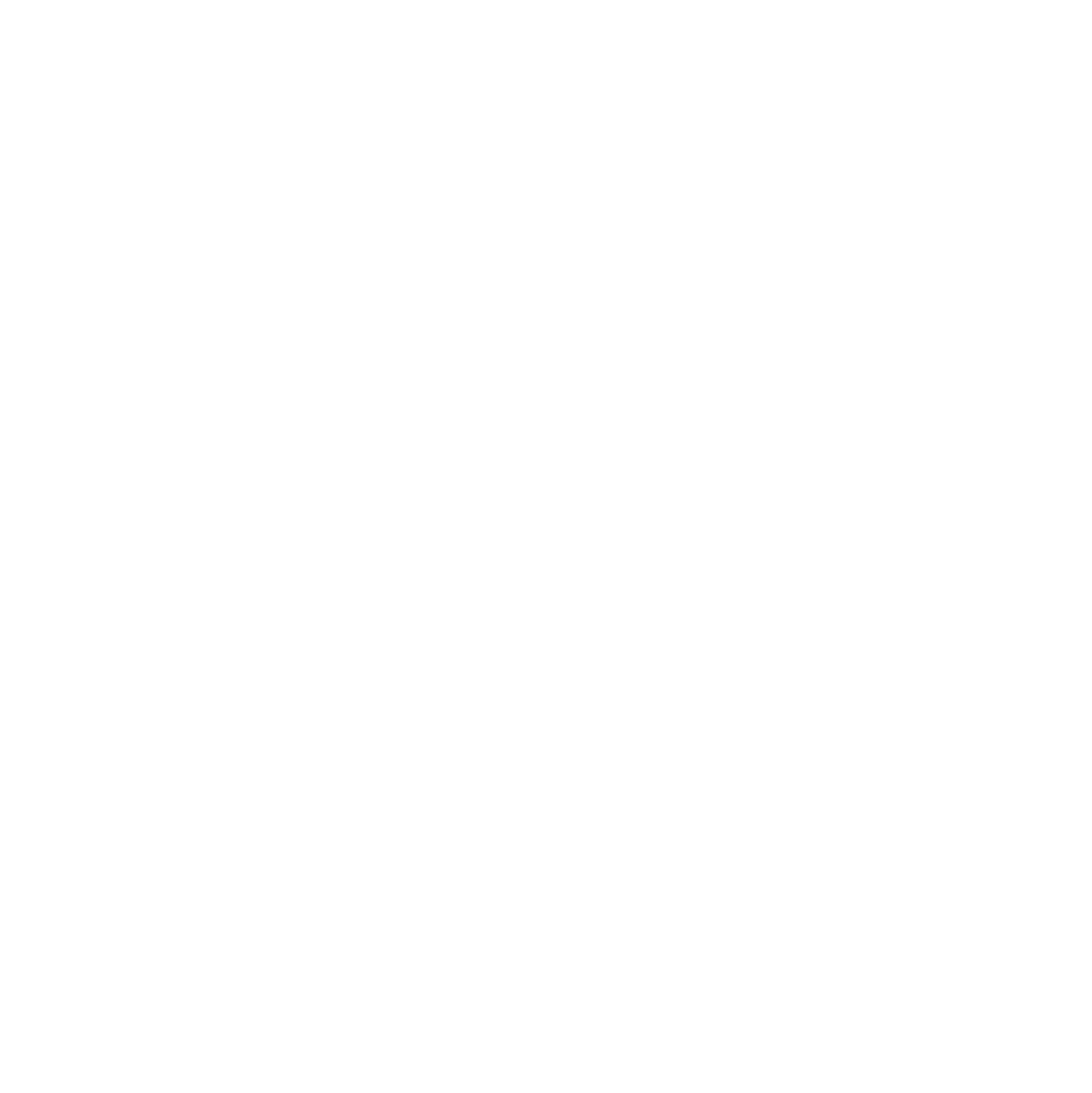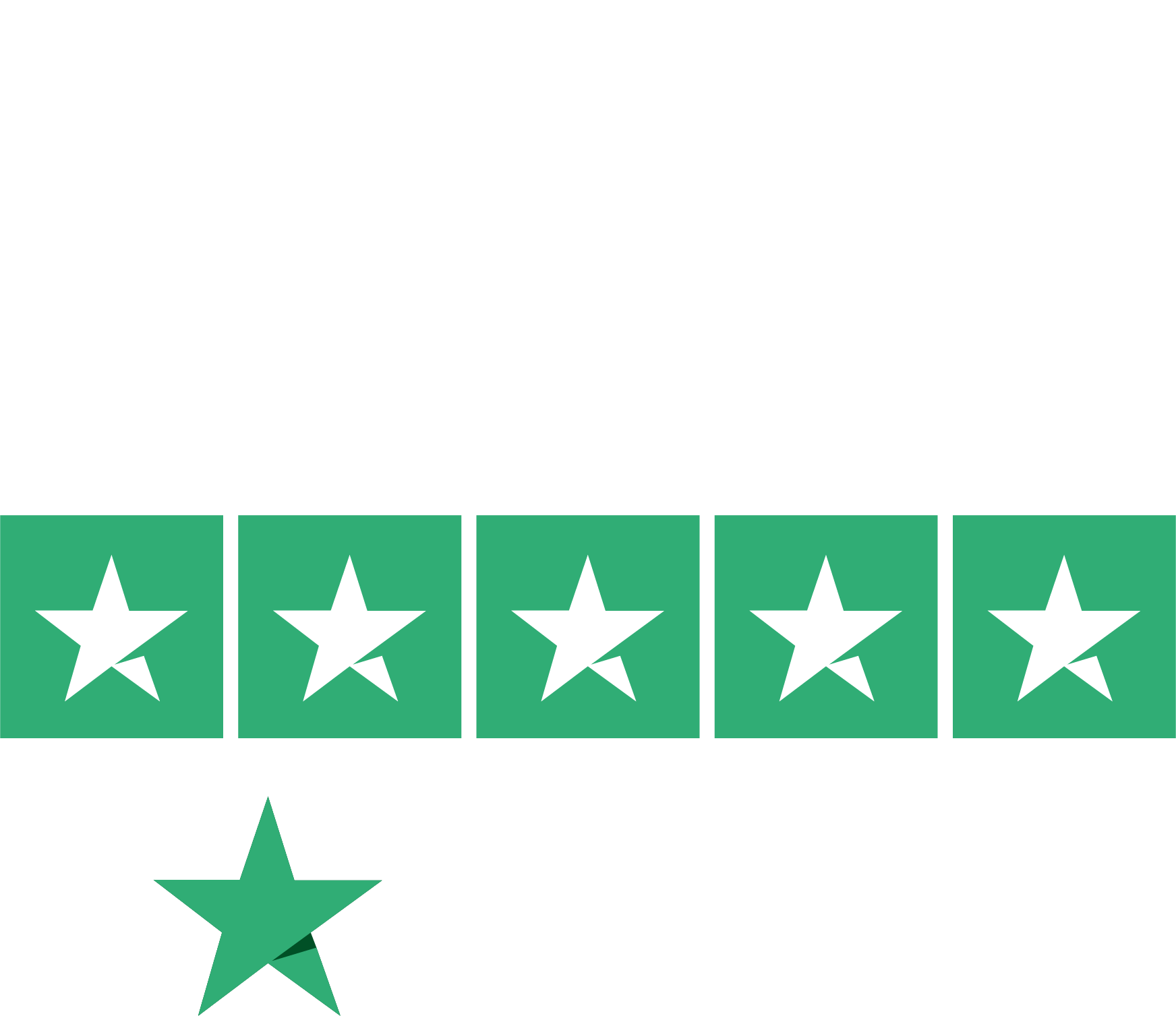Titolo universitario
La più grande facoltà di infermieristica del mondo"
Presentazione
Riconosci i bisogni psicologici, sociali e fisici dei tuoi pazienti con patologie ematologiche grazie a un programma approvato dagli esperti"

I progressi scientifici degli ultimi anni sono riusciti a migliorare le possibilità dei bambini affetti da patologie ematologiche di ricevere trattamenti più appropriati. Questi progressi sono continui e richiedono una specializzazione e un aggiornamento costanti degli operatori infermieristici che lavorano nelle unità di neonatologia, emergenza, ematologia e terapia intensiva pediatrica, al fine di offrire un'assistenza di qualità e personalizzata ai bambini e alle famiglie che richiedono cure specifiche, avanzate e complesse.
L'assistenza infermieristica ai pazienti pediatrici con una patologia ematologica rappresenta una sfida per loro e per le loro famiglie. Da un lato, per l'importanza della malattia stessa, la sua evoluzione, il trattamento intensivo e specifico richiesto, gli effetti collaterali e le ripercussioni emotive e sociali che ha su di loro. Gli infermieri che si occupano di questi pazienti e delle loro famiglie sono consapevoli della necessità di proseguire gli studi accademici per ottenere un livello di competenza specifico che permetta loro di ampliare l'assistenza clinica per rispondere ai bisogni assistenziali dei pazienti e delle loro famiglie.
IlMaster privato in Infermieristica nel Reparto di Ematologia Pediatrica è unico per molti aspetti, in quanto affronta tematiche specifiche nel trattamento e nella cura di bambini e adolescenti con malattie ematologiche, oltre a fornire supporto alle famiglie che affrontano queste malattie insieme ai bambini. In questo modo, gli studenti acquisiranno le conoscenze e le competenze che consentiranno loro di sviluppare le abilità personali e professionali per affrontare questo tipo di situazioni nei loro ambienti di lavoro.
Il team di docenti è di riconosciuto prestigio e vanta una vasta esperienza in unità di riferimento nazionali e internazionali nel trattamento e nella cura di neonati, bambini e adolescenti affetti da neoplasie ematologiche. Durante lo svolgimento di questo Master Privato, agli studenti verranno fornite conoscenze tecnico-scientifiche e un'assistenza completa, in modo da acquisire le competenze necessarie per la cura dei bambini con patologie ematologiche e delle loro famiglie, tenendo conto delle dimensioni fisiche, psicologiche, emotive, sociali e spirituali.
Un Master privato 100% online che permette allo studente di studiare comodamente, dove e quando vuole. Avrà bisogno solo di un dispositivo con accesso a internet per fare un passo avanti nella sua carriera. Una modalità in linea con i tempi attuali e con tutte le garanzie per la crescita professionale dell’infermiere in un settore molto richiesto.
Distinguiti nel tue ambiente di lavoro sviluppando le competenze professionali e personali per la cura dei bambini con patologie ematologiche"
Questo Master privato in Infermieristica nel Reparto di Ematologia Pediatrica possiede il programma educativo più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del corso sono:
- Lo sviluppo di casi di studio presentati da esperti di Ematologia Pediatrica
- I contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici in base ai quali sono stati concepiti forniscono informazioni scientifiche e pratiche riguardo alle discipline mediche essenziali per l’esercizio della professione
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- La sua speciale enfasi sulle metodologie innovative
- Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale.
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
Impara a conoscere i diversi disturbi emorragici nei neonati seguendo esempi pratici presentati da esperti di ematologia pediatrica"
Il personale docente del programma comprende rinomati professionisti e riconosciuti specialisti appartenenti a prestigiose società e università, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.
La progettazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso. Sarai supportato da un innovativo sistema video interattivo sviluppato da esperti rinomati.
È possibile seguire il programma ovunque e in qualsiasi momento grazie alla modalità 100% online, che ti consentirà di continuare a svolgere il tuo lavoro quotidiano"

Potrai contare sull'aiuto di esperti nel campo dell'ematologia pediatrica per esaminare in modo approfondito la composizione del sangue e le patologie che possono svilupparsi nei bambini"
Programma
Per garantire che gli studenti soddisfino i requisiti dell'infermieristica applicata ai pazienti pediatrici con malattie ematologiche, è stato sviluppato un programma i cui moduli offrono un'ampia prospettiva di questo campo d'azione, da un punto di vista olistico, tollerante, sensibile e focalizzato sull'assicurare i diritti, le convinzioni e i desideri dei suoi pazienti. A partire dal modulo 1, lo studente vedrà ampliate le sue conoscenze, il che gli permetterà di svilupparsi professionalmente, sapendo di poter contare sul supporto di un gruppo di esperti.

Gestire un'assistenza infermieristica volta a soddisfare i bisogni dei pazienti, prevenendo le complicazioni e garantendo una pratica sicura e di qualità”
Modulo 1. Fondamenti di ematologia neonatale e pediatrica
1.1. Ematopoiesi Fetale
1.1.1. Introduzione all’ematopoiesi pre-natale
1.1.2. Ematopoiesi mesoblastiche o megaloblastiche
1.1.3. Fase epatica
1.1.4. Fase splenica
1.1.5. Fase midollare o mieloide
1.2. Neonato in salute
1.2.1. Sviluppo del feto
1.2.2. Cambiamenti alla nascita
1.2.3. Primo mese di vita
1.3. Ematopoiesi post-natale
1.3.1. Concetti generali ematopoiesi post-natale
1.3.2. Tipi di tessuto ematopoietico
1.3.2.1. Tessuto mieloide
1.3.2.2. Tessuto linfoide
1.3.3. Regolazione dell’ematopoiesi. Stimolazione e inibizione
1.3.4. Eritropoiesi
1.3.4.1. Sintesi dell’emoglobina
1.3.4.2. Alterazioni dell’emoglobina
1.3.5. Granulocitopoiesi
1.3.6. Monocitopoiesi
1.3.7. Formazione di piastrine
1.4. Composizione del sangue: emocomponenti
1.4.1. Introduzione alle cellule e al plasma sanguigno
1.4.2. Funzioni del sangue
1.4.3. Componenti del sangue
1.4.3.1. Plasma
1.4.3.2. Parte corpuscolata
1.4.3.2.1. Globuli rossi o eritrociti
1.4.3.2.2. Leucociti
1.4.3.2.2.1. Granulari (neutrofili, eosinofili, basofili)
1.4.3.2.2.2. Non granulari (linfociti, monociti)
1.5. Composizione del sangue: plasma sanguigno
1.5.1. Composizione del plasma sanguigno
1.5.1.1. Proteine del plasma
1.5.1.1.1. Albumine
1.5.1.1.2. Globuline
1.5.1.1.3. Fibrinogeno
1.5.1.1.4. Altri
1.5.2. Funzioni del plasma
1.5.3. Differenze tra plasma e siero
1.6. Gruppi sanguigni
1.6.1. Introduzione
1.6.2. Gruppo antigeno 0-A-B
1.6.2.1. Antigeni A e B: agglutinogeni
1.6.2.2. Determinazione genetica degli agglutiniogeni
1.6.2.3. Agglutinine
1.6.2.4. Processo di agglutinazione nelle reazioni trasfusionali
1.6.2.5. La tipizzazione del sangue
1.6.3. Tipo sanguigno Rh
1.6.3.1. Antigeni Rh
1.6.3.2. Risposta immunitaria all’Rh
1.6.3.3. Eritroblastosi fetale ("malattia emolitica del neonato")
1.7. Sistema inmunitario
1.7.1. Concetti generali di immunologia
1.7.2. Funzioni del sistema immunitario
1.7.3. Organi del sistema immunitario
1.7.3.1. Pelle e mucose
1.7.3.2. Timo
1.7.3.3. Fegato e midollo osseo
1.7.3.4. Milza
1.7.3.5. Gangli linfatici
1.7.4. Il sistema innato o non specifico
1.7.5. Il sistema adattativo o specifico
1.7.6. Elementi umorali nella risposta immunitaria
1.7.6.1. Linfociti T
1.7.6.2. Cellule Natural Killer (NK)
1.7.6.3. Cellule presentatori degli antigeni (antigene HLA, macrofagi, cellule dendritiche, linfociti B)
1.7.6.4. Cellule polimorfonucleari: neutrofili, basofili ed eosinofili
1.8. Fondamenti dell’emostasi
1.8.1. Introduzione
1.8.2. Emostasi primaria
1.8.2.1. Vasi, endotelio e piastrine
1.8.2.2. Fisiologia
1.8.2.2.1. Iniziazione (adesione piastrinica)
1.8.2.2.2. Estensione (attivazione delle piastrine)
1.8.2.2.3. Perpetuazione (aggregazione piastrinica e attività procoagulante)
1.8.3. Emostasi secondaria o coagulazione
1.8.3.1. Fattori di coagulazione
1.8.3.2. Fisiologia
1.8.3.2.1. Via estrinseca
1.8.3.2.2. Via intrinseca
1.8.4. Meccanismi di controllo del processo di coagulazione
1.8.5. Rimozione del coagulo e fibrinolisi
1.8.6. Prove di laboratorio
1.8.6.1. Per la valutazione dell'emostasi primaria
1.8.6.2. Per valutare la coagulazione
1.9. Il bambino sano
1.9.1. Lattante: 1-24 mesi
1.9.2. Fase pre-scolastica
1.9.3. Fase scolastica
1.10. Fase adolescienziale
1.11. Introduzione alle malattie ematologiche in Pediatria
1.11.1. Introduzione
1.11.2. Patologie ematologiche benigne
1.11.2.1. Nel neonato
1.11.2.1.1. Specificità
1.11.2.1.2. Patologie ematologiche più frequenti
1.11.2.1.2.1. Ittero neonatale non fisiologico
1.11.2.1.2.2. Anemia del prematuro
1.11.2.1.2.3. Altre anemie del neonato
1.11.2.1.2.4. Disturbi emorragici
1.11.2.1.2.5. Policitemia
1.11.2.1.2.6. Lo shock neonatale
1.11.2.2. Nel bambino
1.11.2.2.1. Specificità
1.11.2.2.2. Patologie più frequenti
1.11.2.2.2.1. Anemie in pediatria
1.11.2.2.2.2. Emoglobinopatie
1.11.2.2.2.3. Alterazioni della coagulazione e dell’emostasi
1.11.2.2.2.4. Malattie benigne dei granulociti
1.11.2.2.2.5. Immunodeficienze primarie
1.11.2.2.2.6. Insufficienze midollari congenite
1.11.2.2.2.7. Infezioni pìù frequenti
1.11.3. Patologie ematologiche maligne
1.11.3.1. Leucemie
1.11.3.2. Linfomi
1.11.3.2.1. Linfoma di Hodgkin
1.11.3.2.2. Linfoma non di Hodkin
Modulo 2. Patologie ematologiche benigne nei neonati
2.1. Valori ematologici di riferimento nel neonato
2.1.1. Introduzione
2.1.2. Valori di riferimento nell’emocromo del neonato a termine (NAT)
2.1.2.1. Valori di riferimento della serie rossa nel NAT
2.1.2.2. Valori di riferimento della serie bianca nel NAT
2.1.3. Valori di riferimento nella biochimica del NAT
2.1.4. Valori di riferimento per l'emostasi del NAT
2.1.5. Valori di riferimento per l'Emogasanalisi del NAT
2.1.5.1. Emogasanalisi alla nascita
2.1.5.2. Emogasanalisi a 24 ore di vita
2.2. Ittero neonatale non fisiologico e malattia emolitica del neonato
2.2.1. Introduzione
2.2.2. Concetti patogenetici di base
2.2.3. Eziopatogenesi
2.2.3.1. Ittero fisiologico
2.2.3.2. Ittero non fisiologico
2.2.3.3. Ittero dovuto all'incompatibilità del fattore Rh
2.2.3.3.1. Malattia emolitica del neonato
2.2.4. Complicazioni cliniche
2.2.4.1. Encefalopatia bilirubica acuta
2.2.4.2. Encefalopatia cronica o Kernicterus
2.2.5. Diagnosi del neonato con ittero
2.2.5.1. Anamnesi
2.2.5.2. Esame fisico
2.2.5.3. Prove di laboratorio
2.2.6. Trattamento
2.2.6.1. Fototerapia
2.2.6.2. Dissanguamento da trasfusione
2.2.6.3. Terapia farmacologica
2.3. Anemia del prematuro
2.3.1. Definizione di Anemia del Prematuro (AOP)
2.3.1.1. Considerazioni sull’anemia nel Neonato prematuro
2.3.1.2. Caratteristiche del Neonato prematuro
2.3.1.3. Caratteristiche ematologiche del neonato prematuro
2.3.2. Classificazione dell'anemia secondo le settimane di gestazione e settimane di gestazione corrette
2.3.3. Epidemiologia delle anemie nel neonato prematuro
2.3.4. Fisiopatologia e cause più comuni di anemia nel prematuro
2.3.4.1. Anemie legate alla diminuzione della produzione di eritrociti
2.3.4.2. Anemie legate all'aumento della distruzione degli eritrociti
2.3.4.3. Anemie legate alla perdita totale del volume del sangue
2.3.5. Aspetti clinici
2.3.5.1. Generali
2.3.5.2. Legate alla causa
2.3.5.3. Legate all'età gestazionale
2.3.6. Diagnosi
2.3.6.1. Diagnosi prenatale. É possibile?
2.3.6.2. Diagnosi differenziale
2.3.6.3. Esami diagnostici complementari
2.3.6.3.1. Informazioni generali.
2.3.6.3.2. Come realizzare correttamente un emocromo in un neonato pre-maturo?
2.3.7. Trattamento
2.3.7.1. Trattamento trasfusionale
2.3.7.2. Altri trattamenti della causa
2.3.7.2.1. Somministrazione di eritropoietina
2.3.7.2.2. Autotrasfusioni
2.3.8. Evoluzione e prognosi delle anemie nel neonato prematuro
2.4. Altre anemie del neonato e del lattante
2.4.1. Differenze tra anemia fisiologica e non
2.4.2. Differenze fisiopatologiche più importanti tra il neonato prematuro e il neonato a termine
2.4.3. Cause di anemie del neonato e del lattante
2.4.3.1. Emorragiche
2.4.3.2. Emolitiche
2.4.3.3. Ipoplastiche
2.4.4. Caratteristiche delle anemie ipoplastiche
2.4.4.1. Anemia ipoplastica fisiologica
2.4.4.2. Anemie Ipoplastiche congenite
2.4.4.2.1. Diamond-Blackfan
2.4.4.2.2. Anemia di Fanconi
2.4.4.2.3. Diseritropoietica
2.4.4.2.4. Aplasia Idiopatica
2.4.4.2.5. Estren-Dameshek
2.4.4.3. Anemia aplastica secondaria
2.4.4.3.1. Leucemia congenita
2.4.4.3.2. Infezioni
2.4.4.3.3. Anemie post-trasfusionali
2.4.4.3.4. Altro
2.4.5. Anemia aplastica secondaria
2.4.6. Diagnosi differenziale e test supplementari
2.4.7. Trattamenti e criteri trasfusionali a seconda dell’età (NAT/lattante)
2.4.8. Altri trattamenti: Dissanguamento da trasfusione
2.4.9. Considerazioni sui trattamenti. Nuovi trattamenti.
2.5. Disturbi emorragici del neonato
2.5.1. Introduzione
2.5.2. Aspetti clinici
2.5.3. Eziologia dei disturbi emorragici del neonato
2.5.3.1. Cause acquisite
2.5.3.1.1. Deficit da vitamina K
2.5.3.1.2. Coagulazione intravascolare disseminata (CID)
2.5.3.1.3. Epatopatia
2.5.3.1.4. Ossigenazione da membrana extracorporea (ECMO)
2.5.3.1.5. Altri: deficit di α2 antiplasmina, problemi vascolari, trauma ostetrico, disturbi qualitativi piastrinici, trombopenia acquisita immune e non immune
2.5.3.2. Cause ereditarie
2.5.3.2.1. Deficit congenito, fattori della coagulazione: emofilia, malattia di von Willebrand
2.5.4. Diagnosi del neonato con emorragia
2.5.4.1. Anamnesi
2.5.4.2. Esame fisico
2.5.4.3. Prove di laboratorio
2.5.5. Trattamento dell'emorragia nel neonato
2.6. Policitemia nel neonato
2.6.1. Introduzione
2.6.2. Eziopatogenesi
2.6.2.1. Trasfusione ematica (ipervolemia)
2.6.2.2. Aumento dell'eritropoiesi (normovolemia)
2.6.2.3. Emoconcentrazione per deplezione di volume
2.6.2.4. Altre: fisiologica, sindrome di Beckwith-Wiedemann
2.6.3. Aspetti clinici
2.6.3.1. Manifestazioni neurologiche
2.6.3.2. Manifestazioni ematologiche
2.6.3.3. Manifestazioni cardiache
2.6.3.4. Manifestazioni respiratorie
2.6.3.5. Manifestazioni gastrointestinali
2.6.3.6. Manifestazioni renali e genito-urinarie
2.6.3.7. Manifestazioni dermatologiche
2.6.3.8. Manifestazioni metaboliche
2.6.4. Diagnosi
2.6.5. Trattamento della policitemia nel neonato
2.6.5.1. Misure generali
2.6.5.2. Dissanguamento parziale da trasfusione
2.6.6. Prognosi
2.7. Trombocitopenia nel neonato
2.7.1. Introduzione
2.7.2. Aspetti clinici
2.7.3. Eziologia
2.7.3.1. Trombocitopenie acquisite
2.7.3.1.1. Malattie: epatopatie, emorragia intraventricolare
2.7.3.1.2. Ittero grave
2.7.3.2. Trombocitopenie ereditarie
2.7.3.2.1. Autosomica recessiva: Trombastenia di Glanzmann, sindrome di Bernard-Soulier
2.7.3.2.2. Autosomica dominante: malattia di von Willebrand di tipo piastrinico, sindrome piastrinica di Quebec
2.7.4. Classificazione in funzione del tipo di Trombocitopenia
2.7.4.1. Trombocitopenia immunitaria neonatale: alloimmune o autoimmune
2.7.4.2. Trombocitopenia infettiva neonatale
2.7.4.3. Trombocitopenia neonatale di origine genetica
2.7.4.4. Cause diverse
2.7.5. Diagnosi del neonato con emorragia
2.7.5.1. Anamnesi
2.7.5.2. Esame fisico
2.7.5.3. Prove di laboratorio
2.7.6. Trattamento della trombocitopenia nel neonato
2.8. Lo shock neonatale
2.8.1. Introduzione
2.8.1.1. Basi fisiopatologiche
2.8.1.2. Tipi di shock
2.8.1.3. Fattori di rischio associati allo shock neonatale
2.8.2. Eziologia dello shock neonatale
2.8.3. Aspetti clinici dello shock neonatale
2.8.4. Diagnosi dello shock neonatale
2.8.4.1. Anamnesi
2.8.4.2. Esame fisico
2.8.4.3. Esami diagnostici complementari
2.8.5. Trattamento dello shock neonatale
Modulo 3. Specificità dell'assistenza ai neonati con patologie ematologiche benigne
3.1. Modello di assistenza incentrato sullo sviluppo e sulla famiglia. NIDCAP
3.1.1. Introduzione al modello
3.1.2. Teoria sinattiva
3.1.3. Neurosviluppo e comportamenti del neonato
3.1.4. La famiglia come caregiver primario
3.1.5. Lavoro di Squadra
3.2. Applicazioni del NIDCAP nel neonato
3.2.1. Posizionamento e manipolazione
3.2.2. Metodo canguro
3.2.3. Procedure dolorose
3.2.4. Inclusione della famiglia nell'assistenza
3.3. Adattamento dell'unità neonatale secondo il modello NIDCAP
3.3.1. Controllo dell'illuminazione e dell'acustica
3.3.2. Porte aperte 24 ore su 24
3.3.3. Raggruppamento di procedure e manipolazioni
3.3.4. Progetti fratelli
3.3.5. Ricovero congiunto
3.3.6. "Con te come a casa"
3.4. L’importanza dell’alimentazione e della nutrizione per il neonato
3.4.1. Alimentazione del neonato con patologie ematologiche benigne
3.4.2. Allattamento materno
3.4.3. Banche del latte materno
3.4.4. Allattamento artificiale
3.5. Procedure diagnostiche e di follow-up nel neonato
3.5.1. Anamnesi ed esame dettagliato
3.5.2. Gruppo sanguigno e test di Coombs
3.5.3. Esami del sangue
3.5.4. Bilirrubina transcutanea
3.5.5. Controllo dell’alimentazione e dell’eliminazione
3.5.6. Altre procedure
3.6. Accessi venosi nel neonato
3.6.1. Catetere venoso ombelicale (CVO)
3.6.2. Catetere epicutaneocavale
3.6.3. Catetere venoso centrale tunnellizzato tipo broviac
3.6.4. Linee venose centrali femorali e giugulari
3.6.5. Catetere venoso centrale con inserimento periferico (PICC)
3.6.6. Via venosa periferica
3.7. Trattamenti più comuni nel neonato con patologia ematologica
3.7.1. Profilassi della malattia emorragica
3.7.2. Fototerapia
3.7.3. Immunoglobuline per via endovenosa
3.7.4. Sieroalbumina
3.7.5. Dissanguamento da trasfusione
3.7.6. Trattamenti Complementari
3.7.7 Metaloporfirine
3.8. Assistenza infermieristica specifica nel trattamento del neonato con ittero neonatale non fisiologico
3.8.1. Quadro teorico
3.8.1.1. Assistenza infermieristica basata nel modello di Virginia Henderson
3.8.2. Assistenza infermieristica a neonati con ittero neonatale non fisiologico
3.8.2.1. Assistenza infermieristica relazionata con la fototerapia
3.8.2.2. Assistenza infermieristica relazionata con il dissanguamento da trasfusione
3.8.2.3. Assistenza infermieristica relazionata con il trattamento farmacologico
3.8.3. Fasi del processo infermieristico
3.8.3.1. Valutazione
3.8.3.2. Screening dei problemi. Diagnosi
3.8.3.3. Pianificazione NOC
3.8.3.4. Implementazione NIC
3.8.3.5. Valutazione
Modulo 4. Patologie ematologiche benigne nei bambini
4.1. Anemie in pediatria I:
4.1.1. Introduzione. Concetti
4.1.2. Fisiopatologia generale delle anemie in pediatria
4.1.3. Classificazione delle anemie
4.1.3.1. Morfologiche
4.1.3.2. Fisiopatologiche
4.1.3.3. Di instaurazione
4.1.4. Prevalenza e incidenza delle anemia in pediatria
4.1.5. Segni e sintomi ienerale
4.1.6. Diagnosi differenziale a seconda del tipo di anemia
4.1.7. Anemia ferropenica
4.2. Anemie in pediatria II:
4.2.1. Anemia microcitica
4.2.1.1. Ferropenica
4.2.1.2. Talassemia
4.2.1.3. Malattia infiammatoria cronica
4.2.1.4. Altre
4.2.1.4.1. Anemia da carenza di rame
4.2.1.4.2. Anemia da intossicazione
4.2.1.4.3. Altre anemie
4.2.2. Anemia normocitica
4.2.2.1. Definizione e possibili cause
4.2.2.1.1. Aplasia/Ipoplasia del midollo osseo
4.2.2.1.2. Sindrome emofagocitica
4.2.3. Anemia macrocitica
4.2.3.1. Anemia da carenza di vitamina B12
4.2.3.2. Anemia da carenza di acido folico
4.2.3.3. Sindrome di Lesch-Nyhan
4.2.3.4. Insufficienza del midollo osseo
4.2.4. Disturbi emolitici
4.2.4.1. Emoglobinopatie
4.2.4.2. Enzimopatie
4.2.4.3. Anemia emolitica immunitaria
4.2.4.4. Fattori estrinsechi
4.2.4.4.1. La malattia di Wilson
4.2.4.4.2. Sindrome emolitica uremica
4.2.4.4.3. Porpora trombotica trombocitopenica
4.2.4.4.4. Coagulazione intravascolare disseminata
4.3. Emoglobinopatie: drepanocitosi e talassemie
4.3.1. Emoglobinopatie quantitative: talassemie
4.3.1.1. Definizione
4.3.1.2. Fisiopatologia
4.3.1.3. Aspetti Clinici Talasemia Maggiore o di Cooley
4.3.1.4. Trattamento
4.3.1.4.1. Ipertensione e chelanti ferrici
4.3.1.4.2. TPH allogenico
4.3.2. Emoglobinopatie qualitative: drepanocitosi
4.3.2.1. Definizione
4.3.2.2. Aspetti clinici
4.3.2.2.1. Anemia emolitica, vascolarizzazione e danni cronici agli organi
4.3.2.2.2. Crisi veno-occlusive
4.3.2.2.3. Infezioni
4.3.2.2.4. Altre
4.3.2.3. Trattamento
4.3.2.3.1. Del dolore
4.3.2.3.2. Di emergenza
4.3.2.3.3. Interventi chirurgici
4.3.2.3.4. TPH allogenico
4.4. Alterazioni della coagulazione e dell’emostasi in pediatria
4.4.1. Trombocitopenia
4.4.1.1. Concetto
4.4.1.2. Trombocitopenia Immune Primaria (IDP)
4.4.1.2.1. Definizione
4.4.1.2.2. Eziologia
4.4.1.2.3. Aspetti clinici
4.4.1.2.4. Trattamento
4.4.1.2.4.1. Corticoidi e immunoglobine endovenose
4.4.1.2.4.2. IG anti-D, crisoterapia
4.4.1.2.4.3. Splenectomia, agonisti recettori di trombopoietina, rituximab
4.4.1.2.4.4. In base a che sia acuta o cronica
4.4.2. Emofilia A e B
4.4.2.1. Eziologia
4.4.2.2. Aspetti clinici
4.4.2.3. Trattamento
4.4.2.3.1. Concentrato plasmatico inattivato o ricombinante
4.4.2.3.2. Desmopressina
4.4.2.3.3. Specificità di vaccinazioni e sport
4.4.3. Malattia di von Willebrand (MVW)
4.4.3.1. Definizione
4.4.3.2. Eziologia
4.4.3.3. Aspetti clinici
4.4.3.4. Trattamento
4.5. Malattie benigne dei granulociti
4.5.1. Neutropenia
4.5.1.1. Classificazione
4.5.1.2. Neutropenia congenita grave
4.5.1.2.1. Segni e sintomi
4.5.1.2.2. Epidemiologia
4.5.1.2.3. Diagnosi
4.5.1.2.4. Trattamento
4.5.1.2.5. Complicazioni
4.5.2. Difetti congeniti della funzione fagocitaria
4.5.2.1. Caratteristiche cliniche
4.5.2.2. Prevalenza
4.5.2.3. Diagnosi e consigli genetici
4.5.2.4. Trattamento
4.6. Immunodeficienze primarie
4.6.1. Introduzione alle Immunodeficienze Primarie (IDP)
4.6.2. Aspetti clinici delle IDP
4.6.3. Diagnosi delle IDP
4.6.4. Tipologie di IDP
4.6.5. Trattamento delle IDP
4.7. Insufficienze midollari congenite (IMC)
4.7.1. Concetto
4.7.2. Classificazione
4.7.2.1. IMC globali
4.7.2.1.1. Definizione
4.7.2.1.2. Anemia di Fanconi
4.7.2.1.3. Sindrome di Shwachman-Diamond
4.7.2.1.3.1. Introduzione
4.7.2.1.3.2. Aspetti clinici
4.7.2.1.3.3. Trattamento
4.7.2.2. IMC isolate
4.7.2.2.1. Anemia di Blackfan-Diamond
4.7.2.2.1.1. Definizione
4.7.2.2.1.2. Aspetti clinici
4.7.2.2.1.3. Trattamento
4.8. Insufficienze midollari congenite: anemia di Fanconi
4.8.1. Definizione
4.8.2. Differenza tra Anemia di Fanconi e Sindrome di Fanconi
4.8.3. Caratteristiche dell’Anemia di Fanconi
4.8.4. Diagnosi
4.8.4.1. Sospetto
4.8.4.1.1. Fratello con anemia di Fanconi diagnosticata
4.8.4.1.2. Insorgere di anemia aplastica o difetto midollare
4.8.4.1.3. Insorgere di mielodisplasia o leucemia
4.8.4.2. Test
4.8.4.2.1. Diagnosi prenatale
4.8.4.2.2. Ecografia
4.8.4.2.3. Analisi citometrica del flusso
4.8.4.2.4. Conteggio del sangue
4.8.4.2.5. Aspirazione del midollo osseo (AMO) e biopsia del midollo osseo
4.8.4.2.6. Altro
4.8.5. Trattamento
4.8.5.1. Di supporto
4.8.5.1.1. Derivati androgenici
4.8.5.1.2. Fattori di crescita
4.8.5.1.3. Trasfusioni sanguigne
4.8.5.2. Guarigione
4.8.5.2.1. Trapianto di cellule staminali ematopoietiche in pediatria
4.8.5.2.2. Terapia genica
4.8.6. Prognosi
4.9. Infezioni più comuni nel paziente pediatrico con patologia ematologica
4.9.1. Fattori che predispongono alle infezioni
4.9.2. Prevenzione di infezioni
4.9.3. Infezioni pìù frequenti
4.9.3.1. Neutropenia febbrile
4.9.3.2. Batteriemia
4.9.3.3. Sepsi e shock settico
4.9.3.4. Infezioni respiratorie:
4.9.3.5. Infezioni digestive
4.9.3.6. Infezioni del SNC
4.9.3.7. Infezioni da organismi multi-resistenti
4.9.3.8. Infezioni virali
Modulo 5. Patologia ematologica maligna in pediatria
5.1. Epidemiologia e fisiopatologia del tumore ematologico in pediatria
5.1.1. Epidemiologia del tumore ematologico in Pediatria
5.1.1.1. Informazioni generali
5.1.1.2. Leucemia linfoblastica acuta
5.1.1.3. Linfoma di Hodgkin
5.1.1.4. Linfoma non di Hodgkin
5.1.2. Fisiopatologia del cancro in pediatria
5.1.2.1. Potenziale di replica illimitato
5.1.2.2. Espansione clonale
5.1.2.3. Differenziazione aberrante
5.1.2.4. Evasione per apoptosi
5.2. Leucemia linfoblastica acuta a cellule B (LLA-B) a rischio standard o intermedio in pediatria
5.2.1. Introduzione
5.2.2. Aspetti clinici
5.2.3. Diagnosi
5.2.4. Trattamento
5.3. LLA-B ad alto rischio e LLA-T in pediatria
5.3.1. LLA-B ad alto rischio
5.3.1.1. Introduzione
5.3.1.2. Aspetti clinici
5.3.1.3. Diagnosi
5.3.1.4. Trattamento
5.3.2. LLA-T
5.3.2.1. Introduzione
5.3.2.2. Aspetti clinici
5.3.2.3. Diagnosi
5.3.2.4. Trattamento
5.4. Leucemia nel lattante (leucemia infantile)
5.4.1. Introduzione
5.4.2. Alterazioni cromosomiche
5.4.3. Caratteristiche cliniche
5.4.5. Approcci terapeutici
5.4.6. Sopravvivenza
5.5. Leucemia mieloide acuta infantile
5.5.1. Leucemie mieloidi acute in pediatria
5.5.1.1. Associazione con altre sindromi
5.5.1.2. Stratificazione a seconda del gruppo di rischio
5.5.2. Leucemia Promielocitica Acuta in Pediatria (LLA o LMA L3)
5.5.2.1. Morfologia
5.5.2.2. Traslocazioni
5.5.2.3. Coagulopatia caratteristica
5.5.2.4. Trattamento
5.5.2.5. Controlli
5.6. Altre Leucemie e sindromi mielodisplastiche in pediatria
5.6.1. Leucemia mieloide cronica
5.6.1.1. Aspetti clinici
5.6.1.2. Trattamento
5.6.2. Leucemia Mielomonocitica Giovanile (LMMG)
5.6.2.1. Definizione
5.6.2.2. Aspetti clinici
5.6.2.3. Trattamento
5.6.2.4. Nuove terapie:
5.6.2.5. Sindrome mielodisplasica
5.7. Linfoma di Hodgkin in pediatria
5.7.1. Introduzione
5.7.2. Aspetti clinici
5.7.3. Diagnosi e stadiazione
5.7.4. Trattamento
5.7.5. Prognosi
5.8. Linfoma non di Hodgkin in pediatria
5.8.1. Introduzione
5.8.2. Classificazione
5.8.3. Aspetti clinici
5.8.4. Diagnosi e stadiazione
5.8.5. Trattamento
5.9. Linfoma di Burkitt
5.9.1. Caratteristiche specifiche
5.9.2. Forme di presentazione
5.9.3. Aspetti clinici
5.9.4. Diagnosi
5.9.5. Trattamento
5.10. Istiocitosi maligna
5.10.1. Istiocitosi delle cellule di Langerhans (HCL)
5.10.1.1. Aspetti clinici
5.10.1.2. Diagnosi
5.10.1.3. Trattamento
5.10.2. Linfoistiocitosi emofagocitica
5.10.2.1. Diagnosi
5.10.2.2. Trattamento
Modulo 6. Trattamento farmacologico e assistenza infermieristica nei bambini con patologie ematologiche
6.1. Cateteri venosi centrali e periferici. Cure infermieristiche
6.1.1. Introduzione
6.1.2. Scelta del catetere
6.1.3. Accessi venosi periferici
6.1.4. Accessi venosi centrali
6.2. Il grande alleato: il serbatoio sottocutaneo. Gli aspetti più importanti della sua cura
6.2.1. Introduzione
6.2.2. Indicazioni per il posizionamento
6.2.3. Vantaggi e svantaggi
6.2.4. Impianto
6.2.5. Ritiro
6.3. Principi generali di somministrazione dei farmaci in pediatria
6.3.1. Sicurezza della somministrazione di farmaci in pediatria ematologica
6.3.2. Vie di somministrazione e cura
6.3.3. Registro della somministrazione del farmaco
6.3.4. Principali farmaci di supporto al trattamento
6.4. I trattamenti più importanti nei pazienti con immunodeficienze
6.4.1. Misure generali
6.4.2. Trattamento profilattico e/o sintomatico
6.4.3. Trattamento sostitutivo
6.4.4. Trattamento curativo
6.5. Trattamento antineoplastico (I)
6.5.1. Fondamenti della chemioterapia
6.5.2. Indicazioni della chemioterapia
6.5.3. Criteri di risposta al trattamento
6.5.4. Resistenza ai farmaci
6.5.6. Modalità di somministrazione della chemioterapia
6.5.7. Interazione della chemioterapia con altri farmaci
6.5.8. Regimi chemioterapici
6.5.9. Intensità della dose
6.6. Trattamento antineoplastico (II)
6.6.1. Agenti antineoplastici più comunemente utilizzati in Ematologia Pediatrica
6.6.2. Agenti chemioprotettivi
6.6.3. Effetti collaterali a breve e medio termine
6.7. Somministrazione di farmaci antineoplastici. Attenzioni più importanti
6.7.1. Misure generali nella somministrazione di citostatici
6.7.2. Prevenzione dei rischi nella somministrazione di citostatici
6.7.2.1. Circuito di sicurezza
6.7.2.2. Ricezione e stoccaggio dei farmaci
6.7.2.3. Doppia convalida delle misure farmacologiche e non farmacologiche prima dell'infusione del farmaco
6.7.2.4. Doppia validazione dell'agente antineoplastico
6.7.2.5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
6.7.2.6. Corroborazione dei farmaci al letto del paziente
6.7.3. Assistenza infermieristica in base alla via di somministrazione
6.7.3.1. Assistenza infermieristica per la somministrazione orale
6.7.3.2. Assistenza infermieristica con somministrazione intramuscolare
6.7.3.3. Assistenza infermieristica per la somministrazione intratecale
6.7.3.4. Assistenza infermieristica per la somministrazione intra-arteriosa
6.7.4. Azione infermieristica in caso di fuoriuscita di citostatici
6.8. Somministrazione di farmaci antineoplastici. Attenzioni più importanti
6.8.1. Agenti irritanti e tossicità degli agenti antineoplastici
6.8.2. Assistenza pre, intra e post somministrazione
6.8.3. Gestione delle complicazioni
6.9. Supporto emoterapico in pediatria. Assistenza più rilevante
6.9.1. Prodotti del sangue
6.9.1.1. Sangue intero
6.9.1.2. Concentrazione di globuli rossi
6.9.1.3. Concentrato di piastrine
6.9.1.4. Plasma fresco
6.9.2. Irradiazione e lavaggio dei prodotti
6.9.3. Indicazioni e dosaggio delle trasfusioni
6.9.4. Richiesta
6.9.4.1. Documentazione
6.9.4.2. Campione per test incrociati
6.9.5. Somministrazione di emoderivati
6.9.6. Reazioni avverse
6.9.7. Sicurezza trasfusionale
Modulo 7. Assistenza infermieristica a bambini/adolescenti con gravi malattie ematologiche e alle loro famiglie
7.1. "Prendersi cura con cura" del bambino/adolescente e della sua famiglia
7.1.1. La fragilità e la vulnerabilità
7.1.1.1. Delle persone di cui ci prendiamo cura
7.1.1.2. Dei professionisti del settore infermieristico
7.1.2. Simpatia, empatia e compassione
7.1.2.1. Delle persone di cui ci prendiamo cura
7.1.2.2. Dei professionisti del settore infermieristico
7.1.3. Bioetica e pediatria
7.1.3.1. Il paternalismo in pediatria
7.1.3.2. Il problema dell'autonomia dei minori
7.1.3.3. Assenso e consenso informato nei minori
7.1.3.4. L'autonomia nell'adolescenza e nel bambino maturo
7.1.3.5. Capacità giuridica del minore
7.1.3.6. Accesso dei genitori alle cartelle cliniche
7.1.3.7. Il Comitato etico per l'assistenza sanitaria (CEA)
7.1.3.8. L'infermieristica come garanzia etica
7.2. La sicurezza come priorità in ematologia pediatrica
7.2.1. Perché e per cosa?
7.2.2. Professionisti coinvolti
7.2.3. Priorità di sicurezza
7.2.4. Assistenza basata sull'evidenza
7.2.5. Sicurezza nell'unità di Ematologia pediatrica
7.3. La sicurezza nell'unità di ematologia pediatrica
7.3.1. L'esordio del bambino e dell'adolescente con malattia ematologica grave
7.3.2. Assistenza nell'unità di emergenza pediatrica
7.3.3. Assistenza nel reparto di degenza
7.4. Osservazione e ascolto attivo in ematologia pediatrica
7.4.1. Differenze tra vedere, guardare e osservare
7.4.2. Obiettivi dell'osservazione attiva
7.4.3. Tempi di osservazione in ematologia pediatrica
7.4.3.1. Osservazione del bambino
7.4.3.2. Osservazione della famiglia
7.4.4. Ostacoli e difficoltà
7.5. Valutazione e diagnosi infermieristiche in Ematologia Pediatrica
7.5.1. Basi della valutazione infermieristica
7.5.1.1. Processo pianificato, sistematico, continuo, deliberativo, intenzionale
7.5.1.2. Obiettivi della valutazione
7.5.1.3. Tipi di valutazione in base agli obiettivi
7.5.1.4. Valutazione generale
7.5.1.5. Valutazione mirata
7.5.2. Fasi del processo di valutazione infermieristica
7.5.2.1. Raccolta di dati
7.5.2.2. Valutazione delle informazioni
7.5.2.3. Valutazione standardizzata in ematologia pediatrica
7.5.3. Individuazione dei problemi in ematologia pediatrica
7.5.4. Problemi di interdipendenza in ematologia pediatrica
7.5.5. Diagnosi infermieristiche più frequenti in Ematologia Pediatrica in base alla situazione
7.6. Assistenza infermieristica nel controllo dei sintomi in ematologia pediatrica
7.6.1. Principi generali del controllo dei sintomi
7.6.2. Valutazione dei sintomi
7.6.3. Atteggiamento emotivo variabile
7.6.4. Irritabilità
7.6.5. Dolore fisico
7.6.6. Derivati della mielosoppressione
7.6.7. Anoressia
7.6.8. Nausea e vomito
7.6.9. Digestivo
7.6.10. Alopecia
7.6.11. Sindrome di Cushing
7.6.12. Cistite emorragica
7.6.13. Polmonite
7.6.14. Disturbi oculari e di altri organi sensoriali
7.6.15. Alterazioni neurologiche
7.7. Cura della pelle nei pazienti pediatrici con gravi malattie ematologiche
7.7.1. Introduzione
7.7.2. Trattamento generale della pelle
7.7.2.1. Esposizione al sole
7.7.2.2. Abbigliamento
7.7.2.3. Igiene e idratazione
7.7.2.4. Unghie
7.7.2.5. Cambiamenti posturali
7.7.3. I disturbi più comuni. Prevenzione, valutazione, trattamento
7.7.3.1. Alopecia
7.7.3.2. Irsutismo
7.7.3.3. Dermatite esfoliativa o eritrodisestesia palmoplantare
7.7.3.4. Prurito
7.7.3.5. Smagliature
7.7.3.6. Ulcerazioni
7.7.3.7. Dermatosi perianali e genitali
7.7.3.8. Mucosite
7.7.3.9. Relative ai dispositivi terapeutici
7.8. Alimentazione nei bambini con neoplasie ematologiche
7.8.1. Importanza dell'alimentazione nell'infanzia
7.8.2. Esigenze particolari del bambino con patologia ematologica grave
7.8.3. Effetti collaterali del trattamento in bambini con gravi malattie ematologiche
7.8.4. Adattamento della dieta nei bambini con gravi malattie ematologiche
7.8.5. Supporto nutritivo
7.8.6. Adattamento della dieta nelle complicazioni
7.8.7. Altre terapie nutrizionali combinate
7.8.8. Adattamento di ricette/consigli per rendere il cibo più appetibile
7.9. Esecuzione di test diagnostici. Cure infermieristiche
7.9.1. Informazioni al paziente e alla famiglia
7.9.2. Coordinamento dei professionisti
7.9.3. Preparazione del paziente
7.9.4. Attenzione durante il test
7.9.5. Accoglienza del paziente
7.9.6. Assistenza specifica durante le ore successive
7.10. Consultazione infermieristica del paziente pediatrico con malattia ematologica benigna. Cure specifiche
7.10.1. Introduzione
7.10.2. Supporto diagnostico
7.10.3. Valutazione socio-familiare e qualità della vita
7.10.4. Misure preventive di educazione
7.10.5. Aderenza al trattamento
7.10.6. Passaggio all'unità per adulti
7.11. Ricerca in Ematologia Pediatrica
7.11.1. Infermieristica basata sulle evidenze (IBE)
7.11.1.1. I pilastri dell'IBE
7.11.1.2. Fasi e modelli dell'IBE
7.11.1.3. Formulazione della domanda
7.11.1.4. Ricerca di prove
7.11.1.5. Lettura critica
7.11.1.6. Attuazione e valutazione
7.11.2. Metodologie di ricerca
7.11.3. Innovazione nell'assistenza
7.11.4. Dove stiamo andando?
Modulo 8. Tutti insieme e in squadra
8.1. Assistenza infermieristica nel dipartimento di emergenza in pazienti pediatrici con patologia ematologica
8.1.1. Definizione di emergenza nel bambino con grave patologia ematologica
8.1.2. Le emergenze più comuni nei bambini con malattie ematologiche gravi
8.1.2.1. Secondo l'eziologia
8.1.2.2. In base agli organi colpiti
8.1.3. Motivi più frequenti di ammissione al pronto soccorso di bambini con gravi patologie ematologiche
8.1.4. Interventi nelle emergenze più comuni
8.1.4.1. Iperleucocitosi
8.1.4.2. Neutropenia febbrile
8.1.4.3. Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria (IRIS)
8.1.4.4. Sindrome da rilascio di citochine
8.1.4.5. Dolore intenso
8.1.4.6. Tossicità acuta da metotrexato
8.1.4.7. Reazioni da trasfusione
8.1.4.8. Fuoriuscite
8.1.4.9. Effetti collaterali della chemioterapia intratecale
8.1.5. Gestione dell'ossigenoterapia, della fluidoterapia, dei principali farmaci e dispositivi elettromedicali e somministrazione di farmaci propri
8.1.6. Risposta alle emergenze
8.1.7. Il carrello per arresti cardio-respiratori
8.1.8. Preparazione del team di assistenza
8.1.9. Comunicazione con la famiglia e il bambino/adolescente
8.2. Assistenza infermieristica al paziente pediatrico con malattia ematologica e famiglia, ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (I)
8.2.1. Valutazione iniziale del paziente in Unità di Terapia Intensiva Pediatrica
8.2.2. Complicanze comuni che richiedono una terapia intensiva
8.2.2.1. Complicanze legate alla malattia di base e al suo trattamento
8.2.2.1.1. Insufficienza respiratoria
8.2.2.1.2. Alterazioni cardiache
8.2.2.1.3. Alterazioni del sistema ematologico
8.2.2.1.4. Insufficienza renale acuta
8.2.2.1.5. Alterazioni metaboliche
8.2.2.1.6. Tossicità epatica
8.2.2.2. Complicanze postoperatorie in neurochirurgia
8.2.3. Assistenza infermieristica di base nel paziente pediatrico ricoverato in Terapia Intensiva
8.2.4. Aspetti nutrizionali del paziente in Terapia Intensiva
8.2.5. Situazioni particolari nel paziente oncologico
8.2.5.1. Paziente che necessita di terapia sostitutiva renale continua (CRRT)
8.2.5.2. Paziente in ventilazione meccanica ad alta frequenza (HFMV)
8.3. Assistenza infermieristica al paziente pediatrico con malattia ematologica e famiglia, ricoverato in Terapia Intensiva (II)
8.3.1. Assistenza iniziale completa alla famiglia del paziente ematologico ricoverato in Terapia Intensiva Pediatrica
8.3.2. Aspetti psicologici nei bambini con patologia ematologica che necessitano di terapia intensiva
8.3.2.1. Gestione del dolore
8.3.2.2. Ansia da trattamento
8.3.2.3. Paura della morte
8.3.3. Il lutto nel paziente oncologico ricoverato in Unità di Terapia Intensiva Pediatrica
8.3.4. Situazioni particolari del paziente oncologico ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva Pediatrica
8.3.4.1. Comunicazione con il paziente oncologico in ventilazione meccanica
8.3.4.2. Riabilitazione (fisioterapia respiratoria e motoria)
8.3.5. Informazioni mediche e comunicazione tra team di cura e unità familiare
8.3.6. Assistenza al paziente oncologico nel fine vita
8.4. Unità di terapia intensiva pediatrica (UTIP). Progetti di umanizzazione
8.4.1. Criteri generali per il ricovero dei pazienti ematologici in UTIP
8.4.2. Ripercussioni familiari del ricovero in UTIP
8.4.3. Visione umanistica dell'assistenza critica
8.4.4. Modello di assistenza: assistenza incentrata sulla famiglia
8.4.4.1. Potenziamento della famiglia
8.4.4.2. Benessere emotivo
8.4.5. Caratteristiche dell'équipe di assistenza in una UTIP umana
8.4.6. Strategie di umanizzazione in una UTIP a porte aperte
8.5. Sostegno psicologico del bambino con grave patologia ematologica
8.5.1. Fase di sviluppo dell'infanzia
8.5.2. Il bambino con malattia ematologica grave
8.5.2.1. Caratteristiche specifiche
8.5.2.2. Assistenza psicologica per bambini e famiglie
8.5.2.2.1. Aspetti generali
8.5.2.2.2. In base allo stadio della malattia
8.5.3. Sopravvissuti a una neoplasia ematologica infantile e qualità della vita
8.5.4. La morte nell'infanzia
8.5.4.1. Cure palliative
8.5.4.2. Lutto
8.6. Sostegno psicologico per l'adolescente durante il processo di convivenza con una malattia ematologica grave
8.6.1. Fase di sviluppo dell'adolescenza
8.6.2. L'adolescente con malattia ematologica grave
8.6.2.1. Caratteristiche specifiche dell'adolescente con grave malattia ematologica
8.6.2.2. Assistenza psicologica nelle fasi della malattia
8.6.2.2.1. Diagnosi
8.6.2.2.2. Trattamento
8.6.2.2.3. Post trattamento
8.6.3. Adolescenti sopravvissuti e qualità della vita
8.6.4. La morte nell'adolescenza
8.7. Continuità educativa nei bambini e negli adolescenti con patologia ematologica
8.7.1. L'assistenza educativa come diritto, principi dell'assistenza educativa per gli alunni con malattie
8.7.2. Requisiti e procedure
8.7.3. Copertura accademica durante il processo di malattia
8.7.3.1. In ospedale. Aule ospedaliere (AAHH)
8.7.3.2. Servizio di supporto educativo a domicilio
8.8. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e umanizzazione
8.8.1. Uso delle TIC e E-health per i genitori
8.8.1.1. Decalogo per il buon uso delle TIC
8.8.1.2. Le TIC come metodo di distrazione e sollievo dal dolore e dall'ansia nei bambini e negli adolescenti
8.8.1.3. Le TIC come metodo di comunicazione e apprendimento
8.8.2. Uso delle TIC e sanità elettronica per i genitori
8.8.2.1. Esigenze di informazione
8.8.2.2. Esigenze di comunicazione
8.8.2.3. Sviluppo e prescrizione di app e pagine web per l'oncologia pediatrica
8.8.2.4. Utilizzo dei social network
8.8.3. Uso delle TIC e della sanità elettronica da parte degli operatori sanitari
8.8.3.1. Nuove tecnologie e nuove sfide per gli infermieri
8.8.3.2. Applicazione delle nuove tecnologie nell'assistenza sanitaria
8.8.3.3. Applicazioni utili per i professionisti dell'assistenza infermieristica in ematologia pediatrica
8.8.3.4. Applicazioni delle TIC nella sanità del futuro
Modulo 9. Verso una cura: Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche in pediatria
9.1. Introduzione e indicazioni per il Trapianto Allogenico di Cellule Staminali Ematopoietiche (HSCT)
9.1.1. Cellule staminali ematopoietici (HSC) e HSCT
9.1.2. Il sistema di istocompatibilità (HLA o MHC)
9.1.3. Anamnesi di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
9.1.4. Tipi di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
9.1.4.1. A seconda del donatore
9.1.4.2. In base alla fonte dei progenitori ematopoietici
9.1.5. Indicazioni per l’HSCT allogenico
9.1.5.1. Pazienti con neoplasie ematologiche maligne
9.1.5.1.1. Leucemie
9.1.5.1.2. Sindrome mielodisplasica
9.1.5.1.3. Linfomi
9.1.5.2. Pazienti con patologie benigne
9.1.5.2.1. Alterazioni degli eritrociti
9.1.5.2.2. Immunodeficienze primarie
9.1.5.2.3. Insufficienze midollari congenite
9.1.5.2.4. Altro
9.2. Dalla selezione dei donatori all'infusione delle cellule staminali ematopoietiche (HSC)
9.2.1. Selezione degli donatore
9.2.1.1. Donatori consanguinei
9.2.1.2. Ricerca di donatori non consanguinei
9.2.1.3. Selezione del donatore
9.2.2. Tecniche di raccolta delle HSC
9.2.2.1. Raccolta e manipolazione delle cellule staminali del sangue cordonale
9.2.2.2. Mobilitazione e raccolta di cellule staminali del sangue periferico
9.2.2.3. Ottenimento di cellule staminali del midollo osseo mediante aspirazione diretta
9.2.3. Trasporto delle HSC (dall'ospedale di origine all'ospedale ricevente)
9.2.3.1. Etichettatura dei sacchi
9.2.3.2. Etichettatura del contenitore
9.2.3.3. Documentazione
9.2.3.4. Temperatura
9.2.4. Manipolazione e conservazione delle HSC
9.2.4.1. Controllo di qualità dell’elaborazione cellulare
9.2.4.2. Manipolazione prima della crioconservazione
9.2.4.3. Crioconservazione
9.2.4.4. Scongelamento
9.2.4.5. Trasporto all'unità dell’HSCT dell'ospedale per l'infusione
9.3. Assistenza infermieristica durante il condizionamento del bambino/adolescente sottoposto ad allo-HSCT
9.3.1. Accoglienza del paziente e della famiglia
9.3.2. Valutazione del paziente
9.3.3. Regimi di condizionamento
9.3.3.1. Irradiazione totale del corpo (TBI)
9.3.3.2. Chemioterapia
9.3.4. Profilassi della malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD)
9.3.4.1. Metotrexato
9.3.4.2. Infliximab e rituximab
9.3.4.3. Ciclosporina
9.3.4.4. Micofenolato
9.3.4.5. ATG
9.3.4.6. Ciclofosfamide
9.3.4.7. Corticosteroidi
9.3.4.8. Immunoglobuline non specifiche
9.3.5. Profilassi della sindrome ostruttiva sinusoidale (SOS)
9.3.6. Profilassi delle infezioni
9.3.6.1. Impostazioni dell'ambiente protetto
9.3.6.2. Dieta a basso contenuto batterico
9.3.6.3. Profilassi farmacologica
9.3.7. Accompagnamento del paziente e della sua famiglia
9.4. Il giorno 0. Infusione delle cellule staminali ematopoietiche
9.4.1. Il giorno 0
9.4.2. Preparazione del paziente
9.4.3. Ricezione delle cellule staminali
9.4.4. Infusione delle cellule staminali
9.4.5. Complicanze potenziali
9.4.6. Cura post-infusione delle cellule staminali
9.4.6.1. Cure del paziente
9.4.6.2. Cure della famiglia
9.5. Fase di aplasia del midollo spinale. Cure infermieristiche
9.5.1. Durate della fase di aplasia del midollo spinale.
9.5.2. Complicanze potenziali della fase di aplasia del midollo spinale
9.5.2.1. Direttamente derivate dal trattamento di condizionamento
9.5.2.2. Prodotte dalla condizione di aplasia
9.5.2.2.1. Infezioni
9.5.2.2.2. Nausea e vomito
9.5.2.2.3. Diarrea
9.5.2.2.4. Mucosite
9.5.2.2.5. Emorragie
9.5.2.2.6. Problemi respiratori
9.5.3. Valutazione e interventi infermieristici
9.6. Assistenza infermieristica a medio termine del bambino/adolescente che ha subito un trapianto e della sua famiglia
9.6.1. Durata della fase post-trapianto a medio termine
9.6.2. Potenziali complicazioni della fase post-trapianto a medio termine
9.6.2.1. Infezioni
9.6.2.2. Malattia del trapianto contro l'ospite
9.6.2.3. Sindrome da impianto e pre-impianto
9.6.2.4. Fallimento dell'impianto/innesto
9.6.2.5. Altre complicazioni
9.6.2.5.1. Cistite emorragica
9.6.2.5.2. Disfunzione renale
9.6.2.5.3. Microangiopatia trombotica
9.6.2.5.4. Sindrome da polmonite idiopatica (IPS)
9.6.2.5.5. Emorragia alveolare diffusa
9.6.3. Valutazione e interventi infermieristici
9.7. Le emergenze più rilevanti nel paziente post-trapianto
9.7.1. Introduzione
9.7.2. Sepsi e shock settico
9.7.3. Mucosite di III-IV grado
9.7.4. Sindrome da impianto
9.7.5. Sindrome da iperpermeabilità capillare (CLS)
9.7.6. GVHD acuta e GVHD cronica
9.7.7. Cistite emorragica
9.7.8. Sindrome ostruttiva sinusoidale del fegato (SOS)
9.7.9. Sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES)
9.7.10. Insufficienza renale acuta
9.7.11. Insufficienza respiratoria post-HSCT
9.7.11.1. Sindrome da polmonite idiopatica (IPS)
9.7.11.2. Emorragia alveolare diffusa (HAD)
9.7.11.3. Polmonite criptogenetica organizzativa (COP)
9.7.11.4. Sindrome da bronchiolite obliterante (BOS)
9.7.12. Microangiopatia trombotica (TMA) post-HSCT
9.7.13. Tossicità Cardiaca
9.7.14. Sindrome da disfunzione multiorgano (SDMO)
9.7.15. Trasferimento all'Unità di Terapia Intensiva
9.8. Visita di follow-up infermieristico del HSCT
9.8.1. Visita di Infermieristica del HSCT
9.8.2. Assistenza infermieristica nella visita pre-trapianto per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche
9.8.2.1. Informazioni sul processo
9.8.2.2. Accoglienza all'Unità dell’HSCT e raccomandazioni di base per il funzionamento
9.8.2.3. Misure antropometriche e segni vitali
9.8.2.4. Analisi del sangue periferico pre-HSCT
9.8.2.5. Presentazione del team multidisciplinare
9.8.2.6. Supporto emotivo per il paziente e la famiglia
9.8.2.7. Risoluzione dei dubbi
9.8.3. Assistenza infermieristica nelle visite di follow-up post-HSCT
9.8.3.1. A breve termine
9.8.3.1.1. Revisione delle informazioni fornite al momento della dimissione dall'ospedale
9.8.3.1.2. Monitoraggio di segnali e sintomi, informazioni sui segnali di allarme, individuazione precoce delle complicanze
9.8.3.1.3. Informazioni sulle misure da adottare per evitare l'infezione: evitare il contatto con persone con sintomi influenzali, evitare gli spazi chiusi affollati
9.8.3.1.4. Raccomandazioni dietetiche e nutrizionali
9.8.3.1.5. Cura e monitoraggio dell'accesso vascolare: PAC, PICC
9.8.3.1.6. Cura e monitoraggio dei dispositivi di supporto nutrizionale: NGLS, bottone gastrico
9.8.3.1.7. Valutazione del dolore
9.8.3.1.8. Valutazione dell'attività
9.8.3.1.9. Educazione sanitaria
9.8.3.1.10. Informazioni sui circuiti del Day Hospital
9.8.3.1.11. Supporto emotivo per il paziente e la famiglia
9.8.3.2. A lungo termine
9.8.3.2.1. Monitoraggio di segnali e sintomi
9.8.3.2.2. Individuazione precoce delle complicanze della tossicità
9.8.3.2.3. Coordinamento con altri specialisti: cardiologia, endocrinologia, traumatologia, ecc.
9.8.3.2.4. Monitoraggio della cronicità: trattamenti sintomatici, supporto emotivo, aderenza al trattamento.
9.8.3.2.5. Follow-up dell'immunizzazione post-HSCT
9.8.3.2.6. Educazione sanitaria su abitudini sane per bambini e adolescenti
9.9. Nuove terapie nel trattamento delle complicanze post allo-HSCT
9.9.1. Infusione di progenitori CD34+ del donatore per il trattamento del fallimento dell'impianto secondario a HSCT allogenico
9.9.1.1. Pazienti candidati
9.9.1.2. Procedura
9.9.2. Fotoferesi extracorporea per il trattamento della GVHD
9.9.2.1. Pazienti candidati
9.9.2.2. Procedura
9.9.3. Infusione di cellule staminali mesenchimali per il trattamento della GVHD
9.9.3.1. Pazienti candidati
9.9.3.2. Procedura
9.9.4. Infusione di linfociti da donatore. Immunoterapia in pazienti con recidiva dopo HSCT allogenico.
9.9.4.1. Pazienti candidati
9.9.4.2. Procedura
Modulo 10. Quando la risposta al trattamento non è adeguata
10.1. Introduzione
10.1.1. Risposta alla malattia
10.1.2. Definizione di sopravvivenza
10.1.3. Definizione di recidiva
10.1.4. Malattie o situazioni con maggiori probabilità di recidive
10.1.5. Opzioni di trattamento
10.1.6. Accogliere e accompagnare la recidiva della malattia
10.1.6.1. I Genitori
10.1.6.1.1. Relazioni emotive
10.1.6.1.2. Coping
10.1.6.2. Reazioni emotive e accettazione della recidiva nei bambini e negli adolescenti
10.2. Concetto, fondamenti e necessità degli studi clinici in Ematologia Pediatrica
10.2.1. Che cos’è uno studio clinico?
10.2.2. Precedenti storici, legislazione ed etica della sperimentazione con i medicinali
10.2.2.1. "Il canone della medicina”. Avicenna (Ibn Sina)
10.2.2.2. Il primo studio clinico della storia. James Lind
10.2.2.3. Sperimentazione con i bambini nel campo di concentramento di Auschwitx (Josef Mengele)
10.2.2.4. Il Codice di Norimberga (1946)
10.2.2.5. Studi clinici eticamente discutibili dopo il Codice di Norimberga
10.2.2.6. Dichiarazione di Helsinki (1964)
10.2.2.7. Linee guida di buona pratica clinica (1995) 10.2.3. Perché sono necessari studi clinici in ematologia pediatrica?
10.2.3. Perché sono necessari studi clinici in ematologia pediatrica?
10.2.3.1. Aumentare la sopravvivenza globale nei pazienti con prognosi infausta
10.2.3.2. Ridurre le sequele a lungo termine
10.3. Progettazione, preparazione e attuazione di uno studio clinico
10.3.1. Progettazione di uno studio clinico
10.3.2. Fasi degli studi clinici
10.3.3. Identificazione e selezione dei centri partecipanti
10.3.4. Farmaci e servizio di farmacia ospedaliera
10.3.5. Laboratori di analisi dei campioni
10.3.6. Aspetti economici della sperimentazione clinica
10.3.7. Archivio
10.4. Conduzione di uno studio clinico aperto in un centro e professionisti coinvolti
10.4.1. Prima visita
10.4.2. Visita di controllo
10.4.3. Visita di chiusura
10.4.4. Dossier del ricercatore
10.4.5. Gestione degli eventi avversi
10.4.6. Farmaci di prova
10.4.7. Selezione dei pazienti
10.4.8. Somministrazione del farmaco di prova, valutazione della malattia e follow-up
10.4.9. Professionisti coinvolti in uno studio clinico
10.4.9.1. Professionisti in ambito ospedaliero
10.4.9.2. Professionisti dell'azienda farmaceutica
10.5. Ruolo del professionista infermieristico negli studi clinici di ematologia pediatrica
10.5.1. Infermiere nel team di sperimentazione clinica in oncoematologia pediatrica
10.5.2. Requisiti di formazione specifici
10.5.2.1. Preparazione sulla buona pratica clinica
10.5.2.2. Preparazione sulla manipolazione e la spedizione di campioni a rischio biologico
10.5.2.3. Preparazione specifica per ogni studio clinico
10.5.3. Responsabilità
10.5.4. Attività delegate di sperimentazione clinica
10.5.4.1. Gestione del materiale
10.5.4.1.1. Fungibile
10.5.4.1.2. Non fungibile
10.5.4.2. Gestione dei campioni del laboratorio locale
10.5.4.3. Gestione dei campioni del laboratorio centrale
10.5.4.4. Tecniche infermieristiche
10.5.4.5. Somministrazione di farmaci
10.5.4.6. Registri delle fonti
10.5.4.7. Registro elettronico di raccolta dati
10.5.5. Cure infermieristiche
10.5.5.1. Assistenza ai bisogni primari
10.5.5.2. Accompagnamento
10.6. Situazione attuale e futuro dell'ematologia pediatrica. Medicina personalizzata.
10.6.1. Scienza e omica
10.6.2. Fondamenti della ricerca traslazionale
10.6.3. Definizione di medicina personalizzata
10.6.4. Tecniche di sequenziamento ad alto rendimento
10.6.5. Analisi dei dati
10.6.6. Biomarcatori
10.6.7. Modelli preclinici
10.7. Introduzione, obiettivi e fasi dell'approccio terapeutico nelle cure palliative pediatriche
10.7.1. Storia delle cure palliative
10.7.2. Difficoltà nell'applicazione delle cure palliative nella popolazione pediatrica. La sfida delle cure palliative pediatriche
10.7.3. Definizione di cure palliative pediatriche
10.7.4. Equipe di assistenza in cure palliative pediatriche
10.7.5. Peculiarità delle cure palliative pediatriche
10.7.6. Principi universali delle cure palliative
10.7.7. Obiettivi dell'approccio palliativo
10.7.8. Stato avanzato della malattia Punto di svolta
10.7.9. Fasi dell'approccio terapeutico
10.7.10. Luogo di cura: in regime di ricovero vs. Domiciliare
10.8. Gestione dei sintomi nelle Cure Palliative in Ematologia Pediatrica (tra cui il dolore)
10.8.1. Diagnosi e valutazione dei risultati
10.8.2. Principi base nello controllo dei sintomi
10.8.3. Sintomi da alleviare
10.8.3.1. Sintomo principale da alleviare: dolore
10.8.3.2. Sintomi generali
10.8.3.3. Sintomi costituzionali
10.8.3.4. Sintomi respiratori
10.8.3.5. Sintomi digestivi
10.8.3.6. Sintomi neurologici
10.8.3.7. Altri sintomi
10.8.4. Prevenzione e trattamento
10.8.4.1. Misure non farmacologiche
10.8.4.2. Misure farmacologiche
10.9 Dolore totale e questioni etiche nelle Cure Palliative Pediatriche
10.9.1. Dolore totale
10.9.1.1. Cicely Saunders
10.9.1.2. Concetto di dolore totale
10.9.1.3. Soglia del dolore
10.9.1.4. Principi di base del trattamento totale del dolore
10.9.1.5. Dolore, sofferenza e morte
10.9.1.6. Ostacoli nella gestione del dolore totale in oncoematologia pediatrica
10.9.1.7. Morire con dignità
10.10 Assistenza infermieristica durante la fase terminale e gli ultimi giorni di vita nelle Cure Palliative Pediatriche
10.10.1. Principi diagnostici della fase terminale
10.10.2. Fase di agonia e fase degli ultimi giorni di vita
10.10.2.1. Concetto
10.10.2.2. Segni ed sintomi della fase di agonia
10.10.2.3. Obiettivi terapeutici
10.10.2.4. Controllo dei sintomi
10.10.2.5. Supporto alla famiglia
10.10.2.6. Sedazione palliativa
10.10.2.7. Adattamento del trattamento farmacologico
10.10.3. Sedazione palliativa
Modulo 11. Accogliere, curare e accompagnare in Ematologia Pediatrica
11.1. Visione integrale della cura del bambino con patologia ematologica e della sua famiglia
11.1.1. Una visione olistica della salute umana
11.1.1.1. Salute fisica
11.1.1.2. Salute mentale
11.1.1.3. Salute emotiva
11.1.1.4. Salute sociale
11.1.1.5. Salute spirituale
11.1.2. Il punto di vista dell'infermiere
11.1.2.1. Emozioni, convinzioni e sviluppo professionale
11.1.2.2. Accoglienza, cura e accompagnamento
11.1.2.3. Modello Biomedico
11.1.2.4. Modello salutistico
11.1.3. Visione sistemica dell'assistenza
11.1.3.1. Coerenza della persona
11.1.3.2. Coerenza del sistema
11.1.3.3. Coerenza dell'"anima"
11.1.4. Accogliere, curare e accompagnare in modo completo
11.1.4.1. Funzioni e competenze infermieristiche
11.1.4.2. Lavoro interdisciplinare dei professionisti
11.1.4.3. Le sfide transdisciplinari del professionista infermieristico
11.2. Teorie e modelli che si avvicinano alla visione integrale dell'assistenza infermieristica
11.2.1. Il modello salutogenico applicato alle cure
11.2.1.1. Fattori del benessere
11.2.1.2. Sviluppo dei fattori personali
11.2.1.3. Sviluppo dei fattori del sistema
11.2.1.4. Sviluppo dei fattori istituzionali
11.2.2. Sviluppo dei fattori personali
11.2.3. Modello di relazione d'aiuto: Hildegarde Peplau
11.2.4. Modelli di Promozione della Salute: Nola Pender
11.2.5. La teoria della diversità e l'universalità della cura: Madeleine Leininger
11.2.6. Teoria dell'assistenza umana: Jean Watson
11.2.7. Teoria del comfort: Katharine Kolkaba
11.2.8. Marie Françoise Colliére. Promuovere la vita
11.3. Ruolo facilitante dell'infermieristica in Ematologia pediatrica
11.3.1. Il ruolo del facilitatore
11.3.2. La prospettiva infermieristica
11.3.3. Facilitare l'assistenza da parte dei diversi ruoli infermieristici
11.3.4. L'umanizzazione delle cure
11.3.5. Gli ordini di aiuto
11.4. Profilo di competenza emotiva degli infermieri in Ematologia Pediatrica
11.4.1. La necessità di promuovere lo sviluppo socio-emotivo dell'infermiere
11.4.2. Modello di competenza emotiva per gli infermieri
11.4.3. Tutto ciò che si può fare con un'emozione
11.4.4. Salute in infermieristica ematologica pediatrica
11.5. La comunicazione terapeutica in ematologia pediatrica
11.5.1. Competenze specifiche di comunicazione efficace e affettiva
11.5.2. Idee chiave in relazione al bambino e alla famiglia
11.5.3. Idee chiave in relazione ai periodi di malattia
11.5.4. Idee chiave in relazione alla pratica intra e interprofessionale
11.6. L'influenza dell'ambiente e dei dintorni nell'accompagnamento del bambino con Patologia Ematologica
11.6.1. Salute sul lavoro e gruppi di lavoro
11.6.2. Architettura degli spazi
11.6.3. Ambiente responsabile con una prospettiva di diritti
11.6.4. Il significato degli spazi
11.7. Accompagnare il sistema familiare in Ematologia Pediatrica
11.7.1. La famiglia come sistema
11.7.2. Prendersi cura della persona che cura il paziente
11.7.3. Accompagnare processi ad alto impatto emotivo
11.7.4. Accompagnamento della crescita
11.7.5. Le difficoltà dell'assistenza
11.7.6. Affrontare la malattia
11.7.7. Accompagnamento sistemico
11.8. Sviluppo psicomotorio e affettivo del neonato e del bambino in età prescolare con patologia ematologica
11.8.1. Accompagnare le caratteristiche specifiche nel neonato
11.8.2. Accompagnare le caratteristiche specifiche nel bambino in età prescolare
11.8.3. Sviluppo psicomotorio e affettivo durante la malattia
11.8.3.1. Sviluppo psicomotorio (salute fisica)
11.8.3.2. Linguaggio e comfort emotivo (salute mentale ed emotiva)
11.8.3.3. La socializzazione (salute sociale)
11.8.3.4. Il significato della vita
11.8.3.4.1. Amore e contatto
11.8.3.4.2. Crescere giocando
11.9. Emozione, narrazione e gioco significativo in bambini in età scolare con Patologia Ematologica
11.9.1. Accompagnare le caratteristiche specifiche del bambino in età scolare
11.9.2. Sviluppo della personalità durante la malattia
11.9.2.1. Coping (salute emotiva)
11.9.2.2. L'importanza della narrazione (salute mentale)
11.9.2.3. La socializzazione (salute sociale)
11.9.3. Il significato della vita
11.9.3.1. Autostima, immagine di sé e concetto di sé
11.9.3.2. Supporto pedagogico
11.9.3.3. Gioco significativo
11.10. Emozioni, narrazione e socializzazione degli adolescenti con patologia ematologica
11.10.1. Accompagnare le caratteristiche specifiche dell'adolescente
11.10.2. Sviluppo della personalità durante la malattia
11.10.2.1. Coping (salute emotiva)
11.10.2.2. L'importanza della narrazione (salute mentale)
11.10.2.3. La socializzazione (salute sociale)
11.10.3. Il significato della vita
11.10.3.1. Autostima, immagine di sé e concetto di sé
11.10.3.2. Supporto pedagogico e sociale
11.10.3.3. Sviluppo affettivo-sessuale

Cogli l'opportunità di conoscere gli ultimi progressi in questo ambito e applicali al tuo lavoro quotidiano"
Master Privato in Infermieristica nel Reparto di Ematologia Pediatrica
Il lavoro degli infermieri pediatrici è vitale per la corretta crescita e lo sviluppo di neonati, bambini e adolescenti. Grazie alla loro assistenza personalizzata in questa fase della vita, è possibile riconoscere i bisogni psicologici, sociali e fisici dei pazienti con patologie del sangue. Per approfondire questo argomento e fornire le basi necessarie per la formazione dei professionisti, in TECH abbiamo progettato un Infermieristica nel Reparto di Ematologia Pediatrica. Un programma di alta qualità che ti permetterà di ottenere una visione completa delle cure e degli aspetti necessari per trattare queste malattie. Durante 1.500 ore di apprendimento ti specializzerai nella fornitura di trattamenti adattati a ogni tipo di paziente. Da questo, sarai in grado di lavorare nelle unità di neonatologia, emergenza, ematologia e terapia intensiva pediatrica.
Realizza un Master Privato in Infermieristica nel Reparto di Ematologia Pediatrica
In TECH abbiamo la più grande Facoltà di Infermieristica. Ti offriamo un programma altamente qualificato con il quale puoi acquisire le competenze necessarie per diagnosticare e trattare pazienti con malattie correlate. Capirai l'evoluzione dei trattamenti intensivi, i loro effetti collaterali e la ripercussione affettiva o sociale che comporta per ognuno, che consentirà di ampliare l'assistenza clinica e fornire una risposta immediata ai bisogni di salute del paziente. Inoltre, apprenderai le basi dell'ematologia neonatale e pediatrica per curare malattie come l'ematopoiesi fetale, l'anemia, i disturbi della coagulazione, l'emofilia A e B. Allo stesso modo, approfondirai l'uso di cateteri venosi centrali e periferici, trattamenti farmacologici e modelli di cura incentrati sull'approccio NIDCAP.
Ottieni un diploma post-laurea presso la più grande università digitale del mondo
Gli infermieri che desiderano rafforzare le proprie conoscenze e incorporare nuove competenze nella propria carriera troveranno in TECH le basi necessarie per essere esperti in questo settore; Potranno integrare il proprio piano di studi con contenuti grafici multimediali, lezioni tecnico-scientifiche, forum partecipativi e lo sviluppo di casi pratici presentati da professionisti di alto livello. Seguendo questo corso completamente online, si specializzeranno nel trattamento di malattie maligne che vanno dalla leucemia linfoblastica acuta a cellule B (B-ALL), alle emoglobinopatie, all'anemia falciforme e alla talassemia.