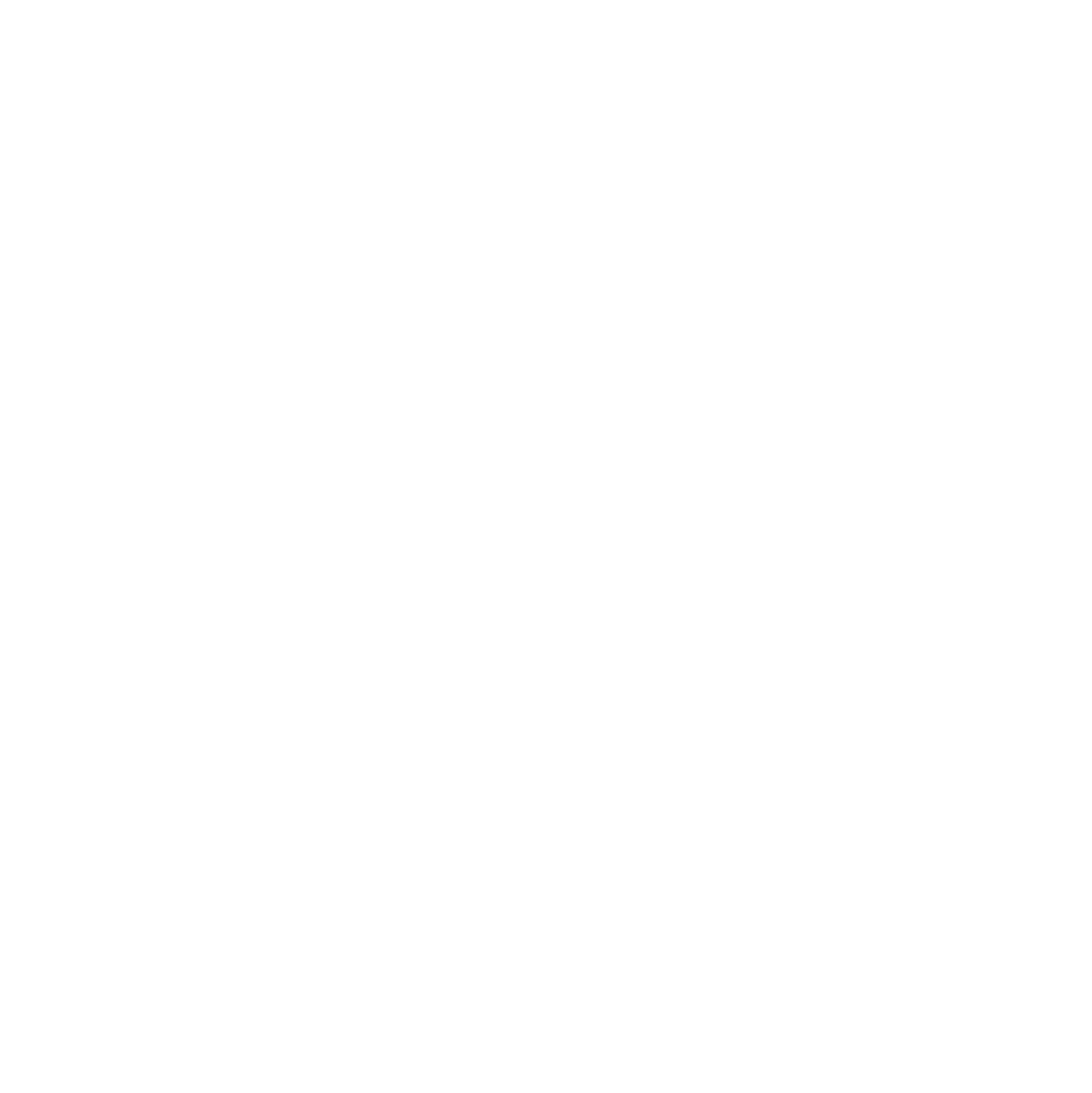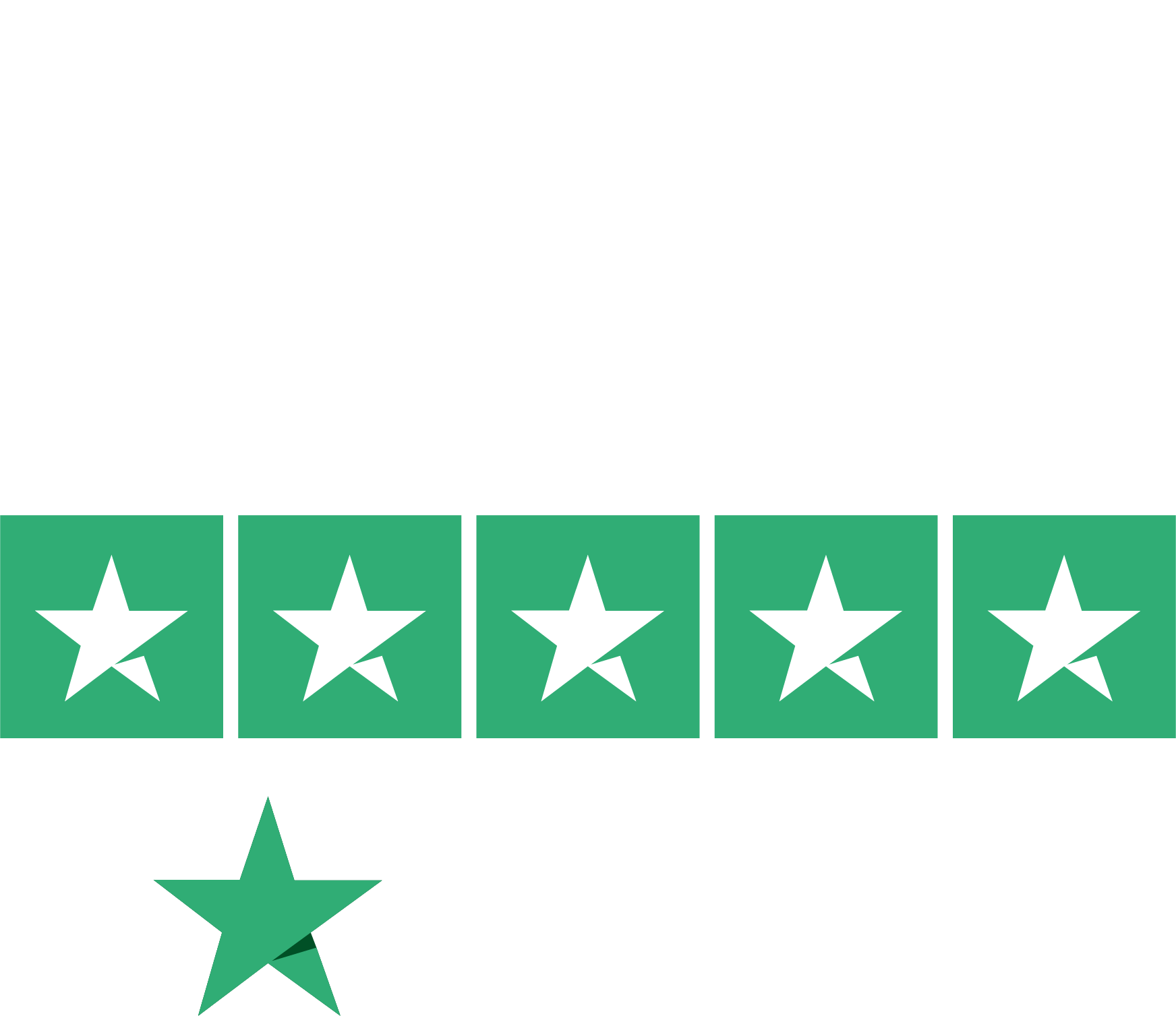Titolo universitario
La più grande facoltà di infermieristica del mondo"
Presentazione
Il buon lavoro degli infermieri nei campi della ginecologia e della riproduzione assistita favorisce il successo dei trattamenti"

Questo tipo di assistenza alle donne richiede conoscenze e attenzioni specifiche.
È il risultato di molteplici cure e attenzioni fornite con generosità e professionalità da diverse categorie di specialisti. Richiede quindi l'acquisizione di conoscenze particolari, diverse da quelle relative al resto della popolazione, ed è quindi necessario affidarsi a professionisti specializzati in queste aree molto specifiche. Lo stesso vale anche per il campo della riproduzione assistita, poiché avere conoscenze specifiche aiuterà i professionisti, ma soprattutto i pazienti.
Questo Master specialistico mira a colmare le lacune degli infermieri in questo campo, fornendo le conoscenze di cui hanno bisogno per mantenersi aggiornati. Fornisce quindi conoscenze su cure specifiche nel campo della ginecologia, come le patologie ginecologiche, i cambiamenti nella crescita e nell'invecchiamento della donna, nonché lo studio dell'infertilità nella donna, per imparare a identificare i fattori più importanti coinvolti in essa e conoscere le patologie più rilevanti e frequenti che colpiscono le donne che manifestano infertilità.
C'è una crescente richiesta di personale infermieristico che abbia una profonda conoscenza della popolazione femminile, al fine di fornire le migliori cure, garantendo un'assistenza di qualità adattata alle nuove ricerche. Per questo motivo, il programma si propone di aiutare gli infermieri a specializzarsi in questo settore e a curare i loro pazienti con il massimo rigore scientifico e professionale.
Durante questa specializzazione, lo studente sarà esposto a tutti gli approcci attuali alle diverse sfide poste dalla sua professione. Un percorso di alto livello che segnerà un processo di miglioramento, non solo professionale, ma anche personale.
Questa sfida è una di quelle che noi di TECH assumiamo come impegno sociale: aiutare i professionisti altamente qualificati a specializzarsi e a sviluppare le loro capacità personali, sociali e lavorative nel corso dei loro studi.
Non solo li accompagneremo attraverso le conoscenze teoriche che offriamo, ma mostreremo un modo differente di studiare e imparare, più organico, semplice ed efficiente. Ci impegniamo per trasmettere agli studenti la motivazione e la passione per l'apprendimento e li spingeremo a pensare e a sviluppare il pensiero critico.
L'elevata richiesta di personale infermieristico nei settori della ginecologia e della riproduzione assistita favorisce questo tipo di specializzazione"
Questo Master specialistico in Assistenza Infermieristica nel Servizio di Ginecologia e Riproduzione Assistita possiede il programma scientifico più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Ultima tecnologia nel software di e-learning
- Sistema di insegnamento intensamente visivo, supportato da contenuti grafici e schematici di facile assimilazione e comprensione
- Sviluppo di casi di studio presentati da esperti attivi
- Sistemi di video interattivi di ultima generazione
- Insegnamento supportato dalla pratica online
- Sistemi di aggiornamento e riqualificazione permanente
- Apprendimento autoregolato: piena compatibilità con altre occupazioni
- Esercizi pratici per l'autovalutazione e la verifica dell'apprendimento
- Gruppi di sostegno e sinergie educative: domande all'esperto, forum di discussione e conoscenza
- Comunicazione con l'insegnante e lavoro di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
- Banche di documentazione di supporto sempre disponibili, anche dopo il completamento del corso
Una proposta didattica di alto livello, supportata da tecnologie avanzate e dall'esperienza docente dei migliori professionisti"
Il nostro personale docente è composto da professionisti attivi. È così che ci assicuriamo di raggiungere l'obiettivo previsto dalla specializzazione. Un team multidisciplinare di professionisti preparati ed esperti in diversi ambienti che svilupperanno efficacemente le conoscenze teoriche ma, soprattutto, metteranno al servizio della specializzazione le conoscenze pratiche derivate dalla propria esperienza.
La padronanza della materia è completata dall'efficacia del disegno metodologico di questo Master Specialistico, elaborato da una team multidisciplinare di esperti di e-Learning e che integra gli ultimi progressi della tecnologia educativa. In questo modo, potrai studiare con una serie di strumenti multimediali comodi e versatili che ti daranno l'operatività di cui hai bisogno nella tua specializzazione.
La progettazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, un approccio che concepisce l'apprendimento come un processo eminentemente pratico. Per raggiungere questo obiettivo in modalità remota,
useremo la telepratica. Grazie all'aiuto di un innovativo sistema di video interattivi e del Learning from an Expert, potrai acquisire le conoscenze come se stessi affrontando il contesto che stai studiando in quel momento. Un concept che ti permetterà di integrare e fissare l'apprendimento in modo più realistico e permanente.
Uno studio approfondito e completo delle strategie e degli approcci in Assistenza Infermieristica nel Servizio di Ginecologia e Riproduzione Assistita"

Possediamo la migliore metodologia d'insegnamento e una moltitudine di casi simulati che ti aiuteranno a prepararti con situazioni reali"
Programma
I contenuti di questa specializzazione sono stati sviluppati dai diversi professori di questo Master Specialistico con un obiettivo chiaro: fare in modo che i nostri studenti acquisiscano tutte le competenze necessarie per diventare veri esperti in materia. I contenuti di questo programma ti permetteranno di apprendere tutti gli aspetti delle diverse discipline coinvolte in questo settore. Un programma completo e ben strutturato che ti eleverà ai più alti standard di qualità e successo.

Grazie a uno studio ben strutturato, potrai accedere alle nozioni più avanzate del momento in Assistenza Infermieristica nel Servizio di Ginecologia e Riproduzione Assistita "
Modulo 1. Anatomia e fisiologia della riproduzione
1.1. Anatomia degli organi riproduttivi femminili
1.1.1. Introduzione
1.1.2. Genitali femminili esterni
1.1.2.1. Vulva
1.1.2.2. Monte di Venere
1.1.2.3. Grandi labbra
1.1.2.4. Piccole labbra
1.1.2.5. Vestibolo vaginale
1.1.2.6. Clitoride
1.1.2.7. Bulbi del vestibolo
1.1.3. Genitali femminili interni
1.1.3.1. Vagina
1.1.3.2. Utero
1.1.3.3. Tube di Falloppio
1.1.3.4. Ovaie
1.2. Endocrinologia dell'apparato riproduttivo femminile
1.2.1. Introduzione
1.2.2. L'ipotalamo
1.2.2.1. GnRH
1.2.3. L'ipofisi
1.2.3.1. FSH e LH
1.2.4. Ormoni steroidei
1.2.4.1. Introduzione
1.2.4.2. Sintesi
1.2.4.3. Meccanismo d'azione
1.2.4.4. Estrogeni
1.2.4.5. Androgeni
1.2.4.6. Progestinici
1.2.5. Modulazione esterna: endorfine e melatonina
1.2.6. Impulsi di GnRH: relazione cervello-ovaio
1.2.7. Agonisti e antagonisti del GnRH
1.3. Ciclo mestruale
1.3.1. Ciclo mestruale
1.3.2. Indicatori biochimici del ciclo mestruale
1.3.2.1. Ormoni allo stato basale
1.3.2.2. Ovulazione
1.3.2.3. Valutazione della riserva ovarica. Ormone anti-mülleriano
1.3.3. Indicatori ecografici del ciclo mestruale
1.3.3.1. Conteggio dei follicoli
1.3.3.2. Ecografia endometriale
1.3.4. Fine dell'età riproduttiva
1.3.4.1. Premenopausa
1.3.4.2. Menopausa
1.3.4.3. Post-menopausa
1.4. Ovogenesi (follicologenesi e ovulazione). Meiosi. Dall'oogonia all'ovocita MII. Tipi di follicoli e loro relazione con l'ovogenesi. Dinamica follicolare. Reclutamento ovarico e ovulazione. L'ovocita MII: marcatori della qualità dell'ovocita. Maturazione degli ovociti in vitro
1.5. Anatomia degli organi riproduttivi maschili
1.5.1. Genitali esterni maschili
1.5.1.1. Testicoli
1.5.1.2. Pene
1.5.1.3. Epididimo
1.5.1.4. Dotti deferenti
1.5.2. Genitali maschili interni
1.5.2.1. Vescicole seminali
1.5.2.2. Dotto eiaculatorio
1.5.2.3. Prostata
1.5.2.4. Uretra
1.5.2.5. Ghiandole bulbouretrali
1.6. Endocrinologia del sistema riproduttivo maschile
1.6.1. Regolazione della funzione testicolare
1.6.2. Biosintesi degli androgeni
1.6.3. Inibine e attivine
1.6.4. Prolattina
1.6.5. Prostaglandine
1.6.6. Estrogeni
1.6.7. Altri fattori
1.7. Spermatogenesi
1.7.1. Meiosi
1.7.2. Differenze tra ovogenesi e spermatogenesi
1.7.3. Il tubulo seminifero
1.7.3.1. Ormoni coinvolti
1.7.3.2. Tipi di cellule
1.7.4. La barriera emato-testicolare
1.7.5. Controllo endocrino e paracrino
1.8. Fecondazione
1.8.1. Trasporto dei gameti
1.8.2. Maturazione dei gameti
1.8.3. Interazione dei gameti
1.9. Sviluppo embrionale
1.9.1. Formazione dello zigote
1.9.2. Prime divisioni
1.9.3. Formazione di blastocisti e impianto
1.9.4. Gastrulazione: formazione del mesoderma
1.9.4.1. Formazione della notocorda
1.9.4.2. Definizione degli assi del corpo
1.9.4.3. Definizione dei destini cellulari
1.9.4.4. Crescita dei trofoblasti
1.9.5. Periodo embrionale o periodo di organogenesi
1.9.5.1. Ectoderma
1.9.5.2. Mesoderma
1.9.5.3. Endoderma
1.10. Effetto dell'età sul sistema riproduttivo femminile e maschile
1.10.1. Sistema riproduttivo femminile
1.10.2. Sistema riproduttivo maschile
Modulo 2. Pubertà, mestruazioni e climaterio
2.1. Patologia della pubertà
2.1.1. Pubertà precoce
2.1.2. Ritardo puberale
2.2. Disturbi mestruali
2.2.1. Amenorrea ipotalamica
2.2.2. Amenorrea di tipo ipofisario
2.2.3. Iperprolattinemia
2.3. Amenorrea uterina
2.3.1. Protocollo
2.3.2. Diagnosi
2.4. Emorragie uterine funzionali
2.4.1. Emorragie ovulatorie
2.4.2. Emorragie anovulatorie
2.4.3. Emorragia da causa extragenitale
2.5. Patologia del climaterio
2.5.1. Trattamento della patologia del climaterio: THS
2.5.2. Terapia ormonale sostitutiva e cancro ginecologico
2.5.3. Misure complementari o alternative in menopausa
2.5.4. Fitoestrogeni
Modulo 3. Patologia infettiva ginecologica e malattie sessualmente trasmissibili
3.1. Infezioni sessualmente trasmissibili
3.1.1. Eziologia
3.1.2. Epidemiologia
3.2. Processi infettivi del sistema riproduttivo
3.2.1. Eziologia
3.2.2. Classificazione
3.2.3. Trattamento
3.3. Vulvovaginite
3.3.1. Descrizione
3.3.2. Trattamento
3.4. Candidosi vaginale
3.4.1. Descrizione
3.4.2. Trattamento
3.5. Vaginosi batterica
3.5.1. Descrizione
3.5.2. Trattamento
3.6. Tricomoniasi vaginale
3.6.1. Descrizione
3.6.2. Trattamento
3.7. Sifilide
3.7.1. Descrizione
3.7.2. Trattamento
3.8. Cancroide
3.8.1. Descrizione
3.8.2. Trattamento
3.9. Linfogranuloma venereo
3.9.1. Descrizione
3.9.2. Trattamento
3.10. Herpes simplex
3.10.1. Descrizione
3.10.2. Trattamento
3.11. Infezioni che portano a uretrite e cervicite
3.11.1. Descrizione
3.11.2. Trattamento
3.12. Condiloma acuminato
3.12.1. Descrizione
3.12.2. Trattamento
3.13. Mollusco contagioso
3.13.1. Descrizione
3.13.2. Trattamento
3.14. Scabbia
3.14.1. Descrizione
3.14.2. Trattamento
3.15. Pediculosis pubis
3.15.1. Descrizione
3.15.2. Trattamento
3.16. HIV
3.16.1. Descrizione
3.16.2. Trattamento
3.17. Malattia infiammatoria pelvica
3.17.1. Descrizione
3.17.2. Trattamento
3.18. Infezione da papillomavirus
3.18.1. Descrizione
3.18.2. Trattamento
Modulo 4. Assistenza alle donne con problemi ginecologici
4.1. Dolore di origine pelvico
4.1.1. Dismenorrea
4.1.2. Sindrome premestruale, endometriosi e altre ancora
4.1.3. Assistenza infermieristica
4.2. Malformazioni del sistema genitale
4.2.1. Malformazioni della vulva
4.2.2. Malformazioni della vagina
4.2.3. Malformazioni del collo dell’utero
4.2.4. Malformazioni dell’utero
4.2.5. Malformazioni ovariche
4.2.6. Malformazioni degli organi urinari inferiori. Fistole urogenitali
4.2.7. Mutilazione genitale femminile
4.2.8. Malformazioni del seno
4.3. Tumori benigni
4.3.1. Tumori benigni della vulva
4.3.2. Tumori benigni della vagina
4.3.3. Tumori benigni dell'ovaio
4.4. Patologia ginecologica benigna
4.4.1. Patologia benigna del collo dell’utero
4.4.2. Patologia benigna del corpo uterino e dell'endometrio
4.4.3. Patologia benigna delle tube di Falloppio
4.5. Alterazioni della statica genitale
4.5.1. Prolasso uterino
4.5.2. Cistocele
4.5.3. Rettocele
4.5.4. Enterocele
4.6. Lacerazioni vulvovaginali e perineali e fistole rettovaginali
4.7. Patologia vulvo-vaginale
4.7.1. Vulvovaginite
4.7.2. Bartolinite
4.7.3. Lichen sclerosus
4.7.4. Malattia di Paget
4.7.5. Cancro vulvare e vaginale
4.8. Patologia della colonna cervicale
4.8.1. Cervicite
4.8.2. Polipi
4.8.3. Tumore cervicale
4.9. Patologia uterina
4.9.1. Mioma uterino
4.9.2. Cancro dell’endometrio
4.10. Patologia annessiale
4.10.1. Malattia Infiammatoria Pelvica (PID)
4.10.2. Sindrome dell'Ovaio Policistico (SOP)
4.10.3. Endometriosi
4.10.4. Carcinoma ovarico
4.10.4. Carcinoma ovarico
Modulo 5. Assistenza alle donne con problemi oncologici ginecologici
5.1. Diagnosi precoce del cancro al seno e del cancro ginecologico
5.1.1. Programmi di diagnosi precoce e di screening della popolazione
5.1.2. Screening dei gruppi a rischio
5.2. Epidemiologia del cancro al seno e del cancro ginecologico
5.2.1. Analisi e test diagnostici
5.3. Cancro al seno e ginecologico
5.3.1. Descrizione
5.3.2. Trattamento
5.4. Cancro alla vulva
5.4.1. Descrizione
5.4.2. Trattamento
5.5. Cancro al collo dell’utero
5.5.1. Descrizione
5.5.2. Trattamento
5.6. Cancro dell’endometrio
5.6.1. Descrizione
5.6.2. Trattamento
5.7. Sarcoma uterino
5.7.1. Descrizione
5.7.2. Trattamento
5.8. Cancro ovarico
5.8.1. Descrizione
5.8.2. Trattamento
5.9. Cancro al seno
5.9.1. Descrizione
5.9.2. Trattamento
5.10. Aspetti psicologici del cancro ginecologico
5.10.1. Assistenza infermieristica
5.10.2. Cure palliative e trattamento del dolore
Modulo 6. Chirurgia ginecologica
6.1. Interventi chirurgici ginecologici
6.1.1. Chirurgia ginecologica
6.1.2. Chirurgia del seno
6.2. La paziente ginecologica ricoverata
6.2.1. Assistenza pre-operatoria
6.2.2. Assistenza post-operatoria
6.2.3. Complicazioni
6.3. Anestesia in ginecologia
6.3.1. Descrizione delle varie tecniche
6.3.2. Assistenza infermieristica
6.4. Chirurgia endoscopica (laparoscopia)
6.4.1. Descrizione
6.4.2. Protocollo d'azione
6.5. Chirurgia endoscopica (isteroscopia)
6.5.1. Descrizione
6.5.2. Protocollo d'azione
6.6. Chirurgia tubarica
6.6.1. Descrizione
6.6.2. Protocollo d'azione
6.7. Chirurgia robotica applicata alla ginecologia
6.7.1. Descrizione
6.7.2. Assistenza infermieristica
Modulo 7. Patologia mammaria
7.1. Esame clinico e strumentale in patologia mammaria
7.1.1. Vari metodi esplorativi
7.1.2. Tipi di metodi diagnostici
7.2. Patologia benigna del seno
7.2.1. Anomalie
7.2.2. Disturbi funzionali
7.2.3. Mastodinia
7.2.4. Processi infiammatori
7.2.5. Patologia tumorale benigna
7.3. Cancro al seno
7.3.1. Epidemiologia e fattori di rischio
7.3.2. Prevenzione primaria. Diagnosi precoce. Lesioni non palpabili
7.3.3. Aspetti clinici e sviluppo
7.3.4. Classificazione TNM
7.3.5. Biologia del carcinoma mammario (marcatori)
7.4. Trattamenti per il cancro al seno
7.4.1. Tipo di trattamento
7.4.2. Assistenza infermieristica
7.5. Monitoraggio e gestione delle pazienti affette da cancro al seno
7.5.1. Controllo assistenziale
7.5.2. Educazione sanitaria
7.5.3. Assistenza infermieristica
Modulo 8. Incontinenza urinaria (IU)
8.1. Epidemiologia dell'incontinenza urinaria
8.1.1. Prevalenza
8.1.2. Incidenza
8.2. Tipi di incontinenza urinaria
8.2.1. Concetto
8.2.2. Classificazione
8.3. Valutazione Infermieristica in presenza di incontinenza urinaria
8.3.1. Processo di Assistenza Infermieristica
8.3.2. Assistenza Infermieristica
8.4. Diagnosi infermieristiche in presenza di incontinenza urinaria
8.4.1. Metodi esplorativi
8.4.2. Metodi diagnostici
8.5. Trattamento dell'incontinenza urinaria
8.5.1. Trattamento non chirurgico
8.5.2. Trattamento chirurgico
8.6. Prevenzione e gestione infermieristica dell'incontinenza urinaria nelle donne
8.6.1. Educazione alla salute
Modulo 9. Urgenze ginecologiche e ostetriche
9.1. Dolore addominale ginecologico
9.1.1. Concetto
9.1.2. Assistenza infermieristica
9.2. Traumi e lesioni dell'apparato genitale
9.2.1. Tipi
9.2.2. Assistenza infermieristica
9.3. Violenza sessuale
9.3.1. Concetto
9.3.2. Diagnosi
9.3.3. Assistenza infermieristica
9.4. Emorragia ginecologica
9.4.1. Classificazione
9.4.2. Assistenza infermieristica
9.5. Minaccia di parto pretermine
9.5.1. Concetto
9.5.2. Trattamento
9.5.3. Assistenza infermieristica
9.6. Stati ipertensivi della gravidanza
9.6.1. Classificazione
9.6.2. Trattamento
9.6.3. Assistenza infermieristica
9.7. Emorragia ostetrica
9.7.1. Emorragia nel 1° trimestre di gravidanza
9.7.2. Emorragia nel 2° e 3° trimestre di gravidanza
9.7.3. Emorragia post-partum
Modulo 10. Studio dell'infertilità nelle donne
10.1. Studio diagnostico iniziale
10.1.1. Introduzione
10.1.2. Base dello studio dei fattori
10.1.3. Storia clinica
10.1.4. Analisi fisica
10.1.5. Studi di base sull'infertilità
10.1.6. Studi complementari in base al fattore alterato
10.2. Fattore ovarico
10.2.1. L'età
10.2.1.1. Età e riserva ovarica
10.2.1.2. Insufficienza ovarica precoce
10.2.1.3. Studi per la valutazione della riserva ovarica
10.2.1.3.1. AMH
10.2.1.3.2. RFA
10.2.1.3.3. Altri ormoni
10.2.2. Anovulazione
10.2.2.1. Che cos'è l'anovulazione?
10.2.2.2. Manifestazioni cliniche
10.2.2.3. Importanza della fase luteale
10.2.2.4. Cause
10.2.2.4.1. Sindrome dell'ovaio policistico
10.2.2.4.2. Disturbi ormonali più comuni
10.2.2.4.3. Altre cause
10.2.2.5. Studi di valutazione dell'ovulazione
10.2.2.5.1. Profilo ormonale ginecologico
10.2.2.5.2. Altri ormoni
10.2.2.5.2.1. Ormoni tiroidei
10.2.2.5.2.2. Prolattina
10.2.2.4.2.3. Androgeni
10.2.2.5.3. Progesterone della fase luteale
10.3. Fattore uterino e tubarico
10.3.1. Utero
10.3.1.1. Utero ed endometrio
10.3.1.2. Malformazioni mülleriane
10.3.1.3. Fibromi e polipi
10.3.1.4. Sindrome di Asherman
10.3.1.5. Fattore uterino e fallimento dell'impianto
10.3.1.6. Fattore uterino e aborto spontaneo ricorrente
10.3.2. Le tube di Falloppio
10.3.2.1. Ostruzione tubarica
10.3.2.1.1. Infettiva
10.3.2.1.2. Chirurgica
10.3.2.1.3. Endometriosi
10.3.2.1.4. Altri
10.3.3. Studi
10.3.3.1. Ecografia 2D e 3D
10.3.3.2. Isteroscopia e altro
10.3.3.2.1. Isteroscopia
10.3.3.2.2. Isterosalpingografia
10.3.3.2.3. Isterosonografia
10.3.3.2.4. Isterolaparoscopia
10.3.3.2.5. RMN
10.4. Fattore infettivo
10.4.1. Infezioni e infertilità
10.4.2. Infezioni più frequenti
10.4.3. Malattia infiammatoria pelvica
10.4.4. Hidrosalpinx
10.4.5. Studi
10.4.5.1. Colture e colture speciali
10.4.5.2. PCR e altri
10.5. Fattori genetici
10.5.1. La genetica oggi
10.5.2. Alterazioni genetiche più comuni
10.5.2.1. Sindrome di Turner
10.5.2.2. Sindrome dell’X Fragile
10.5.2.3. Trombofilia ereditaria
10.5.2.4. Altre mutazioni
10.5.3. Studi di screening
10.6. Fattore immunologico
10.6.1. Sistema immunitario e fertilità
10.6.2. Principali disturbi
10.6.2.1. Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
10.6.2.2. Lupus eritematoso sistemico (LES)
10.6.2.3. Altri
10.6.3. I principali test immunologici
10.7. Endometriosi
10.7.1. L'endometriosi oggi
10.7.2. Implicazioni per la fertilità
10.7.3. La paziente affetta da endometriosi
10.7.4. Analisi clinica e di laboratorio
10.8. Fallimento dell'impianto e aborto spontaneo ricorrente
10.8.1. Fallimento dell'impianto
10.8.1.1. Definizione
10.8.1.2. Cause principali
10.8.1.3. Studio
10.8.2. Aborto spontaneo ricorrente
10.8.2.1. Definizione
10.8.2.2. Cause principali
10.8.2.3. Studio
10.9. Considerazioni speciali
10.9.1. Fattore cervicale
10.9.1.1. Importanza della fisiologia cervicale
10.9.2. Test post-coitale
10.9.2.1. Sessuologia
10.9.2.2. Vaginismo
10.9.3. Cause psicologiche
10.9.4. Infertilità di origine sconosciuta
10.9.4.1. Definizione
10.9.4.2. Che cosa fare?
10.9.5. Approccio completo
10.10. Conclusioni
Modulo 11. Studio dell'infertilità negli uomini
11.1. Studio diagnostico iniziale
11.1.1. Obiettivi
11.1.2. Quando farlo?
11.1.3. Valutazione minima
11.1.4. Valutazione ottimale
11.1.5. Storia clinica
11.1.6. Analisi fisica
11.2. Esami complementari
11.2.1. Test di funzionalità spermatica
11.2.2. Determinazioni ormonali
11.2.3. Ultrasonografia ed ecografia doppler scrotale
11.2.4. Ecografia transrettale
11.2.5. Studio batteriologico dello sperma
11.2.6. Analisi delle urine dopo l'orgasmo
11.3. Studi genetici
11.3.1. Cariotipo
11.3.2. Microdelezioni Y
11.3.3. Mutazioni CFTR
11.3.4. Studi sui cromosomi meiotici
11.3.5. FISH degli spermatozoi
11.4. Seminogramma
11.4.1. Considerazioni di base
11.4.2. Gestione adeguata del campione
11.4.3. Prelievo dei campioni
11.4.3.1. Preparazione
11.4.3.2. Raccolta per la diagnosi
11.4.3.3. Raccolta per l'utilizzo nella riproduzione assistita
11.4.3.4. Raccolta per analisi microbiologiche
11.4.3.5. Raccolta a casa
11.4.3.6. Raccolta con preservativo
11.4.4. Esame macroscopico iniziale
11.4.4.1. Liquefazione
11.4.4.2. Viscosità
11.4.4.3. Apparenza
11.4.4.4. Volume
11.4.4.5. PH
11.4.5. Esame microscopico iniziale
11.4.5.1. Come ottenere un campione rappresentativo
11.4.5.2. Quantità del campione
11.4.5.3. Aggregazione
11.4.5.4. Agglutinazione
11.4.5.5. Presenza di elementi cellulari diversi dagli spermatozoi
11.4.6. Motilità
11.4.7. Vitalità
11.4.8. Concentrazione
11.4.9. Conteggio di cellule diverse dagli spermatozoi
11.4.10. Morfologia spermatica
11.4.11. Presenza di leucociti nello sperma
11.4.12. Test degli anticorpi anti-spermatozoi
11.4.13. Analisi automatizzata
11.5. Analisi e trattamento dei campioni per le tecnologie di riproduzione assistita (ART)
11.5.1. Lavaggio
11.5.2. Swim-up
11.5.3. Gradienti di densità
11.6. Congelamento dello sperma
11.6.1. Indicazioni
11.6.2. Crioprotettori
11.6.3. Tecniche di congelamento dello sperma
11.6.4. Contenitori di stoccaggio
11.7. Lavaggio dello sperma per uomini sieropositivi all'HIV, all'epatite B e all'epatite C
11.7.1. Epatite B
11.7.2. HIV
11.7.3. Epatite C
11.7.4. Considerazioni generali
11.8. Donazione di sperma
11.8.1. Informazioni generali
11.8.2. Indicazioni
11.8.3. Considerazioni sul donatore di sperma
11.8.4. Prove diagnostiche raccomandate
11.8.5. Anonimato
11.8.6. Scegliere il donatore giusto
11.8.7. Rischi
11.8.8. Cessazione della donazione
11.9. Tecniche complementari di selezione dello sperma
11.9.1. MACS (smistamento cellulare marcato magneticamente)
11.9.1.1. Basi biologiche della tecnica
11.9.1.2. Indicazioni
11.9.1.3. Vantaggi e svantaggi
11.9.2. IMSI (Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi morfologicamente selezionati)
11.9.2.1. Procedura
11.9.2.2. Indicazioni
11.9.2.3. Vantaggi e svantaggi
11.9.3. Selezione basata sul legame con l'acido ialuronico
11.9.3.1. Procedura
11.9.3.2. Indicazioni
11.9.3.3. Vantaggi e svantaggi
11.10. Terapia orale. Uso di antiossidanti
11.10.1. Concetto di antiossidante
11.10.2. Specie reattive dell'ossigeno (ROS)
11.10.3. Fattori che portano ad un aumento dei ROS nello sperma
11.10.4. Danni causati dall'aumento dei ROS negli spermatozoi
11.10.5. Sistema antiossidante nello sperma
11.10.5.1. Antiossidanti enzimatici
11.10.5.2. Superossido dismutasi
11.10.5.3. Catalasi
11.10.5.4. Ossido nitrico sintasi
11.10.5.5. Glutatione S-transferasi
11.10.5.6. Perossidossina
11.10.5.7. Tioredossine
11.10.5.8. Glutatione perossidasi
11.10.6. Integrazione esogena
11.10.6.1. Acidi grassi Omega 3
11.10.6.2. Vitamina C
11.10.6.3. Coenzima Q10
11.10.6.4. L-Carnitina
11.10.6.5. Vitamina E
11.10.6.6. Selenio
11.10.6.7. Zinc o
11.10.6.8. Acido folico
11.10.6.9. L-Arginina
11.10.7. Conclusioni
Modulo 12. Genetica e immunologia riproduttiva
12.1. Citogenetica di base: l'importanza della cariotipizzazione
12.1.1. Il DNA e la sua struttura
12.1.1.1. Geni
12.1.1.2. Cromosomi
12.1.2. Il cariotipo
12.1.3. Usi della cariotipizzazione: diagnosi prenatale
12.1.3.1. Amniocentesi
12.1.3.2. Campionamento dei villi coriali
12.1.3.3. Analisi dell'aborto
12.1.3.4. Studi sulla meiosi
12.2. La nuova era della diagnostica: citogenetica molecolare e sequenziamento di massa
12.2.1. FISH
12.2.2. Array CGH
12.2.3. Sequenziamento di massa
12.3. Origine ed eziologia delle anomalie cromosomiche
12.3.1. Introduzione
12.3.2. Classificazione in base all'origine
12.3.2.1. Numerica
12.3.2.2. Strutturale
12.3.2.3. Mosaicismo
12.3.3. Classificazione in base all'eziologia
12.3.3.1. Autosomica
12.3.3.2. Sessuale
12.3.3.3. Poliploidia e aploidia
12.4. Disturbi genetici nella coppia infertile
12.4.1. Disturbi genetici nella donna
12.4.1.1. Origine ipotalamica
12.4.1.2. Origine ipofisaria
12.4.1.3. Origine ovarica
12.4.1.3.1. Alterazioni cromosomiche
12.4.1.3.1.1. Delezione Totale del cromosoma X: Sindrome di Turner
12.4.1.3.1.2. Delezione parziale del cromosoma X
12.4.1.3.1.3. Traslocazioni del cromosoma X e degli autosomi
12.4.1.3.1.4. Altro
12.4.1.4. Disturbi monogenici
12.4.1.4.1. X fragile
12.4.1.5. Trombofilia ereditaria
12.4.2. Disordini genetici nell'uomo
12.4.2.1. Alterazioni numeriche: Sindrome di Klineffelter
12.4.2.2. Traslocazioni robertsoniane
12.4.2.3. Mutazioni CFTR
12.4.2.4. Microdelezioni sul cromosoma Y
12.5. Diagnosi genetica pre-impianto (PGT: Preimplantation Genetic Testing)
12.5.1. Introduzione
12.5.2. Biopsia embrionale
12.5.3. Indicazioni
12.5.4. Diagnosi genetica per malattie monogeniche (PGT-M)
12.5.4.1. Studi sul vettore
12.5.5. Diagnosi genetica per anomalie strutturali
12.5.5.1. Numerico (aneuploidie, PGT-A)
12.5.5.2. Strutturale (PGT-SR)
12.5.6. Diagnosi genetica combinata
12.5.7. Limitazioni
12.5.8. Gli embrioni mosaico come caso speciale
12.5.9. Diagnosi genetica pre-impianto non invasiva
12.6. Neonati con tre progenitori genetici, trasferimento nucleare nelle malattie mitocondriali
12.6.1. DNA mitocondriale
12.6.2. Malattie mitocondriali
12.6.3. Trasferimento di donatori citoplasmatici
12.7. Epigenetica
12.7.1. Concetti generali
12.7.2. Modifiche epigenetiche
12.7.3. Imprinting genetico
12.8. Studi genetici sui donatori
12.8.1. Raccomandazioni
12.8.2. Matching dei vettori
12.8.3. Pannelli portanti
12.9. Il fattore immunologico nella riproduzione assistita
12.9.1. Aspetti generali
12.9.2. Il sistema immunitario femminile in continua evoluzione
12.9.3. Popolazione di cellule immunitarie nel sistema riproduttivo femminile
12.9.3.1. Regolazione delle popolazioni di linfociti T
12.9.3.2. Citochine
12.9.3.3. Ormoni femminili
12.9.4. Infertilità di origine autoimmune
12.9.4.1. Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
12.9.4.2. Anticorpi anti-tiroidei
12.9.4.3. Anticorpi antinucleari
12.9.4.4. Anticorpi anti-ovarici e anti-FSH
12.9.4.5. Anticorpi anti-spermatozoi
12.9.5. Infertilità di origine alloimmune, il contributo del feto
12.9.5.1. L'embrione come antigene
12.9.5.2. Fallimento dell'impianto di embrioni euploidi
12.9.5.2.1. Cellule NK
12.9.5.2.2. T-Helpers
12.9.5.2.3. Anticorpi
12.9.6. Il ruolo dello sperma e degli spermatozoi
12.9.6.1. Regolazione dei linfociti T
12.9.6.2. Liquido seminale e cellule dendritiche
12.9.6.3. Importanza clinica
12.10. Immunoterapia e situazioni speciali
12.10.1. Introduzione
12.10.2. Aspirina ed eparina
12.10.3. Corticosteroidi
12.10.4. Terapia antibiotica
12.10.5. Fattori di crescita delle colonie
12.10.6. Emulsioni di grasso per via endovenosa
12.10.7. Immunoglobuline per via endovenosa
12.10.8. Adalimumab
12.10.9. Cellule mononucleari periferiche
12.10.10. Plasma seminale
12.10.11. Preparazioni di sperma senza anticorpi
12.10.12. Tacrolimus
12.10.13. Rischi e benefici
12.10.14. Conclusioni
12.10.15. Situazioni speciali: endometriosi
12.10.16. Situazioni particolari: infezione da Chlamydia trachomatis
Modulo 13. Consulenza in materia di riproduzione assistita e banca dei donatori
13.1. Importanza dell'infermiere nella clinica di Riproduzione Assistita
13.1.1. Consulenza infermieristica. Un bisogno emergente
13.1.2. Aree di lavoro: assistenza, gestione e istruzione
13.1.3. L’assistenza integrale continuata
13.2. Area di assistenza. Visita di follow-up
13.2.1. Assistenza al paziente nei cicli di stimolazione
13.2.2. Follicolometria
13.2.3. Citologia
13.3. Esami del sangue per lo studio della fertilità. Programmazione, interpretazione e raccolta
13.3.1. Ormoni ipofisari o gonadotropine
13.3.1.1. FSH
13.3.1.2. LH
13.3.1.3. Prolattina
13.3.1.4. TSH
13.3.2. Ormoni ovarici
13.3.2.1. Estradiolo
13.3.2.2. Progesterone
13.3.2.3. Antimulleriano (AMH)
13.3.3. Altri ormoni
13.3.3.1. Triiodotironina libera (T3)
13.3.3.2. Tiroxina libera (T4)
13.3.3.3. Testosterone totale (T)
13.3.3.4. Inibina B
13.3.4. Studio sul fallimento dell'impianto. Interpretazione ed estrazione
13.3.4.1. Definizione
13.3.4.2. Profilo immunologico
13.3.4.3. Trombofilia
13.3.4.4. Biopsia endometriale
13.3.4.5. Coltura endocervicale e vaginale
13.3.5. Sierologia. Interpretazione ed estrazione
13.3.5.1. Introduzione e necessità
13.3.5.2. VHB
13.3.5.3. VHC
13.3.5.4. HIV
13.3.5.5. Sifilide (RPR)
13.3.5.6. Rosolia
13.3.5.7. Toxoplasmosi
13.3.6. Cariotipi
13.4. Area di educazione del paziente
13.4.1. Comunicazione efficace
13.4.2. Misure igienico-dietetiche di base. Importanza della IMC
13.4.3. Autosomministrazione di farmaci
13.5. Area di Gestione
13.5.1. Storia clinica
13.5.2. Richiesta di gameti
13.5.2.1. Richiesta di gameti maschili
13.5.2.2. Richiesta di gameti femminili
13.5.3. Trasferimento di materiale genetico
13.6. Follow-up della paziente dopo il risultato della BHCG
13.6.1. Introduzione. Interpretazione dei risultati
13.6.2. Prima visita dopo il risultato BHCG
13.6.2.1. Risultato negativo
13.6.2.2. Risultato positivo
13.6.3. Educazione alimentare per le donne in gravidanza
13.6.4. Follow-up della donna in gravidanza. Farmaci e monitoraggio ecografico. Alto
13.6.5. Monitoraggio ostetrico dopo il parto
13.7. Banca dei donatori
13.7.1. Requisiti del donatore. Test e compatibilità. Importanza del gruppo sanguigno
13.7.2. Limiti al numero di stimoli e/o donazioni
13.7.3. Limitazione del numero di gravidanze
13.7.4. Donazioni internazionali
13.7.5. Anonimato
13.7.6. Compensazione finanziaria
13.7.7. Registrazione dei donatori
13.7.8. Test aggiuntivi
13.8. Domande frequenti
13.9. Conclusioni
Modulo 14. Farmacologia
14.1. Induttore della follicologenesi: clomifene citrato
14.1.1. Introduzione
14.1.2. Definizione
14.1.3. Meccanismo d'azione
14.1.4. Metodo di somministrazione e istruzioni per l'uso
14.1.5. Effetti collaterali
14.1.6. Vantaggi e svantaggi
14.1.7. Risultati
14.2. Induzione della follicologenesi con le gonadotropine
14.2.1. Introduzione e indicazioni
14.2.2. Tipi
14.2.2.1. Stimolanti del follicolo
14.2.2.2. Stimolanti del corpo luteo
14.2.3. Stimolazione con dosi crescenti o decrescenti
14.2.4. Esito del trattamento
14.2.5. Complicazioni
14.2.6. Istruzioni per l'autosomministrazione
14.3. Induttori di ovulazione
14.3.1. Gonadotropina corionica umana (hCG) e ricombinante
14.3.2. Gonadotropina umana della menopausa (HMG)
14.3.3. Ormone follicolo stimolante ricombinante (FSH)
14.3.4. Ormone luteinizzante ricombinante (LH)
14.3.5. Agonista del GnRH
14.4. Altri trattamenti ormonali
14.4.1. Ormone ipotalamico di rilascio delle gonadotropine (GnRH)
14.4.1.1. Introduzione
14.4.1.2. Meccanismo d'azione
14.4.1.3. Programma di amministrazione
14.4.1.4. Complicazioni
14.4.2. Inibitori dell’aromatasi
14.4.2.1. Definizione e utilizzo
14.4.2.2. Meccanismo d'azione e modalità d'uso
14.4.2.3. Programma di amministrazione
14.4.2.4. Tipi
14.4.2.5. Vantaggi e svantaggi
14.5. Uso di analoghi delle gonadotropine nella riproduzione assistita
14.5.1. Agonisti
14.5.1.1. Introduzione e principali agonisti
14.5.1.2. Origine, struttura chimica e proprietà farmacodinamiche
14.5.1.3. Farmacocinetica e via di somministrazione
14.5.1.4. Effettività
14.5.2. Antagonisti
14.5.2.1. Tipi e meccanismo d'azione
14.5.2.2. Forme di somministrazione
14.5.2.3. Farmacocinetica e farmacodinamica
14.6. Altri farmaci coadiuvanti utilizzati nella riproduzione assistita
14.6.1. Farmaci insulino-sensibilizzanti: metformina
14.6.2. Corticosteroidi
14.6.3. Acido folico
14.6.4. Estrogeni e progesterone
14.6.5. Contraccettivi orali
14.7. Supporto farmacologico della fase luteale nella fecondazione in vitro
14.7.1. Introduzione
14.7.2. Metodi di trattamento dell'insufficienza della fase luteale
14.7.2.1. Supporto luteale con hCG
14.7.2.2. Integrazione della fase luteale con progesterone
14.7.2.3. Integrazione della fase luteale con estrogeni
14.7.2.4. Mantenimento della fase luteale con agonisti del GnRH
14.7.3. Controversie
14.7.4. Conclusione
14.8. Complicanze della stimolazione ovarica: sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS)
14.8.1. Introduzione
14.8.2. Fisiopatologia
14.8.3. Sintomatologia e classificazione
14.8.4. Prevenzione
14.8.5. Trattamento
14.9. Presentazioni commerciali nei trattamenti di fertilità
14.9.1. Ovitrelle®, Elenva®, Ovaleap®, Porgoveris®, Bemfola®, Monopur®, Gonal®, Puregon®, Fostipur®, HMG-Lepori®, Decapeptyl®, Cetrecide®, Orgaluntan®
14.10. Gestione anestetica nella riproduzione assistita
14.10.1. Introduzione
14.10.2. Anestesia locale
14.10.3. Oppioidi
14.10.4. Benzodiazepine
14.10.5. Anestesia generale per inalazione e per via endovenosa: protossido di azoto, alogenati e propofol
14.10.6. Anestesia regionale
14.10.7. Conclusioni
Modulo 15. Tecniche di riproduzione assistita
15.1. Inseminazione artificiale
15.1.1. Definizione
15.1.2. Tipi
15.1.3. Indicazioni
15.1.4. Requisiti
15.1.5. Procedura
15.1.6. Esito della FIV/ICSI e probabilità di gravidanza
15.1.7. Definizione e differenze
15.1.8. Indicazioni per la FIV/ICSI
15.1.9. Requisiti
15.1.10. Vantaggi e svantaggi
15.1.11. Probabilità di gravidanza
15.1.12. Procedura
15.1.12.1. Puntura dell'ovocita
15.1.12.2. Valutazione degli ovociti
15.1.12.3. Inseminazione ovocitaria (FIV/ICSI)
15.1.12.3.1. Altre tecniche di inseminazione: IMSI, PICSI, ICSI+MACS, uso di luce polarizzata
15.1.12.4. Valutazione della fecondazione
15.1.12.5. Coltura di embrioni
15.1.12.5.1. Tipi
15.1.12.5.2. Sistemi di coltura
15.1.12.5.3. Attrezzatura per la coltura timelapse
15.1.13. Rischi potenziali
15.2. Test genetici preimpianto (PGT)
15.2.1. Definizione
15.2.2. Tipi
15.2.3. Indicazioni
15.2.4. Procedura
15.2.5. Vantaggi e svantaggi
15.3. Trasferimento embrionale
15.3.1. Definizione
15.3.2. Qualità e selezione di embrioni
15.3.2.1. Giorno di trasferimento
15.3.2.2. Numero di embrioni da trasferire
15.3.3. Schiusa assistita
15.3.4. Procedura
15.4. Congelamento e vetrificazione
15.4.1. Differenze
15.4.2. Congelamento dello sperma
15.4.2.1. Definizione
15.4.3. Vitrificazione degli ovuli
15.4.3.1. Definizione
15.4.3.2. Procedura
15.4.3.3. De-vitrificazione
15.4.3.4. Vantaggi: conservazione e donazione
15.4.4. Vitrificazione degli embrioni
15.4.4.1. Definizione
15.4.4.2. Indicazioni
15.4.4.3. Giornata della vetrificazione
15.4.4.4. Procedura
15.4.4.5. De-vitrificazione
15.4.4.6. Vantaggi
15.4.5. Conservazione della fertilità (sperimentale)
15.4.5.1. Tessuto ovarico
15.4.5.2. Tessuto testicolare
15.5. Donazione
15.5.1. Definizione
15.5.2. Tipi di donazione
15.5.2.1. Donazione di ovuli (OVODONATION)
15.5.2.1.1. Definizione
15.5.2.1.2. Indicazioni
15.5.2.1.3. Tipi di ovodonazione
15.5.2.1.4. Procedura
15.5.2.1.4.1. Puntura ovarica di una donatrice
15.5.2.1.4.2. Preparazione dell'endometrio della ricevente
15.5.2.2. Banca degli ovociti: sistema di stoccaggio
15.5.2.3. Vantaggi e svantaggi
15.5.2.2. Donazione di sperma
15.5.2.2.1. Procedura
15.5.2.3. Donazione di embrioni
15.5.2.3.1. Definizione
15.5.2.3.2. Indicazioni
15.5.2.3.3. Procedura
15.5.2.3.4. Vantaggi
15.5.2.4. Donazione doppia
15.5.2.4.1. Definizione
15.5.2.4.2. Indicazioni
15.5.2.4.3. Procedura
15.6. Metodo ROPA
15.6.1. Definizione
15.6.2. Indicazioni
15.6.3. Procedura
15.6.4. Requisiti giuridici
15.7. Tracciabilità
15.7.1. Definizione
15.7.2. Materiali
15.7.3. Campioni
15.7.4. Doppio controllo
15.7.5. Sistemi tecnologici per la tracciabilità (Witness, Gidget
15.8. Biovigilanza
15.9. Altre tecniche
15.9.1. Test di ricettività endometriale (ERA)
15.9.2. Studio del microbioma vaginale
Modulo 16. La sala operatoria e il laboratorio di riproduzione assistita
16.1. L’area chirurgica
16.1.1. Ambiti dell’area chirurgica
16.1.2. Abbigliamento chirurgico
16.1.3. Ruolo degli infermieri nell'unità di riproduzione assistita
16.1.4. Gestione dei rifiuti e controllo ambientale
16.2. Puntura follicolare per il prelievo degli ovociti
16.2.1. Definizione
16.2.2. Caratteristiche
16.2.3. Procedura e materiale richiesto
16.2.4. Attività infermieristiche: intraoperatorie
16.2.5. Attività infermieristiche: post-operatorie
16.2.6. Raccomandazioni al momento delle dimissioni
16.2.7. Complicazioni
16.3. Trasferimento embrionale
16.3.1. Definizione
16.3.2. Caratteristiche
16.3.3. Procedure e materiale richiesto
16.3.4. Preparazione dell'endometrio: estrogeni e progesterone
16.3.5. Ruolo dell'infermiere durante il trasferimento degli embrioni
16.3.6. Ruolo dell'infermiere dopo il trasferimento embrionale
16.3.7. Istruzioni per la dimissione
16.3.8. Complicazioni
16.4. Prelievo di sperma in pazienti con azoospermia (biopsia testicolare)
16.4.1. Introduzione e prelievo di spermatozoi
16.4.2. Metodi
16.4.2.1. MESA
16.4.2.2. PESA
16.4.2.3. TESE
16.4.2.4. TESA
16.4.2.5. TEFNA
16.4.3. Conclusione
16.5. Trattamenti chirurgici per l'infertilità
16.5.1. Laparoscopia nell'infertilità
16.5.1.1. Obiettivi
16.5.1.2. Tecniche e strumenti
16.5.1.3. Indicazioni
16.5.2. Isteroscopia
16.5.2.1. Introduzione
16.5.2.2. Tecniche diagnostiche
16.5.2.3. Dispositivi di distensione isteroscopica
16.5.2.4. Tecniche operatorie
16.6. Il laboratorio come camera bianca: definizione
16.7. Struttura del laboratorio
16.7.1. Laboratorio di Andrologia
16.7.2. Laboratorio di Embriologia
16.7.3. Laboratorio di Criobiologia
16.7.4. Laboratorio di PGD
16.8. Condizioni di laboratorio
16.8.1. Disegno
16.8.2. Pressione
16.8.3. Controllo dei gas (CO2, O2, N2)
16.8.4. Controllo della temperatura
16.8.5. Controllo dell'aria (COV)
16.8.6. Illuminazione
16.9. Pulizia, manutenzione e sicurezza
16.9.1. Abbigliamento e igiene del personale
16.9.2. Pulizia del laboratorio
16.9.3. Biosicurezza
16.9.4. Controllo di qualità
16.10. Attrezzature di laboratorio
16.10.1. Cappe
16.10.2. Incubatrici
16.10.3. Microiniettori
16.10.4. Frigoriferi
16.10.5. Serbatoi di azoto
16.10.6. Attrezzatura time lapse
16.10.7. Monitoraggio, guasti e riparazioni delle apparecchiature
16.11. Tempi di lavoro in laboratorio
Modulo 17. Supporto psicologico e situazioni particolari nella riproduzione assistita
17.1. Psicologia della riproduzione umana
17.1.1. Fisiologia riproduttiva
17.1.2. Sessualità umana: funzionale e disfunzionale
17.1.3. Definizione di infertilità/sterilità
17.1.4. Sostegno alle coppie infertili
17.2. Psicologia della riproduzione umana assistita
17.2.1. Credenze sulla riproduzione assistita
17.2.2. Aspetti psicologici, emotivi, comportamentali e cognitivi della procreazione assistita
17.2.3. Aspetti psicologici degli studi genetici
17.2.4. Ripercussioni psicologiche ed emotive dei trattamenti riproduttivi
17.2.5. Attesa dei risultati
17.2.6. Famiglie frutto della Riproduzione Assistita
17.2.6.1. Tipi di famiglia e supporto infermieristico emotivo
17.3. Perdita gestazionale ricorrente
17.3.1. Cause
17.3.1.1. Stress
17.3.2. Credenze sociali, culturali e religiose
17.3.3. Possibili reazioni all'aborto ripetuto
17.3.4. Ripercussioni psicologiche e cognitivo-comportamentali dell'aborto
17.3.5. Aborto ripetuto psicosomatico
17.3.6. Intervento sugli aborti ripetuti
17.3.7. Indicazione per la psicoterapia: supporto Infermieristico nella psicoterapia
17.4. Approccio psicosociale alla donazione di gameti
17.4.1. Colloquio con i candidati donatori di gameti
17.4.1.1. Valutazione qualitativa
17.4.1.2. Valutazione quantitativa
17.4.1.3. Valutazione comportamentale
17.4.1.4. Valutazione psicotecnica
17.4.2. Rapporto di valutazione dei candidati alla donazione di gameti
17.4.2.1. Rivalutazione
17.4.3. Famiglie di riceventi di gameti
17.4.3.1. Credenze e miti sulla donazione di gameti
17.4.3.2. Domande frequenti
17.4.3.3. Divulgazione delle origini secondo i modelli familiari
17.5. Consulenza infermieristica nella riproduzione assistita: Approccio psicosociale
17.5.1. Consulenza e trattamento olistico nell'assistenza infermieristica alla Riproduzione Assistita
17.5.2. Ruolo dell'Assistenza Sanitaria primaria alla coppia infertile
17.5.2.1. Reclutamento della popolazione target
17.5.2.2. Colloquio iniziale: accoglienza, informazione, consulenza, rinvio ad altri professionisti
17.5.3. Gestione della comunicazione con i pazienti che praticano la riproduzione assistita
17.5.3.1. Abilità comunicative
17.5.3.2. Relazione interpersonale infermiere-paziente
17.5.3.3. Assistenza emotiva al paziente nella riproduzione assistita
17.5.3.3.1. Individuazione di problemi emotivi nel colloquio con il paziente
17.5.3.3.2. Strategie di intervento e prevenzione
17.5.3.3.3. Gruppi di sostegno
17.5.4. Principali diagnosi infermieristiche (NANDA), interventi (NIC) ed esiti (NOC) nel processo emozionale della Riproduzione Assistita
17.6. Situazioni specifiche
17.6.1. Approccio riproduttivo nel paziente oncologico
17.6.1.1. Che impatto ha il trattamento del cancro sulla fertilità?
17.6.1.2. Quando è necessaria la conservazione della fertilità?
17.6.1.3. Limiti della conservazione della fertilità
17.6.2. Conservazione della fertilità nel paziente oncologico
17.6.2.1. Stimolazione ovarica per la conservazione della fertilità nella paziente oncologica
17.6.2.2. Metodi di conservazione della fertilità
17.6.2.2.1. Crioconservazione: ovociti, embrioni e tessuti ovarici
17.6.2.2.2. Terapia ormonale
17.6.2.2.3. Trasposizione ovarica
17.6.3. Conservazione della fertilità nel paziente oncologico
17.6.3.1. Metodi di conservazione fertilità
17.6.3.1.1. Crioconservazione dello sperma
17.6.3.1.2. Crioconservazione del tessuto testicolare
17.6.3.1.3. Terapia ormonale
17.6.4. Approccio e conservazione riproduttiva nei pazienti con riassegnazione del sesso
17.7. Consulenza nutrizionale nella riproduzione assistita
17.7.1. Alimentazione e infertilità. Stile di vita
17.7.1.1. Obesità
17.7.1.2. Problemi ormonali
17.7.1.2.1. Ipotiroidismo/ipertiroidismo
17.7.1.2.2. Diabete Mellito
17.7.1.2.3. SOP
17.7.1.2.4. Endometriosi
17.7.2. Alimenti consigliati/sconsigliati prima e durante il trattamento di riproduzione assistita
17.7.2.1. Ruolo delle vitamine
17.7.2.2. Ruolo dei minerali
17.7.3. Miti e verità sulla nutrizione nella riproduzione assistita
17.7.4. Esempi di dieta
17.8. Il dolore nella riproduzione assistita
17.8.1. Concetto di lutto
17.8.2. Tipi di lutto nella riproduzione assistita:
17.8.2.1. Lutto per l'infertilità
17.8.2.2. Lutto per la perdita dell'invisibile
17.8.2.3. Lutto per perdita gestazionale
17.8.2.4. Lutti dovuti a impianti falliti
17.8.2.5. Lutto perinatale
17.8.3. Consulenza terapeutica per affrontare il lutto
17.8.4. Piano di assistenza nel processo di lutto
17.9. Fallimento della Riproduzione Assistita: nuove alternative
17.9.1. Adozioni
17.9.2. Famiglia senza figli
Una specializzazione completa che ti fornirà le conoscenze necessarie per competere con i migliori”
"
Master Specialistico in Assistenza Infermieristica nel Servizio di Ginecologia e Riproduzione Assistita
Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nei Paesi in via di sviluppo 1 coppia su 4 è affetta da problemi di infertilità. Tuttavia, questo non è più un ostacolo per diventare genitori. Grazie alla tecnologia di riproduzione assistita, oggi è possibile trattare questo problema. In questo contesto clinico, il lavoro degli infermieri è uno dei ruoli più fondamentali, in quanto sono responsabili di fornire un'assistenza completa durante l'intero processo terapeutico, compresa l'analisi diagnostica dei pazienti e il supporto in ogni fase. Forniscono inoltre assistenza tecnica nell'esecuzione di test, linee guida farmacologiche e coordinamento delle attività cliniche. Sei interessato a esplorare questo campo? Con TECH troverai il Master Specialistico In Assistenza Infermieristica nel Servizio di Ginecologia e Riproduzione Assistita, in cui studierai le tecniche e le azioni negli interventi correlati. Attraverso la guida di un team specializzato in medicina della fertilità e concezione assistita, apprenderai argomenti rilevanti come l'anatomia-fisiologia riproduttiva, la genetica e l'immunologia della riproduzione e lo studio dell'infertilità nella donna e nell'uomo.
Scopri il servizio di ginecologia e riproduzione assistita
L'infermiera Jean Marian Purdy gettò le basi di quella che sarebbe diventata la fecondazione artificiale trasferendo un embrione cresciuto in laboratorio in un utero. Oggi, questo esperimento rivoluzionario è un salvavita per molte persone con problemi di infertilità. I notevoli progressi scientifici e tecnologici in questo campo richiedono un aggiornamento delle conoscenze. Per questo motivo, in questo corso post-laurea online di TECH troverai le metodologie di apprendimento più innovative, integrate da materiale multimediale unico. Attraverso 18 moduli tematici, apprenderai l'endocrinologia riproduttiva, il ciclo ovarico-uterino, la procedura di congelamento dello sperma e i fattori immunologici che influenzano la riproduzione assistita. Scoprirai anche gli aspetti legali ed etici del settore, la gestione delle emergenze ginecologiche-ostetriche, le banche dei donatori e la farmacologia personalizzata. Infine, studierai le tecniche di fecondazione artificiale, l'approccio ai problemi ginecologici e il supporto psicologico in situazioni particolari. Al termine dei due anni di formazione, sarai in grado di trattare in sicurezza le pazienti affette da diverse patologie legate alla riproduzione.
"