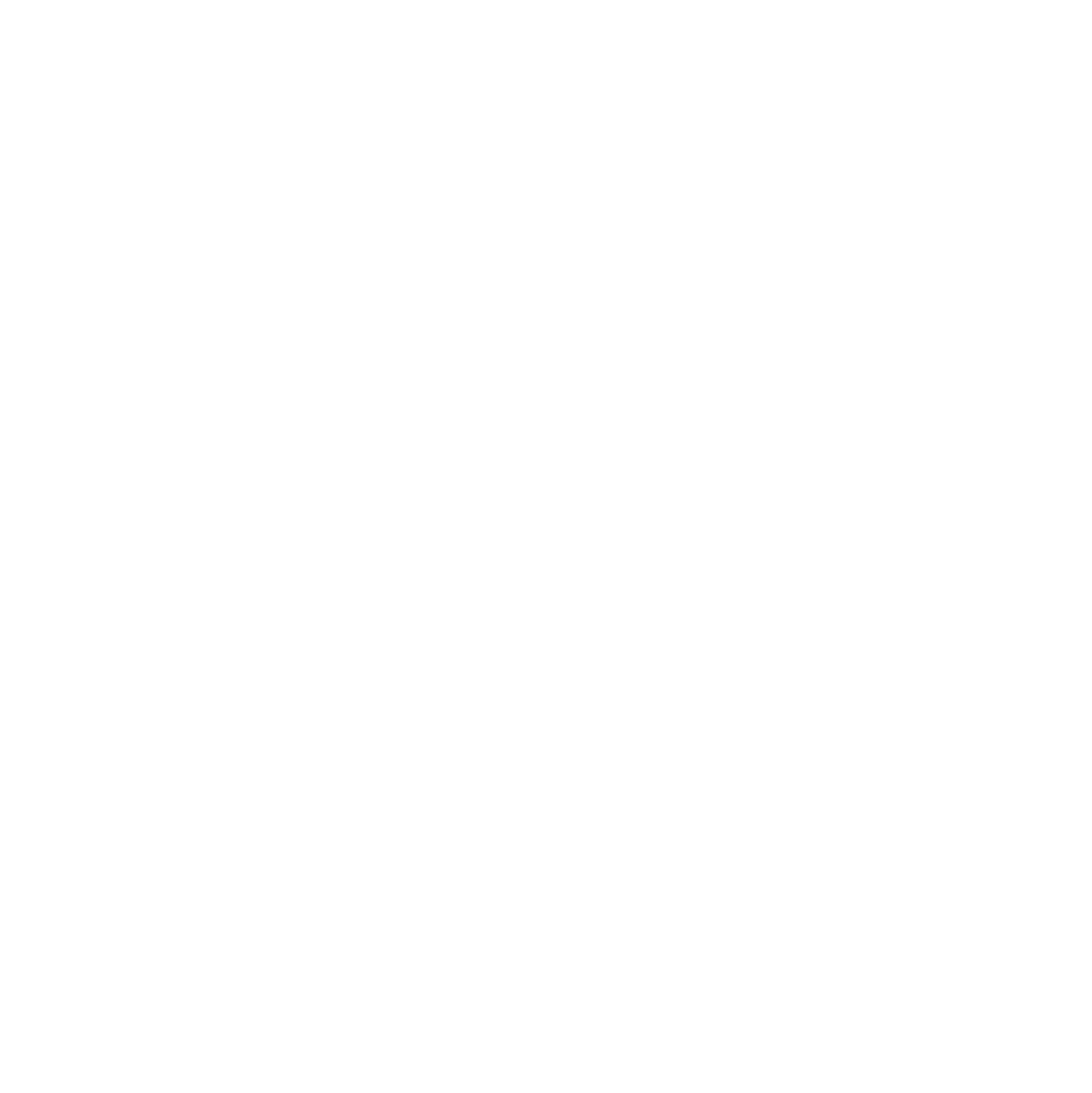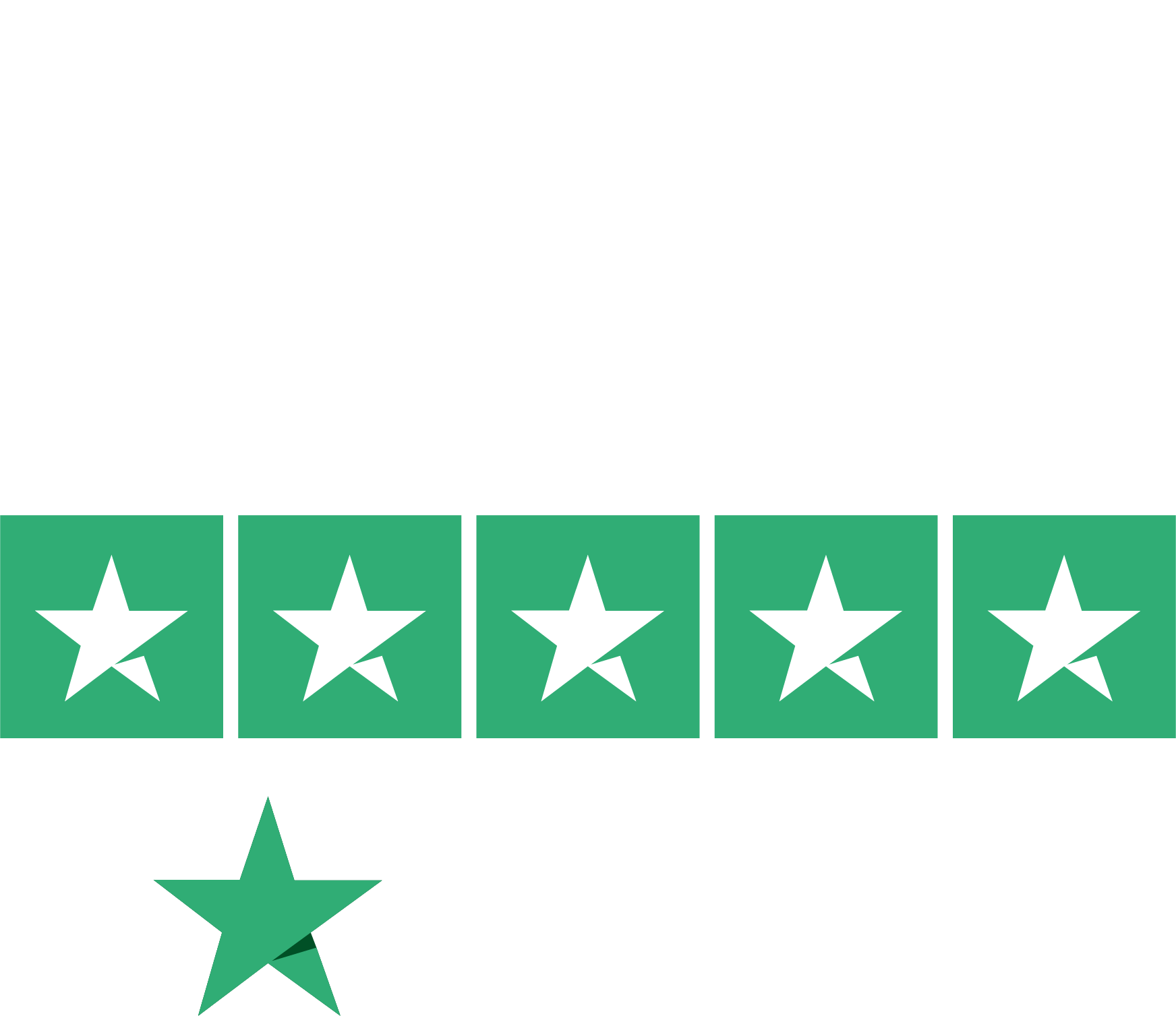Titolo universitario
La più grande facoltà di educazione del mondo"
Presentazione
Grazie a questa qualifica, imparerai a svolgere le migliori attività per garantire la riabilitazione uditiva del bambino a cui è stato impiantato un apparecchio acustico di recente"
L'acquisizione del linguaggio in età precoce può essere significativamente influenzata da una Disabilità Uditiva, dato che tale difficoltà costituisce un ostacolo significativo allo sviluppo cognitivo del bambino. Per tale ragione, negli ultimi anni sono nate nuove terapie volte a potenziare i residui uditivi utili e a favorire un processo di apprendimento che li ponga a un ritmo simile a quello degli altri coetanei nell'ambiente scolastico. Visti i vantaggi offerti da queste nuove metodologie nel migliorare la qualità della vita e dell'insegnamento, i professionisti del settore educativo sono tenuti a gestirne l'utilizzo per garantire il benessere dei bambini.
Pertanto, TECH ha creato il Corso universitario in Disabilità Uditiva, con il quale lo studente adotterà le competenze più aggiornate in questo campo per perfezionare l’approccio ai bambini che soffrono di diversi disturbi di questa natura. Durante 150 ore di apprendimento intensivo, lo studente gestirà gli strumenti di valutazione e di diagnosi più efficaci per individuare un possibile disturbo dell'udito e padroneggerà ciascuna delle fasi esistenti nell'intervento dello stesso. Allo stesso modo, acquisirà alcune nozioni di linguaggio dei segni per comunicare con i pazienti con una perdita uditiva molto elevata.
Questo programma accademico offre una modalità 100% online, che consentirà agli studenti di ottenere un apprendimento eccellente senza la necessità di recarsi in un centro di studi. Inoltre, l'accesso ai contenuti didattici in un'ampia varietà di formati testuali e multimediali garantirà un insegnamento personalizzato, comodo e adatto alle esigenze accademiche di ogni studente.
D’altra parte, questo titolo universitario beneficia della partecipazione accademica di un eminente esperto internazionale nel campo della Logopedia. Un rinomato specialista che conduce una vivace attività di ricerca e ha ottenuto risultati scientifici di rilevanza globale. Questo illustre Direttore Ospite è responsabile di una Master class esclusiva e innovativa.
Approfondirai le strategie per affrontare la Disabilità Uditiva grazie alla Master class senza pari proposta da questo programma"
Questo Corso universitario in Disabilità Uditiva possiede il programma educativo più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:
- Sviluppo di casi di studio presentati da esperti in Logopedia, specializzati nel trattamento del paziente affetto da un qualsiasi tipo di Disabilità Uditiva
- Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono eccellenti informazioni pratiche riguardo alle discipline mediche essenziali per l’esercizio della professione
- Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- Particolare enfasi sulle metodologie innovative
- Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o portatile provvisto di connessione a internet
Questo Corso universitario ti fornirà contenuti didattici realizzati da logopedisti che saranno pienamente applicabili nella tua professione"
Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti del settore e altre aree correlate, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente.
I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno
al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito
in un contesto reale.
La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato sui Problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.
Padroneggia i metodi più sofisticati di valutazione e diagnosi di una possibile ipoacusia grazie a questa specializzazione"
Beneficia di una modalità di insegnamento 100% online che ti permetterà di raggiungere un apprendimento efficace senza trascurare le tue attività quotidiane.
Programma
Il programma del Corso universitario in Disabilità Uditiva è stato progettato con l'obiettivo di fornire agli studenti i contenuti necessari per accrescere le proprie competenze logopediche nel campo della Disabilità Uditiva orientata all'ambiente scolastico. I materiali didattici che saranno disponibili per tutta la durata del programma saranno accessibili su supporti come i test di valutazione, i video esplicativi o le letture complementari. Grazie a ciò, lo studente potrà godere di un apprendimento efficace, supportato dalla comodità di studiare da casa che la modalità 100% online offre.
Accresci le tue conoscenze sulla Disabilità Uditiva senza dover affrontare scomodi spostamenti verso centri di studio”
Modulo 1. Comprendere la Disabilità Uditiva
1.1. Il sistema uditivo: basi anatomiche e funzionali
1.1.1. Introduzione all’unità
1.1.1.1. Considerazioni iniziali
1.1.1.2. Concetto di suono
1.1.1.3. Concetto di rumore
1.1.1.4. Concetto di onda sonora
1.1.2. L'orecchio esterno
1.1.2.1. Concetto e funzione dell'orecchio esterno
1.1.2.2. Parti dell'orecchio esterno
1.1.3. L'orecchio medio
1.1.3.1. Concetto e funzione dell'orecchio medio
1.1.3.2. Parti dell'orecchio medio
1.1.4. L'orecchio interno
1.1.4.1. Concetto e funzione dell'orecchio interno
1.1.4.2. Parti dell'orecchio interno
1.1.5. Fisiologia dell’udito
1.1.6. Come funziona l'udito naturale
1.1.6.1. Concetto di udito naturale
1.1.6.2. Meccanismo dell'udito senza disturbi
1.2. Ipoacusia
1.2.1. Ipoacusia
1.2.1.1. Concetto di ipoacusia
1.2.1.2. Sintomi della perdita dell'udito
1.2.2. Classificazione dell'ipoacusia in base alla localizzazione della lesione
1.2.2.1. Perdita dell'udito per trasmissione o conduzione
1.2.2.2. Perdite uditive percettive o neurosensoriali
1.2.3. Classificazione dell'ipoacusia in base al grado di perdita uditiva
1.2.3.1. Perdita dell'udito leggera o lieve
1.2.3.2. Ipoacusia media
1.2.3.3. Ipoacusia severa
1.2.3.4. Ipoacusia profonda
1.2.4. Classificazione dell'ipoacusia in base all'età di insorgenza
1.2.4.1. Ipoacusia pre-locutoria
1.2.4.2. Ipoacusia perlocutoria
1.2.4.3. Ipoacusia post-locutoria
1.2.5. Classificazione dell'ipoacusia in base alla sua eziologia
1.2.5.1. Perdita accidentale dell'udito
1.2.5.2. Perdita dell'udito dovuta al consumo di sostanze ototossiche
1.2.5.3. Ipoacusia di origine genetica
1.2.5.4. Altre cause possibili
1.2.6. Fattori di rischio per la perdita dell'udito
1.2.6.1. Invecchiamento
1.2.6.2. Rumori forti
1.2.6.3. Fattori ereditari
1.2.6.4. Sport ricreativi
1.2.6.5. Altro
1.2.7. Prevalenza della perdita uditiva
1.2.7.1. Considerazioni iniziali
1.2.7.2. Prevalenza della perdita uditiva nei vari Paesi
1.2.8. Comorbidità dell’ipoacusia
1.2.8.1. La comorbilità nell’ipoacusia
1.2.8.2. Disturbi associati
1.2.9. Confronto dell'intensità dei suoni più frequenti
1.2.9.1. Livelli sonori dei rumori frequenti
1.2.10. Prevenzione dell'udito
1.2.10.1. Considerazioni iniziali
1.2.10.2. L’importanza della prevenzione
1.2.10.3. Metodi preventivi per la cura dell'udito
1.3. Audiologia e audiometria
1.4. Apparecchi acustici
1.4.1. Considerazioni iniziali
1.4.2. Storia degli apparecchi acustici
1.4.3. Cosa sono gli apparecchi acustici?
1.4.3.1. Concetto di apparecchio acustico
1.4.3.2. Come funziona un apparecchio acustico
1.4.3.3. Descrizione del dispositivo
1.4.4. Applicazione di apparecchi acustici e requisiti di applicazione
1.4.4.1. Considerazioni iniziali
1.4.4.2. Requisiti per l'applicazione di apparecchi acustici
1.4.4.3. Come si applica un apparecchio acustico?
1.4.5. Quando è sconsigliato applicare un apparecchio acustico?
1.4.5.1. Considerazioni iniziali
1.4.5.2. Aspetti che influenzano la decisione finale del professionista
1.4.6. Il successo e il fallimento dell'applicazione di un apparecchio acustico
1.4.6.1. Fattori che influiscono sul successo dell'applicazione di un apparecchio acustico
1.4.6.2. Fattori che influenzano il fallimento dell'applicazione di un apparecchio acustico
1.4.7. Analisi delle prove di efficacia, sicurezza e aspetti etici degli apparecchi acustici
1.4.7.1. Efficacia degli apparecchi acustici
1.4.7.2. Sicurezza degli apparecchi acustici
1.4.7.3. Aspetti etici dell'apparecchio acustico
1.4.8. Indicazioni e controindicazioni degli apparecchi acustici
1.4.8.1. Considerazioni iniziali
1.4.8.2. Indicazioni per gli apparecchi acustici
1.4.8.3. Controindicazioni degli apparecchi acustici
1.4.9. Modelli attuali di apparecchi acustici
1.4.9.1. Introduzione
1.4.9.2. I diversi modelli di apparecchi acustici attuali
1.4.10. Conclusioni finali
1.5. Impianti cocleari
1.5.1. Introduzione all’unità
1.5.2. Storia dell'impianto cocleare
1.5.3. Cosa sono gli impianti cocleari?
1.5.3.1. Il concetto di impianto cocleare
1.5.3.2. Come funziona un impianto cocleare?
1.5.3.3. Descrizione del dispositivo
1.5.4. Requisiti per l'applicazione di un impianto cocleare
1.5.4.1. Considerazioni iniziali
1.5.4.2. Requisiti fisici che l'utente deve soddisfare
1.5.4.3. Requisiti psicologici che l'utente deve soddisfare
1.5.5. Applicazione di un impianto cocleare
1.5.5.1. L'intervento chirurgico
1.5.5.2. Programmazione dell'applicazione
1.5.5.3. I professionisti coinvolti nella chirurgia e nella programmazione degli impianti
1.5.6. Quando è sconsigliato applicare un impianto cocleare?
1.5.6.1. Considerazioni iniziali
1.5.6.2. Aspetti che influenzano la decisione finale del professionista
1.5.7. Successi e fallimenti dell'impianto cocleare
1.5.7.1. Fattori che influiscono sul successo dell'applicazione di un apparecchio cocleare
1.5.7.2. Fattori che influenzano il fallimento dell'applicazione di un apparecchio cocleare
1.5.8. Analisi delle prove di efficacia, sicurezza e aspetti etici degli impianti cocleari
1.5.8.1. L'efficacia dell'impianto cocleare
1.5.8.2. La sicurezza dell'impianto cocleare
1.5.8.3. Aspetti etici dell'impianto cocleare
1.5.9. Indicazioni e controindicazioni per l'impianto cocleare
1.5.9.1. Considerazioni iniziali
1.5.9.2. Indicazioni dell'impianto cocleare
1.5.9.3. Controindicazioni dell'impianto cocleare
1.5.10. Conclusioni finali
1.6. Strumenti di valutazione logopedica per i disturbi uditivi
1.6.1. Introduzione all’unità
1.6.2. Elementi da tenere presenti nella valutazione
1.6.2.1. Livello di attenzione
1.6.2.2. Imitazione
1.6.2.3. Percezione visiva
1.6.2.4. Modalità di comunicazione
1.6.2.5. Udito
1.6.2.5.1. Reazione a suoni inaspettati
1.6.2.5.2. Rilevamento del suono. Quali suoni si sentono?
1.6.2.5.3. Identificazione e riconoscimento dei suoni ambientali e linguistici
1.6.3. Audiometria e audiogramma
1.6.3.1. Considerazioni iniziali
1.6.3.2. Concetto di audiometria
1.6.3.3. Concetto di audiogramma
1.6.3.4. Il ruolo dell'audiometria e dell'audiogramma
1.6.4. Prima parte della valutazione: l'anamnesi
1.6.4.1. Sviluppo generale del paziente
1.6.4.2. Tipo e grado di perdita uditiva
1.6.4.3. Tempistica di insorgenza della perdita uditiva
1.6.4.4. Esistenza di patologie associate
1.6.4.5. Modalità di comunicazione
1.6.4.6. Uso o assenza di apparecchi acustici
1.6.4.6.1. Data di applicazione
1.6.4.6.2. Altri aspetti
1.6.5. Seconda parte della valutazione: otorinolaringoiatra e protesista
1.6.5.1. Considerazioni iniziali
1.6.5.2. Rapporto dell'otorinolaringoiatra
1.6.5.2.1. Analisi delle prove oggettive
1.6.5.2.2. Analisi delle prove soggettive
1.6.5.3. Rapporto del protesista
1.6.6. Seconda parte della valutazione: test standardizzati
1.6.6.1. Considerazioni iniziali
1.6.6.2. Audiometria vocale
1.6.6.2.1. Test di Ling
1.6.6.2.2. Test del nome
1.6.6.2.3. Test di percezione precoce della parola (ESP)
1.6.6.2.4. Test delle caratteristiche distintive
1.6.6.2.5. Test di identificazione delle vocali
1.6.6.2.6. Test di identificazione delle consonanti
1.6.6.2.7. Test di riconoscimento dei monosillabi
1.6.6.2.8. Test di riconoscimento dei bisillabi
1.6.6.2.9. Test di riconoscimento delle frasi
1.6.6.2.9.1. Test di frasi a scelta aperta con supporto
1.6.6.2.9.2. Test di frasi a scelta aperta non supportata
1.6.6.3. Test del linguaggio orale
1.6.6.3.1. PLON-R
1.6.6.3.2. Scala Reynell di sviluppo del linguaggio
1.6.6.3.3. ITPA
1.6.6.3.4. ELCE
1.6.6.3.5. Registro Fonologico Indotto da Monfort
1.6.6.3.6. MacArthur
1.6.6.3.7. Test dei concetti di base di Boehm
1.6.6.3.8. BLOC
1.6.7. Elementi da includere in una relazione logopedica sui disturbi dell'udito
1.6.7.1. Considerazioni iniziali
1.6.7.2. Elementi importanti e fondamentali
1.6.7.3. Importanza del rapporto del logopedista nella riabilitazione uditiva
1.6.8. Valutazione del bambino disartrico nel contesto scolastico
1.6.8.1. Professionisti da intervistare
1.6.8.1.1. Tutor
1.6.8.1.2. Personale docente
1.6.8.1.3. Maestro di ascolto e linguaggio
1.6.8.1.4. Altro
1.6.9. La diagnosi precoce
1.6.9.1. Considerazioni iniziali
1.6.9.2. L’importanza di unadiagnosi precoce
1.6.9.3. Perché la valutazione del linguaggio è più efficace quando il bambino è più piccolo?
1.6.10. Conclusioni finali
1.7. Ruolo del logopedista nell'intervento sulla perdita uditiva
1.7.1. Introduzione all’unità
1.7.1.1. Approcci metodologici, secondo la classificazione di Perier (1987)
1.7.1.2. Metodi orali monolingue
1.7.1.3. Metodi bilingue
1.7.1.4. Metodi misti
1.7.2. Ci sono differenze tra la riabilitazione dopo l'impianto di un apparecchio acustico e uno cocleare?
1.7.3. Intervento post-implantare nei bambini in fase di pre-locuzione
1.7.4. Intervento post-implantare nei bambini in fase di post-locuzione
1.7.4.1. Introduzione all’unità
1.7.4.2. Fasi della riabilitazione uditiva
1.7.4.2.1. Fase di rilevamento del suono
1.7.4.2.2. Fase di discriminazione
1.7.4.2.3. Fase di identificazione
1.7.4.2.4. Fase di riconoscimento
1.7.4.2.5. Fase di comprensione
1.7.5. Attività utili per la riabilitazione
1.7.5.1. Attività per la fase di rilevamento
1.7.5.2. Attività per la fase di discriminazione
1.7.5.3. Attività per la fase di identificazione
1.7.5.4. Attività per la fase di riconoscimento
1.7.5.5. Attività per la fase di comprensione
1.7.6. Ruolo della famiglia nel processo di riabilitazione
1.7.6.1. Linee guida per le famiglie
1.7.6.2. È consigliabile la presenza dei genitori alle sessioni?
1.7.7. L'importanza di un'équipe interdisciplinare durante l'intervento
1.7.7.1. Considerazioni iniziali
1.7.7.2. Perché il team interdisciplinare è importante
1.7.7.3. I professionisti coinvolti nella riabilitazione
1.7.8. Strategie per l'ambiente scolastico
1.7.8.1. Considerazioni iniziali
1.7.8.2. Strategie di comunicazione
1.7.8.3. Strategie metodologiche
1.7.8.4. Strategie di adattamento dei testi
1.7.9.Materiali e risorse adattati all'intervento logopedico in audiologia
1.7.9.1. Materiali e ausili di elaborazione propria
1.7.9.2. Materiali utili sul mercato
1.7.9.3. Risorse tecnologiche
1.7.10. Conclusioni finali
1.8.Comunicazione bimodale
1.8.1. Introduzione all’unità
1.8.2. Che cos'è la comunicazione bimodale?
1.8.2.1. Concetto
1.8.2.2. Funzioni
1.8.3. Elementi della comunicazione bimodale
1.8.3.1. Considerazioni iniziali
1.8.3.2. Gli elementi della comunicazione bimodale
1.8.3.2.1. Gesti pantomimici
1.8.3.2.2. Elementi della lingua dei segni
1.8.3.2.3. Gesti naturali
1.8.3.2.4. Gesti "idiosincratici"
1.8.3.2.5. Altri elementi
1.8.4. Obiettivi e vantaggi della comunicazione bimodale
1.8.4.1. Considerazioni iniziali
1.8.4.2. Vantaggi della comunicazione bimodale
1.8.4.2.1. Per quanto riguarda la parola nella ricezione
1.8.4.2.2. Per quanto riguarda la parola nell’espressione
1.8.4.3. Vantaggi della comunicazione bimodale rispetto ad altri sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa
1.8.5. Quando dovremmo considerare l'uso della comunicazione bimodale?
1.8.5.1. Considerazioni iniziali
1.8.5.2. Fattori da tenere presente
1.8.5.3. Professionisti che prendono la decisione
1.8.5.4. L'importanza del ruolo della famiglia
1.8.6. L'effetto facilitante della comunicazione bimodale
1.8.6.1. Considerazioni iniziali
1.8.6.2. L'effetto indiretto
1.8.6.3. L'effetto diretto
1.8.7. La comunicazione bimodale nelle diverse aree linguistiche
1.8.7.1. Considerazioni iniziali
1.8.7.2. Comunicazione bimodale e comprensione
1.8.7.3. Comunicazione bimodale ed espressione
1.8.8. Forme di implementazione della comunicazione bimodale
1.8.9. Programmi finalizzati all'apprendimento e all'implementazione del sistema bimodale
1.8.9.1. Considerazioni iniziali
1.8.9.2. Introduzione alla comunicazione bimodale supportata dagli strumenti di autore CLIC e NEOBOOK
1.8.9.3. Bimodal 2000
1.8.10. Conclusioni finali
1.10. La figura dell'Interprete della Lingua dei Segni
1.10.1. Introduzione all’unità
1.10.2. Storia dell'interpretazione
1.10.2.1. Storia dell'interpretariato di lingue orali
1.10.2.2. Storia dell'interpretariato di lingue dei segni
1.10.2.3. L'interpretazione della lingua dei segni come professione
1.10.3. L’Interprete della Lingua dei Segni
1.10.3.1. Concetto
1.10.3.2. Profilo del professionista di Lingua dei Segni
1.10.3.2.1. Caratteristiche personali
1.10.3.2.2. Caratteristiche intellettuali
1.10.3.2.3. Caratteristiche etiche
1.10.3.2.4. Conoscenze generali
1.10.3.3. La funzione indispensabile dell'Interprete della Lingua dei Segni
1.10.3.4. Professionalità nell'interpretazione
1.10.4. Metodi di interpretazione
1.10.4.1. Caratteristiche dell'interpretazione
1.10.4.2. Lo scopo dell'interpretazione
1.10.4.3. L'interpretazione come interazione comunicativa e culturale
1.10.4.4. Tipi di interpretazione
1.10.4.4.1. Interpretazione consecutiva
1.10.4.4.2. Interpretazione simultanea
1.10.4.4.3. Interpretariato in una telefonata
1.10.4.4.4. Interpretare testi scritti
1.10.5. Componenti del processo di interpretazione
1.10.5.1. Messaggio
1.10.5.2. Percezione
1.10.5.3. Sistemi di collegamento
1.10.5.4. Comprensione
1.10.5.5. Interpretazione
1.10.5.6. Valutazione
1.10.5.7. Risorse umane coinvolte
1.10.6. Relazioni degli elementi dei meccanismi di interpretazione
1.10.6.1. Il modello ipotetico di interpretazione simultanea di Moser
1.10.6.2. Il modello del lavoro di interpretazione di Colonomos
1.10.6.3. Il modello del processo di interpretazione di Cokely
1.10.7. Tecniche di interpretazione
1.10.7.1. Concentrazione e attenzione
1.10.7.2. Memoria
1.10.7.3. Prendere appunti
1.10.7.4. Fluidità verbale e agilità mentale
1.10.7.5. Risorse per la costruzione del lessico
1.10.8. Campi d'azione della Lingua dei Segni
1.10.8.1. Servizi in generale
1.10.8.2. Servizi specifici
1.10.8.3. Organizzazione di servizi di Lingua dei Segni nei Paesi europei
1.10.9. Standard etici
1.10.9.1. Il codice etico della Lingua dei Segni
1.10.9.2. Principi fondamentali
1.10.9.3. Altri principi etici
1.10.10. Associazioni degli Interpreti di Lingua dei Segni
1.10.10.2. Associazioni di Lingua dei Segni in Europa
1.10.10.3. Associazioni di Lingua dei Segni nel resto del mondo
Un’esperienza di specializzazione unica e decisiva per crescere a livello professionale"
Corso Universitario in Disabilità Uditiva
Gli ultimi progressi della tecnologia aumentativa in medicina e logopedia stanno dando una svolta importante a nuovi approcci metodologici legati all'intervento nei disturbi percettivi, come la perdita dell'udito, che sono disturbi con un'incidenza significativa nella popolazione scolastica, grazie a programmi educativi inclusione. Conoscere quali sono i bisogni educativi specifici e specifici che derivano dalla perdita dell'udito, come individuarli, valutare i sistemi di supporto più adattivi e progettare un intervento personalizzato e diretto, insieme all'intervento socio-familiare, sono tutti aspetti fondamentali per qualsiasi rieducazione processo logopedia. Ecco perché TECH Università Tecnologica lancia il suo Corso Universitario in Disabilità Uditiva, è un'ottima opportunità per coloro che sono interessati al settore della salute e dell'istruzione e vogliono specializzarsi nella cura delle persone con disabilità uditive. Questo programma accademico è progettato per offrire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le caratteristiche del deficit uditivo e il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone colpite. Attraverso questo corso gli studenti avranno l'opportunità di conoscere le tecniche di prevenzione, diagnosi e trattamento dei problemi uditivi.
Scopri molto di più sui problemi di udito online
Gli studenti apprenderanno inoltre gli strumenti e le procedure necessari per diagnosticare i disturbi dell'udito e le diverse opzioni di trattamento disponibili. Allo stesso modo, approfondisce le terapie riabilitative, l'utilizzo di apparecchi acustici e gli ausili tecnici per le persone con disabilità uditiva. Infine, il corso affronta le competenze specifiche necessarie per lavorare con le persone con disabilità uditive, comprese le tecniche di comunicazione efficaci e l'importanza dell'uso del linguaggio dei segni. Questo programma accademico è offerto online e gli studenti avranno accesso a contenuti online e strumenti didattici. Al termine del corso, gli studenti riceveranno una qualifica universitaria in Disabilità Uditiva, che consentirà loro di essere riconosciuti come professionisti formati nel settore.